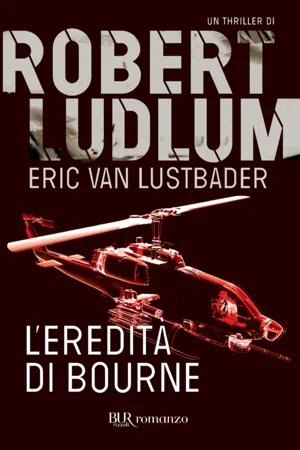![]()
L’eredità di Bourne
In memoria di Bob
![]()
Prologo
Khalid Murat, leader dei ribelli ceceni, era seduto immobile come una statua a bordo del veicolo di centro del piccolo convoglio che stava percorrendo le vie bombardate di Grozny. I tre blindati da trasporto truppe BTR-60BP erano mezzi militari di serie, di fabbricazione russa, che rendevano il convoglio indistinguibile da tutti gli altri mezzi pesanti che rombavano ovunque in città in perenne servizio di pattuglia. Gli uomini di Murat, armati fino ai denti, erano stipati a bordo degli altri due veicoli, davanti e dietro il suo blindato. Erano diretti all’Ospedale n. 9, uno dei sei o sette diversi nascondigli che Murat utilizzava per anticipare le mosse e tenersi previdentemente alla larga dalle forze russe che lo ricercavano.
Murat aveva una folta barba nera, era prossimo ai cinquanta, con un fisico da orso bruno e lo sguardo fiammeggiante dell’autentico patriota. Aveva dovuto imparare fin troppo presto che il pugno di ferro era l’unico modo per governare. Era stato presente quando Jokhar Dudayev aveva imposto la legge islamica della Shari‘a senza successo. Era stato testimone delle stragi avvenute in seguito, quando tutto era cominciato, quando i signori della guerra stranieri con basi in Cecenia, alleati di Osama bin Laden, avevano invaso il Dagestan e messo a segno una serie di attentati dinamitardi a Mosca e a Volgodonsk, mietendo circa duecento vittime tra la popolazione civile. Quando l’infamante responsabilità delle azioni dei terroristi stranieri era stata falsamente attribuita agli insorti ceceni, i russi avevano dato il via ai loro devastanti bombardamenti di Grozny, riducendo in macerie gran parte della città.
Il cielo sopra la capitale cecena era completamente offuscato da una nube persistente di cenere e caligine, un’incandescenza luccicante talmente vivida da sembrare quasi radioattiva. Fuochi e incendi alimentati da petrolio e gasolio ardevano ovunque nello squallore del paesaggio disseminato di rovine, macerie e calcinacci.
Khalid Murat guardò fuori dai finestrini scuri del blindato mentre il convoglio passava davanti allo scheletro carbonizzato di un edificio imponente, massiccio, scoperchiato, con l’interno invaso da focolai di incendi e alte fiamme guizzanti. Si lasciò sfuggire un’imprecazione, poi, voltandosi verso Hasan Arsenov, il suo secondo, disse: «Un tempo Grozny era una città accogliente dove gli innamorati passeggiavano in ampi viali fiancheggiati dai cipressi e le madri spingevano carrozzine in piazze ombreggiate da alberi frondosi. Il circo a tre piste ogni sera era affollato di volti gai e sorridenti, e architetti di fama internazionale venivano qui in pellegrinaggio da tutto il mondo per una visita guidata degli splendidi palazzi che facevano di Grozny una delle città più belle della terra».
Murat scosse sconsolatamente il capo e batté la mano sul ginocchio del compagno in un gesto cameratesco. «Allah, Hasan!» disse ad alta voce. «Adesso guarda come i russi hanno distrutto tutto ciò che un tempo era utile e buono!»
Hasan Arsenov annuì. Era un uomo brusco, energico, di almeno dieci anni più giovane di Murat. Ex campione di biathlon, aveva le spalle larghe e i fianchi stretti dell’atleta nato. Quando Murat aveva assunto il comando come leader dei ribelli, Arsenov era al suo fianco. Indicò a Murat le rovine fuligginose di una massiccia costruzione a destra del convoglio. «Prima dei conflitti armati» dichiarò in tono solenne, «quando Grozny era ancora uno dei principali centri di produzione e raffinazione petrolifera, mio padre lavorava là, all’Istituto Petrolchimico. Ora, invece dei profitti derivanti dai nostri pozzi di trivellazione, abbiamo roghi e incendi che inquinano la nostra aria e la nostra acqua.»
I due ribelli furono indotti al silenzio dalla parata di edifici bombardati davanti ai quali stavano transitando, di vie deserte, percorse soltanto da rari animali ed esseri umani alla ricerca di carogne o rifiuti. Dopo diversi minuti di silenziosa e lugubre contemplazione, si rivolsero lo sguardo contemporaneamente, con negli occhi il dolore per le sofferenze della loro gente. Murat socchiuse le labbra per dire qualcosa, ma restò muto e paralizzato all’inconfondibile rumore di proiettili che a un tratto rimbalzarono sul loro blindato. Gli ci volle solo un istante per rendersi conto che il veicolo era stato bersagliato da armi di piccolo calibro, assolutamente inefficaci per penetrare la massiccia corazzatura del blindato da trasporto truppe. Arsenov, sempre vigile, allungò la mano verso la radio di bordo.
«Ordino alle guardie nei veicoli di testa e di coda di rispondere al fuoco.»
Murat scosse il capo. «No, Hasan. Rifletti. Siamo camuffati con uniformi militari dell’esercito russo e viaggiamo a bordo di automezzi blindati russi. È più probabile che chi ci sta bersagliando sia un nostro alleato piuttosto che un nemico. Dobbiamo accertarcene prima di macchiarci di sangue innocente.»
Murat sottrasse il ricevitore dalle mani di Arsenov e ordinò al convoglio di fermarsi.
«Tenente Gochiyayev» disse nella radio, «organizzi i suoi uomini ed effettui una rapida ricognizione. Voglio scoprire chi ci ha preso di mira, ma evitate di aprire il fuoco.»
Nel veicolo di testa, il tenente Gochiyayev radunò i suoi sottoposti e ordinò loro di sparpagliarsi a ventaglio all’aperto, tenendosi al coperto dei tre blindati. Poi li seguì nella strada disseminata di macerie, incurvando le spalle contro il freddo pungente. Ricorrendo a dei precisi segnali manuali, diresse i suoi uomini in modo che convergessero da sinistra e da destra verso il punto da cui erano partiti i colpi.
I suoi uomini erano tutti bene addestrati; avanzavano rapidi e silenziosi da un masso a un muro a un cumulo di putrelle d’acciaio ritorte, tenendosi bassi e accovacciandosi quando erano allo scoperto, così da diventare un difficile bersaglio. Però non risuonarono altri spari. Effettuarono la corsa finale all’improvviso e contemporaneamente, con una manovra a tenaglia in grado di intrappolare gli avversari e annientarli in un micidiale fuoco incrociato.
Nel veicolo di centro Hasan Arsenov tenne gli occhi fissi sul punto in cui Gochiyayev aveva fatto convergere i soldati, aspettandosi una scarica di raffiche che non venne mai. Spuntò invece il tenente Gochiyayev, che fece capolino con la testa sopra i resti di un muro poco lontano. Rivolgendosi verso il blindato di centro agitò il braccio a semicerchio, da destra a sinistra, segnalando che la zona era stata resa sicura. A quel segnale Khalid Murat oltrepassò Arsenov, scese dal blindato e si diresse verso i suoi uomini attraversando con passo sicuro le macerie coperte di brina.
«Khalid Murat!» esclamò Arsenov allarmato, rincorrendo il suo comandante.
Imperturbabile, Murat camminò verso i resti di un muro di pietre semidistrutto, il punto da cui erano partiti i colpi di arma da fuoco. Con la coda dell’occhio notò i mucchi di rifiuti e di detriti; su uno di essi era steso il cadavere cereo di un uomo dalla pelle bianca, che era stato completamente spogliato. Perfino a distanza il fetore di carne in putrefazione colpiva le narici con violenza. Arsenov raggiunse il suo capo ed estrasse la pistola dalla fondina.
Quando Murat giunse ai resti del muro sbreccato, i suoi uomini circondavano il nido dei cecchini con le armi puntate. Il vento soffiava a raffiche irregolari, ululando e fischiando tra le rovine. Il cielo di un opaco color grigio ferro si era ulteriormente oscurato e aveva cominciato a nevicare. Una leggera spolveratura aderì rapidamente agli stivali di Murat in uno strato sottile, e creò una sorta di ragnatela bianca tra i peli ispidi della sua folta barba.
«Tenente Gochiyayev, avete trovato gli attentatori?»
«Sì, signore.»
«Allah mi ha guidato in ogni cosa. Mi guida anche in questo. Fatemeli vedere.»
«Ce n’è solo uno» ribatté Gochiyayev.
«Uno?» esclamò Arsenov. «Chi è? Sapeva che siamo ceceni?»
«Siete ceceni?» domandò una vocina e un volto pallido spuntò da dietro il muro. Era un ragazzino che non doveva avere più di dieci anni. Indossava un berretto di lana lercio, un vecchio maglione ridotto alla trama sopra due o tre camicie di flanella a quadri, un paio di pantaloni rappezzati in più punti e un paio di stivali di gomma mezzi rotti, di gran lunga troppo grandi per i suoi piedi, che probabilmente erano stati sottratti a un cadavere. Sebbene fosse solo un bambino, aveva gli occhi di un adulto; osservavano tutto con un’espressione a metà tra l’avvedutezza e la diffidenza. Stava in piedi in atteggiamento difensivo davanti al rottame di un razzo russo inesploso che aveva estratto dalle macerie e da cui avrebbe ricavato qualche soldo per comprare un po’ di pane al mercato nero; verosimilmente quel piccolo tesoro era tutto ciò che si frapponeva tra la sua famiglia e la fame. Impugnava una pistola con la mano sinistra; al posto della destra c’era solo un moncherino. Murat distolse immediatamente lo sguardo, ma Arsenov continuò a fissare il bambino.
«Una mina» spiegò quello con straziante praticità. «Lasciata dalla feccia russa.»
«Sia lode ad Allah! Che piccolo soldatino!» esclamò Murat, rivolgendo al bambino un sorriso abbagliante. Era quel sorriso accattivante e disarmante che gli aveva attirato le simpatie del suo popolo come il ferro a una calamita. «Vieni, vieni.» Chiamò a sé il ragazzino con un cenno insistente, poi rivolse le palme delle mani all’insù. «Come vedi, siamo ceceni, come te.»
«Se siete come me» obiettò lui, «perché viaggiate a bordo di blindati russi?»
«Conosci un modo migliore per nascondersi al lupo russo?» Murat socchiuse gli occhi per mettere a fuoco meglio e rise notando che il bambino impugnava una Gyurza. «Vedo che sei armato con una pistola delle Forze Speciali russe. Un’audacia del genere va assolutamente premiata, giusto?»
Murat si abbassò sulle ginocchia accanto al bambino e gli chiese come si chiamava. Dopo che il ragazzino gli ebbe detto il suo nome continuò: «Aznor, sai chi sono? Sono Khalid Murat e anch’io come te desidero essere libero dal giogo russo. Insieme ci riusciremo, vero?».
«Non volevo sparare a dei compagni ceceni» disse Aznor. Con il braccio mutilato indicò il convoglio. «Pensavo che fosse in corso una zachistka.» Intendeva una delle mostruose operazioni di rastrellamento perpetrate dai soldati russi a caccia di sospetti ribelli. Più di dodicimila ceceni erano stati uccisi durante queste zachistka; duemila erano semplicemente scomparsi, innumerevoli altri feriti, torturati, mutilati e stuprati. «I russi hanno assassinato mio padre e i miei zii. Se foste stati russi vi avrei uccisi tutti.» Uno spasmo di rabbia e di frustrazione gli contrasse i tratti del viso.
«Ne sono sicuro» commentò solennemente Murat. Si frugò in tasca ed estrasse qualche banconota. Il bambino fu costretto a infilare la pistola nella cintura dei pantaloni per prenderle con l’unica mano che gli restava. Piegandosi verso il ragazzino Murat bisbigliò in tono confidenziale: «Adesso stammi bene a sentire: ti dirò dove comprare altre munizioni per la tua Gyurza, così sarai in grado di difenderti alla prossima zachistka».
«Grazie.» Sul viso di Aznor si fece strada un sorriso.
Khalid Murat gli sussurrò poche parole, poi si ritrasse e lo accarezzò affettuosamente sulla testa. «Che Allah sia con te, soldatino, in tutto quel che fai.»
Il leader ceceno e il suo vicecomandante osservarono il ragazzino allontanarsi arrampicandosi sui mucchi di macerie e detriti, con i pezzi del razzo russo inesploso stretti sotto il braccio con il moncherino. Poi tornarono al loro veicolo. Con un brontolio di disgusto Hasan chiuse il portello corazzato del mezzo blindato, escludendo il mondo esterno, il mondo di Aznor. «Non ti disturba il fatto di mandare un bambino incontro alla morte?»
Murat gli lanciò un’occhiata. La neve si era sciolta in goccioline tremolanti sulla sua barba, facendolo assomigliare agli occhi di Arsenov più a un imam che a un comandante militare. «Ho appena dato a quel “bambino” – che deve nutrire, vestire e, cosa più importante, proteggere quel che gli resta della sua famiglia come se fosse un adulto – speranza, prima di tutto, e poi un obiettivo specifico. In breve, gli ho fornito quella che si può definire “una ragione per vivere”.»
L’amarezza aveva impallidito e indurito l’espressione di Arsenov; i suoi occhi avevano una luce minacciosa. «I proiettili russi lo faranno a brandelli.»
«Ne sei veramente convinto, Hasan? Che Aznor sia stupido o, peggio, incauto?»
«È soltanto un bambino.»
«Quando il seme è piantato, il germoglio nasce e si sviluppa anche dal terreno più inospitale. È sempre stato così, Hasan. La fede e il coraggio di un individuo inevitabilmente crescono e si diffondono, e ben presto da quel solo individuo ne nascono dieci, venti, cento, mille come lui!»
«E nel frattempo il nostro popolo continua a essere ucciso, violentato, percosso, affamato e rinchiuso come bestiame. Non è abbastanza, Khalid. Non basta neppure lontanamente!»
«L’impazienza giovanile non ti ha ancora abbandonato, Hasan.» Murat strinse la spalla del compagno. «Be’, in fondo non dovrei stupirmene.»
Arsenov, cogliendo il turbamento negli occhi di Murat, serrò la mandibola e rivolse lo sguardo altrove. Le folate di vento furioso sollevavano la neve lungo la via, turbinando come dervisci ceceni in trance estatica. Murat interpretò quella visione come un segno dell’importanza di ciò che aveva appena fatto, e di ciò che stava per dire. «Abbi fede» concluse in un sussurro ispirato. «In Allah e in quel bambino coraggioso.»
Dieci minuti dopo il convoglio si fermò davanti all’Ospedale n. 9. Arsenov guardò l’orologio. «È quasi ora» disse. Lui e Murat viaggiavano sullo stesso veicolo, contrariamente alle norme di sicurezza più elementari, a causa dell’estrema importanza della chiamata che stavano per ricevere.
Murat si sporse in avanti, premette un pulsante e la lastra di vetro fonoassorbente si alzò, isolandoli acusticamente dal conducente e dalle quattro guardie del corpo sedute davanti. Come sapevano di dover fare, gli uomini tennero lo sguardo rivolto in avanti, oltre il parabrezza antiproiettile.
«Dimmi, Khalid, visto che il momento della verità è sospeso su di noi, quali sono i tuoi dubbi.»
Murat inarcò le ispide sopracciglia come se non capisse. «Dubbi?»
«Non vuoi quello che ci appartiene di diritto, Khalid, ciò che Allah ha decretato come nostro?»
«Il sangue ti va in fretta alla testa, amico mio. Lo so fin troppo bene. Abbiamo combattuto fianco a fianco molte volte. Abbiamo ucciso insieme e ci siamo salvati la vita a vicenda più di una volta. Adesso stammi bene a sentire. Soffro e sanguino per il nostro popolo. Le sue pene mi riempiono di una rabbia che trattengo a stento. Tu questo lo sai forse meglio di chiunque altro. Ma la storia ci insegna che ci si deve guardare da ciò che si desidera maggiormente. Le conseguenze di quel che è stato proposto…»
«Quel che abbiamo pianificato!»
«Sì, pianificato» ripeté Murat. «Comunque sia, le conseguenze vanno prese seriamente in considerazione.»
«Prudenza» disse Arsenov in tono pungente. «Sempre prudenza!»
«Amico mio.» Khalid Murat sorrise stringendo ancora una volta la spalla al compagno. «Non voglio essere tratto in inganno. Il nemico incauto è più facile da annientare. Devi imparare a fare della pazienza una virtù.»
«Pazienza!» sbottò Arsenov. «Però non hai detto a quel bambino di essere paziente. Gli hai dato del denaro, gli hai rivelato dove comprarsi delle munizioni. Lo hai istigato contro i russi. Ogni giorno in più che ritardiamo è un altro giorno in cui quel bambino e migliaia di altre persone rischiano di essere uccisi. È il futuro stesso della Cecenia che dipende dalla nostra scelta, a questo punto.»
Murat si massaggiò gli occhi con i pollici, con un lento movimento circolare. «Ci sono altri modi, Hasan. Ci sono sempre altri modi. Forse dovremmo considerare…»
«Non c’è più tempo. L’annuncio è stato fatto, la data stabilita. Lo Shaykh ha ragione.»
«Già, lo Shaykh.» Khalid Murat scosse sconsolatamente la testa. «Sempre lo Shaykh!»
In quell’istante il radiotelefono di bordo squillò. Khalid rivolse un’occhiata d’intesa al compagno e con calma premette il pulsante di risposta in modalità vivavoce. «Sì, Shaykh» disse in tono deferente. «Hasan e io siamo entrambi presenti. Attendiamo sue istruzioni.»
In una posizione strategica sovrastante la via in cui il convoglio era fermo in attesa, una figura era accovacciata su un tetto a terrazza, con i gomiti appoggiati sul basso parapetto di protezione. A portata di mano un Sako TRG-41, un fucile di altissima precisione a caricamento manuale, di fabbricazione finlandese, uno dei tanti che l’uomo aveva modificato con le sue stesse mani. Il calcio in alluminio e poliuretano rendeva l’arma tanto leggera quanto mortalmente precisa. L’uomo indossava l’uniforme mimetica dell’esercito russo, il che non stonava affatto con i suoi tratti asiatici. Sopra l’uniforme portava un’imbracatura leggera ...