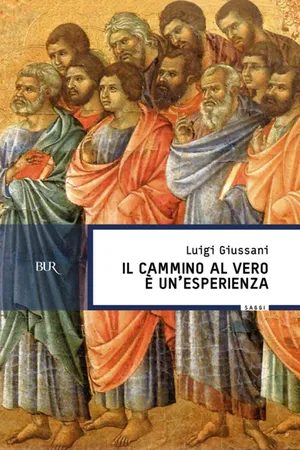PREMESSA ALLA PRIMA EDIZIONE
Questo libretto è nato nell’estate 1959 da discussioni fra giovani impegnati in Gioventù Studentesca e propone un primo appunto di sistematica riflessione sull’esperienza intensamente vissuta in questi ultimi anni.
La preoccupazione più acuta alle origini del movimento era stata allora – come continua ad essere – quella che il richiamo cristiano arrivasse a tutti. Così queste riflessioni riflettono la persuasione di avere intravista una strada esatta e sono offerte non solo agli studenti di GS, ma anche agli altri.
La stesura – anche per come è nata – vuol introdurre più che concludere: è quindi consapevolmente provvisoria. La prima parte è costituita da spunti che solo la meditazione paziente saprà scoprire nel loro eventuale valore; la seconda parte invece è la descrizione di un’esperienza che solo una attenzione amica può comprendere.
È per noi un dovere gratissimo ringraziare Sua Eminenza il cardinal Montini, Sua Eccellenza monsignor Pignedoli e l’Azione Cattolica diocesana, che non solo permettono, ma sostengono la nostra ricerca.
Milano, settembre 1959
DIRETTIVE METODOLOGICHE
PER IL RICHIAMO
Il richiamo cristiano deve essere:
– Deciso come gesto
– Elementare nella comunicazione
Condizioni per essere elementari: libertà, azione, concretezza
– Integrale nelle dimensioni
Dimensioni del richiamo cristiano: cultura, carità, cattolicità
– Comunitario nella realizzazione
Fattori della comunità: adesione personale, funzionalità, autorità, unità sensibile.
DECISO COME GESTO
1. La prima condizione per raggiungere tutti è una iniziativa chiara di fronte a chiunque.
2. Può essere illusione ambiguamente coltivata quella di introdursi nell’ambiente o di proporsi alle persone con una indecisione tale da sminuire il richiamo, nel timore che il suo urto contro la mentalità corrente indisponga gli altri verso di noi, e crei insormontabili incomprensioni e solitudini.
Si possono così cercare, magari con ansiosa scaltrezza, accomodamenti e camuffamenti che rischiano troppo facilmente di rappresentare dei compromessi dai quali è poi assai arduo liberarsi.
3. Non dobbiamo dimenticarci che questa «mentalità corrente» non esiste solo al di fuori di noi, ma ci permea fin nel profondo. Per cui l’indecisione nell’affrontarla può costituire una posizione rovinosa per noi stessi.
4. Per essere onesti, a un certo momento occorre porsi di fronte ai problemi seri, non solo nell’ambito interiore della propria coscienza, ma anche nel dialogo con gli altri.
5. Per questo occorre la forza di mettersi contro, che è quanto Cristo ci ha chiesto per farci entrare nel regno: «Chi avrà avuto vergogna di me di fronte agli uomini, anch’io avrò vergogna di lui di fronte al Padre mio».
6. Forza, cioè coraggio (virtus, in latino): in fondo ciò che occorre è un po’ di quella virtù con cui Matteo, Zaccheo e la Maddalena affermarono la loro scoperta cristiana di fronte all’ambiente in cui erano immersi.
O, se si vuole, ciò che occorre è rinnovare la testimonianza di Stefano di fronte al Sinedrio: sfidare l’opinione di tutti per seguire Gesù.
ELEMENTARE NELLA COMUNICAZIONE
1. È attraverso noi che Cristo si ripropone agli uomini; sono il nostro atteggiamento e la nostra parola che costituiscono il richiamo attraverso cui gli altri possono conoscerlo.
Perché tale richiamo possa essere rivolto a tutti, deve essere elementare nella comunicazione, cioè semplice.
2. La semplicità consiste non tanto in un modo di esporre, ché questo può essere capacità non comune, quanto nel prescindere da ogni complicazione, cioè nell’essere essenziali.
3. Anche il richiamo di Cristo alle origini fu semplice ed essenziale: infatti ha proposto obbligatoriamente solo verità precise (i dogmi), i gesti sacramentali e l’autorità nella comunità.
Così la Chiesa è discretissima nel fissare i punti obbligatori.
4. È facile comprendere la bontà di questo comportamento di Cristo e della Chiesa. Solo la semplicità, infatti, ha la duttilità per un riferimento a ogni singolo. E solo l’essenzialità ha la capacità di far arrivare allo scopo, eliminando fatiche non necessarie.
La precisione nell’individuare i fattori essenziali dell’esistenza porta:
a) a una forte sottolineatura del loro valore, e quindi a un forte attaccamento a essi;
b) a una larga comprensione per tutte le posizioni sopraggiunte, a una capacità di valorizzare e abbracciare infinite varietà di traduzioni del valore.
5. C’è una osservazione da meditare. «Elementare» non vuol dire «generico», ma piuttosto preciso negli elementi sostanziali e libero di fronte a qualsiasi traduzione.
Gesù disse: «Andate nel mondo universo e predicate a tutte le genti». Ognuno ha la responsabilità di un compito ben preciso: «Andate e predicate», ma è liberissimo di scegliere il modo, nell’ambito della sua particolare vocazione.
Vediamo ora le condizioni per essere elementari. Esse sono:
– Libertà
– Azione
– Concretezza.
Libertà
1. È alla persona singola e inconfondibile che il richiamo cristiano si rivolge. Più precisamente, è alla sua libertà che esso si propone.
2. Quando Dio si rivolge all’uomo per chiedergli qualcosa, la Bibbia con sublime semplicità descrive il dialogo. Dio chiama per nome – che è il segno della persona, come individuo unico e libero –; e l’uomo dà un’adesione libera e unica: «Eccomi».
Nel cristianesimo interessa solo il valore della persona, perché tutto il resto ne dipende. Ora, tutto il valore della persona è misurato da quella adesione libera.
I punti della storia in cui questo è più evidente sono le figure di Abramo e di Cristo. Ma il momento forse più facilmente chiaro per noi è la figura della Madonna. «Ave, Maria…» «Fiat»: nell’impenetrabile intimità libera di questo gesto di offerta e di accettazione sta la chiave di volta per il misterioso incontro di Dio con l’uomo.
3. Il nostro richiamo deve essere esclusivamente una eco di quella «Voce che chiama ognuno per nome».
Esso perciò deve voler andare diritto alla libertà di coloro cui si rivolge. E questo implica un’accanita esigenza di suscitare la loro consapevolezza e di provocare la loro iniziativa.
Ignoranza e passività sono limiti alla libertà: guai calcolare su di esse per «prendere» o «tenere» la gente! Ogni adesione al cristianesimo, in quanto ha di puramente meccanico, non possiede valore.
Perciò guardiamo con molta perplessità ogni attaccamento puramente tradizionale e ogni improvvisato entusiasmo.
L’ambiente proprio della libertà è la convinzione, illuminata e volitiva.
4. Per rivolgerci genuinamente alla libertà altrui, occorre agire in libertà noi. Solo l’impegno della mia persona può raggiungere la persona dell’altro; il richiamo cristiano esiste nella misura in cui l’incontro seriamente io. Comunicare il cristianesimo è quindi incontro di due libertà, è riferimento di una persona a un’altra persona.
È cioè amore: «Ci ha eletti in Lui... per amore».
Ogni atteggiamento generico non serve a nulla, ed è negligenza o presunzione.
5. Rivolgersi alla libertà altrui, abbiamo detto, significa sollecitare a una consapevole iniziativa. Tale iniziativa può essere vissuta in gradazioni indefinite: cioè la risposta può essere...