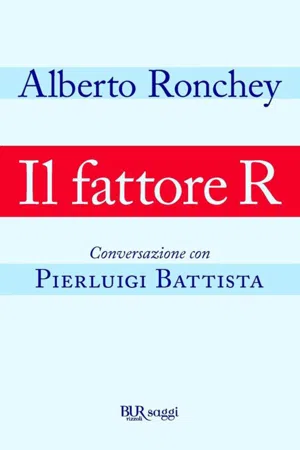![]()
OUVERTURE.
KARENINA E IL TRENO
PIERLUIGI BATTISTA Tu lavori, se non sbaglio, da sessant’anni. E continui?
ALBERTO RONCHEY Già, continuo anziché andare ai giardinetti, e includo nei giardinetti anche i campi da golf, in attesa di quelle che Saul Bellow chiama semifinali chirurgiche.
Hai qualche aspirazione?
Ricordo che a una domanda simile, fatta nel 1944 dai giornalisti americani a Sforza, lui rispose: «I have no ambitions, but 78 years». Detto bene.
Quali sono le idee superate, fra quelle che avevi coltivato nell’età giovane?
Ti rispondo con un’altra domanda. C’è ancora, per caso, qualche idea che non sia superata?
dp n="8" folio="8" ?
Hai qualche interesse per i costumi e il modo di ragionare delle ultime generazioni?
Sono abbastanza curioso, rifuggo dai pregiudizi contrari a ogni nuova mentalità, dalla pigrizia e dalla bigotteria. Però non pratico la speciale demagogia, o cortigianeria, che tanti usano verso il «popolo giovane». Vedo che fra gli anziani è diffusa la mania di schierarsi e mischiarsi per costante pregiudizio favorevole con le ultime generazioni, forse alla ricerca dell’utopica «fonte di giovinezza». Già la cercò un famoso esploratore spagnolo, che non la trovò, ma nel 1542 per consolazione scoprì almeno la California.
Ti sei trovato in situazioni rischiose, durante i viaggi o sul terreno di gravi conflitti?
Due incidenti aerei, con atterraggi di fortuna. Il primo in Canada, di fronte alla Baia di Hudson, un’ala infranta sulla pista ghiacciata. Il secondo in volo sui Pirenei, con uno dei due motori che aveva preso fuoco. In quelle circostanze, come credo succeda a tutti, non ho avvertito all’istante alcun panico. Un certo sgomento è sopraggiunto poco dopo, ripensandoci, malgrado le robuste bevute di whisky Seagram’s o di Pernod. Due volte mi sono trovato sul terreno di conflitti tragici. A Cipro, durante la guerriglia tra greci e turchi, mentre tutti sparavano da tutte le parti. Nel Congo, dopo la strage dei caschi blu a Kindu, quando mi toccò uscire in jeep dall’aeroporto trincerato dell’Onu, con una scorta etiopico-malese per una ronda nel villaggio dei massacratori. Un cronista Rai comunicò la notizia in ponte radio, come in seguito venni a sapere, con un eccesso di drammaticità: «Sta partendo Ronchey, lascia a Roma la moglie e una figlia...». Ma di queste vicende, se permetti, parleremo in dettaglio più oltre.
Ti sei mai trovato in condizioni professionali e politiche insidiose, con rischi di sgradevoli compromissioni?
A Mosca, un settimanale mi propose una collaborazione, ma lasciai cadere l’invito perché poteva dissimulare un tentativo di ricatto a tempo differito. In Siberia, per motivi che ti spiegherò poi, rischiai l’arresto e sarei stato probabilmente scambiato con chissà quale spia sovietica, se solo mi avessero trovato un po’ di alcol in corpo. Ci fu anche una disavventura nei rapporti con gli americani, qualche anno più tardi. A Hong Kong avevo conosciuto e stimato per la loro competenza i redattori della «Far Eastern Economic Review», che mi chiesero un articolo sulle vertenze confinarie russo-cinesi. Avevo spedito l’articolo da tempo, quando mi fu recapitato un cospicuo assegno in dollari dell’Usis. Domandai perché, mi risposero che si trattava della retribuzione per l’articolo pubblicato dalla rivista. Decisi di restituire quella somma, perché avevo avuto sentore che ci fosse un capitolo di bilancio comune tra l’Usis-Usia e la Cia. Intendiamoci, sarà stato un eccesso di prudenza, ma spiegai all’Usis di Roma che su certe questioni ero cauteloso come un coyote.
Cambiamo argomenti?
Certo, mi pare opportuno in questa ouverture di numerosi e disparati racconti.
dp n="10" folio="10" ?
Spesso ti hanno accusato di applicare, per la comprensione delle cose umane, un eccesso di razionalità, un deliberato non tener conto del ruolo delle passioni, dell’irrazionale, del simbolico nella sfera dell’«umano, troppo umano». Può essere compressa la vita nel gelo delle cifre, nel cerchio oggettivo della pura fattualità?
Un giorno, in un pubblico dibattito, Antonio Ghirelli disse che se fosse stato per il modo di ragionare di La Malfa e mio «Anna Karenina non si sarebbe mai gettata sotto un treno». Risposi: «Ma con il vostro modo di ragionare neanche sarebbe passato il treno». Insomma, lui obiettava che nella vita di tutti, come nella politica e nella storia, non c’è solo razionalità. C’è anche l’irrazionale, con le sue pulsioni emotive legate a passioni e ideologie. Questo lo sappiamo bene, intendevo io, ma in Italia ormai s’è raggiunta la soglia massima dell’irrazionale collettivo, che va fronteggiata con gli strumenti della logica. Se no, qui nemmeno passa il treno. Correvano gli anni Settanta, con le utopie dell’epoca. La politica non voleva commisurare i mezzi ai fini, o viceversa. Per esempio, si poteva reggere l’illusione che il salario fosse una «variabile indipendente», anche se in economia tutto è interdipendente? Oppure, si poteva concepire che fosse raggiungibile subito, e non solo auspicabile, il cosiddetto «salario europeo» in assenza del capitale fisso di livello europeo? No, perché il salario in termini reali, e non inflazionistici, è correlato alla produttività, la quale poi è correlata in gran parte alla dotazione di capitale fisso per addetto, impianti, tecnologia, infrastrutture. In Italia, la dotazione media era inferiore a quella nordeuropea.
Detto questo, è chiaro tuttavia che ogni singolo individuo è vulnerabile all’irrazionalità e persino a qualche utopia personale, me compreso. Mia moglie osserva che io stesso, anche se mi professo pragmatico, cedo poi a una sorta di utopismo privato quando pretendo di non obbedire né di comandare. Incredibile, certo, lo so, e so pure che non conviene vivere così. Ma il disastro vero è il diffondersi dell’arbitrio privato su scala pubblica.
C’entra tutto questo con la cura quasi maniacale per il controllo minuzioso dei fatti che è un tratto specifico della tua identità, non solo professionale?
Sai, ho scoperto una cosa. In età giovane si lavora per sopravvivere anche tirando via, ma dopo si lavora per capire come stanno veramente le cose. Chiaro, l’infallibilità non esiste, si tratta di sbagliare il meno possibile, o meno degli altri. Nel mio mestiere ho intervistato e letto libri o giornali in quattro lingue. Un travaglio pesante, costante, ma sostenibile se lo scopo è capire i fatti, senza cedere all’effimera opinione corrente o prevalente, che predilige le supersemplificazioni. Chiaro, chi scrive per i giornali complicando una questione semplice, anziché spiegarla, commette una mala azione, ma è un’azione peggiore supersemplificare una questione complessa, che significa presentare un problema facile solo perché deformato, dunque falso. In breve, se neanche si tenta di spiegare davvero le cose, almeno un po’, questo mestiere si riduce a un’immensa noia, oltre tutto indecorosa e faticosa.
Quanto conta la paura tremenda di sbagliare nella tua «psicosi d’accertamento»? E ti è mai capitato di sbagliare? E per te il fatto stesso di sbagliare rappresenta in quanto tale uno scacco intollerabile?
dp n="12" folio="12" ?
Hai letto La variante di Lüneburg, quel romanzo di Paolo Maurensig? Studia nel giocatore di scacchi, magari per metafora, il terrore di sbagliare, un’ossessione, una malattia. Bene, anche in altri esercizi mentali è così. In un certo stadio della vita, e in certe professioni, senza questa malattia non si campa, si finisce ai giardinetti. Tu domandi se ho mai sbagliato. Senza dubbio e spesso. Quante volte, figliolo? Non ricordo, so con certezza che ho cercato se non altro di fuggire l’errore nei «giudizi di fatto». Devo aggiungere che nel mio mestiere ci si può sentir colpevoli non solo per un errore fattuale o un’imprecisione, forse inevitabile, ma anche per una virgola sbagliata che cambia il senso dell’argomentazione, un refuso che la rende incomprensibile. Camminando sulla via, capita persino d’immaginare che qualcuno ti denunci col dito puntato: «Ecco, è lui, è lui che ha sbagliato». Che fastidio, per esempio, quella virgola che ti cacciano tra il soggetto e il verbo, tra il verbo e il complemento oggetto. Un errore, perché l’azione non si ferma, anche se a questa obiezione un funzionario dei Beni Culturali mi rispose con un sospiro: «Si ferma, qui si ferma, ministro, purtroppo...». Che fastidio poi, anche riguardo alla sciatteria altrui, sentire nelle comuni conversazioni e nei dibattiti, mutuato dal malvezzo televisivo, quell’intercalare stucchevole: «Come dire... come dire...». Se non sai come dire, non dire. Beninteso, qui sto ricordando solo alcune molestie minime dello scrivere o parlare illogico e impreciso. In genere, l’ossessiva e disperata guerra contro qualsiasi fallibilità sarà pure una malattia, ma è uno stimolo vitale proprio come la «sindrome d’accertamento», diagnosticata quale malattia dagli psicologi eppure indispensabile per la ricerca.
dp n="13" folio="13" ?
C’è un qualche rapporto tra tutto questo e la tua predilezione per la cultura anglosassone, tutta pragmatismo, cifre e fatti, contrapposta all’idealismo italiano, imbevuto di perenne ideologismo?
Chissà, forse c’è qualcosa nel mio genoma d’origine scozzese, a parte la mia speciale affezione per Adam Smith, padre dell’economia politica. Mentre come lettore assiduo degli economisti classici prediligo anche Ricardo, Malthus, Alfred Marshall, e poi Keynes, fra l’altro studioso di lettere antiche, il quale proclamava: «L’economia non è la civiltà, ma la possibilità della civiltà». Non sono d’accordo nel contrapporre in blocco l’empirismo e il pragmatismo degli anglosassoni alla cultura italiana, che include l’illustre filone di Cattaneo. Del «Politecnico» possedevo una collezione, che ho affidato alla Fondazione del «Corriere della Sera», un lascito che ho immaginato e spero non solo materiale. E come dimenticare Pareto, Salvemini, Luigi Einaudi?
Dimmi chi sono gli «anglosassoni» della tua vita: libri, film, scrittori, canzoni.
Qui si ritorna, per cominciare, a uno scozzese, Robert Louis Stevenson, senza rievocare la storica e più celebrata letteratura propriamente inglese. Riguardo agli americani, fra il ginnasio e il liceo fui subito influenzato dal culto clandestino di Radio New York, l’eredità musicale di Gershwin, scomparso nel 1937. E Cole Porter, Duke Ellington, e gli altri. Fra le prime scoperte letterarie, Steinbeck, già tradotto e pubblicato durante il fascismo perché in Furore aveva descritto la Grande Crisi. Poi Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Faulkner, Sinclair Lewis e più oltre fra i miei prediletti Saul Bellow, Philip Roth, Bernard Malamud. Sul cinema, conservo impressi nella memoria specialmente i film di guerra dal Pacifico all’Europa, Guadalcanal, Corregidor, lo sbarco in Normandia. Ho intervistato, prima che fossero premiati, i Nobel per l’economia Samuelson e Solow. Poi ho conosciuto Walter Heller, Daniel Bell, Irving Kristol, Schlesinger, Bundy, Rostow, Galbraith, Kissinger, Brzezinski. Ho viaggiato in quarantanove dei cinquanta Stati Uniti, escludendo le Hawaii che offrivano solo svaghi turistici. Sento ancora addosso l’odore americano dopo il primo sbarco a New York, quello del caffè fresco e delle ciambelle nei corridoi della Grand Central Station, alle cinque della mattina, in cerca del «New York Times». Sento l’intonazione così particolare, insieme rassicurante e sbrigativa, degli speaker nei notiziari ininterrotti. Ma da quegli anni, devo confessare, l’America non mi affascina più come prima, nell’epoca di Kennedy. Forse io sono un laudator temporis acti e non posso farci niente, malgrado i prodigi informatici e telematici o biotecnologici di quella società.
E la Roma in cui sei nato e cresciuto, quanto conta, «antropologicamente», per te?
Sono entrato in scena quando l’altro secolo era giovane, vicino a Villa Borghese. Quello rimane il mio imprinting, compreso il fischio del vigile urbano in bicicletta non appena si calpestava un’aiuola, un suono che vorrei sentire ancora. Poi ho vissuto a piazza Navona, Bernini, Borromini, lo stadio di Domiziano, e a Campo de’ Fiori, con il monumento a Giordano Bruno. Quindi ho abitato in Prati, Mole Adriana o Castel Sant’Angelo. Di «antropologico» non c’è più niente, bisogna risalire a Belli, Pascarella, Petrolini e Trilussa. Ci si può consolare solo volgendo lo sguardo al centro storico da Trinità de’ Monti, o passeggiando per Trastevere, se appena il sindaco Veltroni ci concedesse una pausa delle sue smanie sagraiole o festivaliere, quella fissazione di rendere la città borgatara e insieme plurietnica, moltiplicando la chiassosa «insiemitudine» di notte oltreché di giorno. Eppure scriveva Seneca nella settima lettera a Lucilio: «Mi domandi che cosa si debba specialmente fuggire. Ti rispondo, la folla».
Quanto, del tuo modo di essere giornalista, si riflette nel giornalismo italiano? Poco, tanto, niente? E quali sono i giornalisti della generazione successiva alla tua che senti più affini, o più simili a te?
Come rispondere? Il giornalismo è del tutto cambiato a causa della televisione, che trasmette le immagini e le notizie in diretta, anche se con molti errori di grammatica, sintassi, storia, geografia, pronuncia. In quanto a chi studia, indaga e scrive ho in mente qualche nome davvero eccellente, ma non voglio scoraggiare l’ultimo e finora inosservato emergente.
Non perdi occasione per parlare male della politica italiana.
Non si tratta della politica seria, ma della «politique pol...