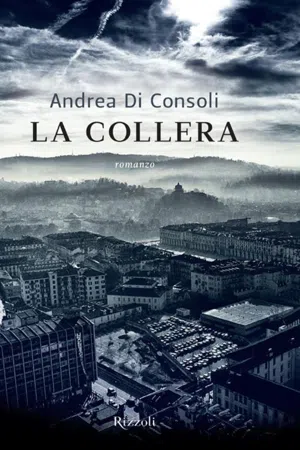![]()
1
Diciotto agosto 2008. Sono le cinque del pomeriggio, ma la canicola è ancora opprimente. Un gruppo di persone sta senza parlare davanti al primo manifesto funebre che annuncia al paese la morte di Pasquale Benassìa.
Il manifesto è ancora umido di colla. C’è scritto che “si è spento serenamente”, ma non è vero, e lo sanno tutti: sereno non lo è mai stato, Pasquale, eppure si dice sempre così, si dice così per tutti, anche per i disperati.
Il funerale lo pagheranno il comune del Paese dei Mori e alcuni vecchi iscritti alla locale sezione di Alleanza Nazionale (hanno fatto una colletta, soprattutto i veterani del MISS), perché Pasquale non aveva parenti né qualcuno che vivesse con lui o che, insomma, lo amasse – che lo amasse per davvero dopo la morte di Teresa, l’anziana amante sopravvissuta ai temporali e alle durezze di una sciagurata esistenza.
Costerà poco, questo misero funerale, perché la bara è di legno grezzo e il marmo della lapide sarà scadente, se mai si degneranno di metterla sulla piccola parete di cemento e di calce bianca, ché con il passare degli anni sempre più loculi, in quest’angolo di Calabria, rimangono disadorni, appena segnati da un nome sgangherato scritto a pennello con l’inchiostro rosso.
In paese tutti lo conoscevano e tutti, in un certo senso, gli volevano bene, anche se molti, per non litigarci, lo sopportavano e gli dicevano sempre di sì, come si fa con i pazzi o con gli scemi. E non erano pochi quelli che lo consideravano un esaurito, un povero spiantato che s’era fabbricato con le sue stesse mani un assurdo inferno terreno.
La verità è che Pasquale Benassìa è morto solo come un cane, consumato dalla bronchite cronica, dalla dispnea e dalla sofferenza cardiaca – e da una rumorosa solitudine.
Della sua scomparsa si è accorta l’assistente sociale che gli portava ogni giorno il pranzo alle dodici in punto. Margherita ha bussato più volte, invano. Poi è ritornata alle due, e anche alle due nessuno ha aperto. A quel punto è scesa per strada e ha iniziato a chiedere a destra e a manca. Nessuno però l’aveva visto, quel giorno, nemmeno gli amici del bar.
Sono stati i carabinieri a sfondare la porta. Subito sono saliti di sopra. Pasquale era disteso sul letto, con il telefono appoggiato sul grosso ventre. Sembrava sorridere, anche se a consumarlo è stata l’infelicità. Tutt’intorno c’erano vecchie riviste di storia, alcune copie del «Secolo d’Italia» e confezioni di medicinali per il diabete, la pressione alta, l’insufficienza renale e la bronchite cronica.
Margherita, affezionata a quel vecchio strampalato che dimostrava almeno quindici anni più di quelli che effettivamente aveva, ad apprendere che se n’era andato per sempre senza dire addio a nessuno, si è coperta il volto con le mani ed è uscita dalla casa in lacrime, quasi correndo.
E forse era l’unica ad avergli voluto davvero bene negli ultimi tempi.
Da qualche anno Pasquale non ce la faceva nemmeno più a parlare, tanto era in affanno. Gli amici del bar gli dicevano continuamente di ricoverarsi, ma lui non li stava a sentire, rispondeva a muso duro che «nessun dottore potrà mai ostacolare la sacralità del destino». E aggiungeva pure: «Voialtri siete servi di tutti, specialmente dei medici. Infatti pagate per sentirvi raccontare delle frottole. Eppure dovreste saperlo che contro la morte non c’è rimedio».
Farlo ragionare era impossibile. Voleva agire di testa sua e questa ostinazione gli ha procurato infinite sofferenze.
In chiesa ci sono alcune vecchie che partecipano a tutte le funzioni e a tutti i funerali. C’è il sindaco e ci sono alcuni assessori della giunta di centrodestra – di centrodestra per modo di dire, perché, come càpita spesso nei piccoli comuni, nella maggioranza ci sono esponenti di una lista civica e due transfughi di sinistra in polemica con il proprio partito. C’è ovviamente Margherita. E poi ci sono la vecchia vedova del dottor Anile, una dozzina di ragazzi che frequentano la chiesa, gli amici del bar, alcuni attivisti di quel che rimane di Alleanza Nazionale e due o tre coetanei di Pasquale.
In fondo, in disparte, è seduta invece una distinta ed esile anziana che nessuno, lì al paese, ha mai visto prima, ma pochi ci fanno caso.
Saranno in totale una trentina di persone. Il resto, o è al mare oppure non ha motivo di partecipare al funerale di Pasquale Benassìa.
Il prete, durante la predica, riserva poche affettuose parole all’uomo che, immobile davanti a lui, sta dicendo per sempre addio al mondo.
Le morti sono ancora uguali, al Paese dei Mori, e una vita, tutto sommato, vale l’altra; e dunque, come tutti, anche Pasquale, a parere del prete, sarà accolto dal benevolo abbraccio del Signore, sempre che non abbia da ridire anche nell’aldilà.
La gente esce dalla chiesa e si dilegua a causa dell’afa. In piazza, sotto il sole cocente, ci sono soltanto muscolosi operai a torso nudo che stanno montando il palco dove in serata canterà Maurizio Vandelli.
Gli impiegati delle pompe funebri trasportano la bara sulla spalla e la sistemano in silenzio nel Mercedes grigio. Poi entrano in macchina e si dirigono lentamente verso il cimitero, seguiti a piedi dagli amici zoppicanti del bar.
Cani randagi afflitti dal caldo e dalla sete si muovono intorno agli uomini che stanno spingendo la cassa nel loculo che il comune ha riservato a Pasquale.
Adesso è finita per davvero.
Qualcuno, a testa bassa, si fa il segno della croce; altri augurano finalmente la pace a quel pover’uomo che la pace non ha mai conosciuto. E quando tutti sono andati via, davanti alla tomba di Pasquale rimane solo un cane nero che rosicchia rabbiosamente un enorme osso secco di bue.
![]()
PARTE PRIMA
Breve e rapida storia dell’infanzia,
della giovinezza e delle idee di Pasquale Benassìa
![]()
2
Una delle cose importanti che a Pasquale Benassìa era capitato di scoprire a un certo punto della sua vita, dopo anni e anni di ossessivo rimuginare – a lui che amava confrontare con l’animo in tumulto date della storia e incroci del destino – era la faccenda di Adolf Hitler (quante volte aveva usato la parola faccenda riferendosi al Führer?), morto lo stesso giorno che lui nasceva.
Su questa storia di Hitler aveva nel tempo costruito una teoria: una delle sue tante apodittiche e franose verità. Ma ogni volta che aveva provato a parlarne agli altri, gli avevano sempre sorriso in faccia con diffidenza, dicendogli che era un esaltato, un matto.
«Che significa dire a qualcuno tu sei matto?» reagiva colmo di rancore. «Significa forse qualcosa? Niente, non significa un cazzo di niente.»
Era cosa di poco conto nascere il 30 aprile del 1945?
A lui sembrava una cosa sensazionale, altroché. Così come le acque erano legate sotterraneamente, e la luna cambiava l’asse invisibile dei cervelli e il dosaggio degli umori, così anche i destini delle persone vive e morte eternamente s’incrociavano e si mescolavano nel sottosuolo del grande destino dell’umanità.
Pasquale Benassìa soleva ripetere che qualcosa di lassù era scesa fin quaggiù – e per quaggiù intendeva il suo povero Paese dei Mori, nelle Calabrie alte condannate a una brutta sorte, «alla barbarie di una eterna ignoranza».
«Non è che sono la reincarnazione di Hitler, capiscimi bene, non sono mica esaurito» ripeteva all’amico o avventore di turno, «ma il fatto è che io, come lui, ho capito che non serve a niente piagnucolare come fate voialtri analfabeti. Siete piccoli piccoli, com’è che non ve ne accorgete? Ma che ci parlo a fare con degli ignoranti come voi? A lavare le orecchie all’asino si perde solo acqua e sapone.»
A quel punto quasi tutti, non capendolo, alzavano le spalle e cambiavano argomento; alcuni invece, molto più avvertiti e informati, si inalberavano e gli ripetevano, alzando la voce e accalorandosi, il conto esatto degli ebrei sterminati e la nera storia dei forni. Ovviamente quasi nessuno capiva che Pasquale diceva quel che diceva non per cattiveria, ma per un oscuro impulso a impossessarsi di qualunque verità o parola che gli altri, per buon senso, rifiutavano.
Solo una volta accadde nella piazza che il figlio del calzolaio, a sentirlo parlare in quel modo, commentò con malcelata simpatia: «Un nazista in Calabria non lo avevo mai sentito prima». E lo disse con divertita solidarietà, forse intuendo un fuoco buono in quel delirio incomprensibile che molti, ragionevolmente, fraintendevano. Ma anziché ringraziarlo per l’inattesa comprensione, Pasquale prese anche lui a male parole, e gli urlò contro: «Sei uno scemo anche tu, che ti credi? Tutti voi giovani siete scemi! Avete bisogno di storie per commuovervi e di leccare il culo ai politici per trovare un lavoro. Siete dei mendicanti, questo siete!».
L’altra cosa memorabile che avvenne in quel tempo lontano, nel tempo lontano dell’infanzia – era il 1953 – fu la faccenda delle capre, che il padre pastore, Ernesto Benassìa, classe 1908, reduce di guerra in Abissinia senza medaglia, e quindi senza onore, trovò semimorte e agonizzanti nell’enorme Campo del Misso.
Tornò a casa che non respirava più, il povero padre – allora non soffriva di cuore o, perlomeno, non lo sapeva ancora, di avere un cuore grande come quello di un bue. Era nero dalla rabbia, balbettava bestemmie, prometteva vendette insanguinate. La moglie, Maria Perrone, classe 1914, continuava a dirgli: «Oh, stai calmo, per la Madonna incoronata, raccontami cos’è successo!».
Ma quello schiumava rabbia e vendetta come un cane senza ragione.
Solo dopo qualche minuto di sfogo il vecchio trovò le parole per dire il suo dolore: «Hanno avvelenato tutte le nostre capre».
Andarono al Campo del Misso e videro un centinaio di capre che respiravano schiuma e sangue dalla bocca e dal naso, e che stavano a terra moribonde, con la debolezza estrema dell’agonia. Il padre, a quel punto, decise che sarebbe andato a chiamare il medico Sarubbi e disse, colmo di odio e di speranza: «Se questi mangiapaneatradimento sanno curare un cristiano, allora sapranno curare anche una bestia».
La moglie, vermiciattola frettolosa, sempre con un tozzo di pane in mano (lo portava eternamente con sé, senza mai mangiarlo, chissà per quale oscura memoria della fame) lo accompagnò, e quasi si dimenticarono del piccolo Pasquale, che rimase solo in mezzo al campo.
A rimanere così, Pasquale ebbe un brivido di paura, ma anche un’avida curiosità per quegli atroci sintomi da soffocamento (probabilmente fu lì che gli s’appalesò un estro viscerale, un’attitudine a pensare la vita interamente attraverso i moti del corpo), tanto che s’inginocchiò davanti a un caprone puzzolente e scrutò attentamente i suoi occhi spenti, gli aprì la bocca rantolante e, per saggiarne la vitalità, gli tirò il pelo e gli diede dei pugni sulle zampe. L’animale rispose con un lamento impotente, e quasi parve implorarlo, con la poca luce rimastagli negli occhi grigi, di farla finita.
Ma proprio mentre Pasquale torturava il caprone agonizzante, sul Campo del Misso comparve un monaco che camminava a piedi nudi. Camminava velocemente e attraversava quel brutto spettacolo di capre moribonde senza, in apparenza, curarsene. Pasquale si alzò e lo guardò senza riuscire ad aprire la bocca. L’unica cosa che gli balenò nella mente fu l’immagine di San Francesco di Paola, il santo patrono del paese.
Ma tanta fu poi la paura – perché, quando si è piccoli, dinanzi alle cose importanti si tende giustamente a fuggire – che si mise a correre giù per il vallone, verso casa, dove nel frattempo era giunto il patetico medico senza scienza che, ancor prima di salire al Campo, s’era già messo avidamente da parte vini, olî, uova e polpose salsicce, perché in paese tutti sono perennemente affamati tranne il medico, il sindaco, il farmacista, il prete e «il bastardissimo maresciallo», come Pasquale avrebbe definito da grande un caposbirro un po’ vigliacco del Paese dei Mori.
Arrivato a casa, davanti ai genitori e al medico, rimase in silenzio; anzi, tentò di placare con la volontà un pesante fiatone da cane. Non gli sembrava proprio il caso di uscirsene, in un frangente triste e teso come quello, con una notizia del tipo: «Cara mamma, caro papà, caro dottor Sarubbi, vi comunico che ho appena visto camminare di fretta tra le capre morenti il nostro amato San Francesco». Sarebbero chiaramente partiti calci in culo e grevi bestemmie, e forse anche qualcosa di peggio; ragion per cui rimase in un angolo della cucina con le mani dietro la schiena (come un vecchio in piazza), e attese che quegli adulti uscissero in direzione del Campo del Misso.
Ovviamente li seguì senza fiatare.
E quando tutti furono lì, s’avvidero sbalorditi che le capre non erano affatto stese a terra agonizzanti, ma in piedi, sanissime, colme d’appetito. Fu solo a quel punto che Pasquale tentò di dire cosa gli era capitato di vedere; ma il padre era più intento a giustificarsi col medico adirato, al quale ripeteva disperato «ti giuro sopra la testa di mio figlio che erano tutte moribonde», che non ad ascoltare le rivelazioni del figlio, che rimasero lettera morta, se non per un fugace segno della croce che la madre si fece ringraziando non solo San Francesco, ma pure Iddio, la Madonna, sant’Antonio e, senza distinzione di valore, tutti i santi del cielo.
Pasquale Benassìa pose alla base del suo assurdo sistema filosofico proprio queste due faccende – il demone di Hitler e la gioia delle visioni – ma questo sistema divenne sempre più strampalato in età adulta, quando arrivò a fondare una specie di religione individuale di cui era l’unico adepto e, in fondo, l’unico dio.
«Ogni giorno succedono milioni di miracoli e voi non li vedete perché siete esseri miserabili che hanno bisogno di mangiarsi un tozzo di pane, di godere tra le gambe e di raccontarsi storie che fanno piangere. Siete esseri inferiori, e come esseri inferiori dovete morire» gridava tra bar e pizzerie ogni volta che un pensiero altrui gli andava di traverso come un osso aguzzo nella gola ispessita dal fumo e dalla tosse catarrosa.
«Siete solo niente mischiato con nulla» sbraitava e sentenziava dall’alto del suo furore prima di rincasare in solitudine.
![]()
3
La cosa curiosa di quest’uomo che soleva urlare eresie e sconcezze nel paese è che sin da ragazzo aveva letto tutto quello che gli era capitato per le mani – almanacchi, calendari, giornali, riviste, romanzi, libri di Storia e, con sommo gaudio, enciclopedie di ogni tipo: mediche, geografiche, storiche, militari.
Eppure non aveva fatto che la quarta elementare, con infinita disperazione del maestro Ginetto Cersosimo – un triste adepto del Pascoli, del quale praticò malamente una fanatica rivisitazione vernacolare – che non sapeva più quale altra punizione inventarsi per placarlo almeno un poco. Perché Pasquale non faceva altro, mentre il maestro parlava pazientemente di numeri e di grammatiche, che imitare il verso degli animali: una volta quello della pecora, un’altra volta quello del cane, più spesso quello acuto e ululante del lupo. A quel punto – quando Pasquale imitava il lupo, come un ossesso – il maestro lo prendeva per le orecchie e gli sbatteva la faccia contro il muro, sortendo come unico effetto l’ilarità non solo di Pasquale, ma anche dei suoi rustici compagni di scuola, odorosi di capra e di cenere di braciere.
Sin da allora sembrava che dentro al corpo di quel ragazzo ci fosse il caos, un fuoco perennemente acceso, un eccesso di sangue, e che tutto, in lui, tendesse senza rimedio verso una devastante confusione (in altre epoche, probabilmente, lo avrebbero curato coi salassi). E non c’erano schiaffi o calci che potessero placare quella piccola furia a cui molti pronosticavano, colmi di buon senso e di saggezza antica, «di fare una brutta fine: vedrai che Pasquale finirà o in galera o in manicomio, a Girifalco, con la camicia di forza».
E se matto non sei di natura, matto ti ci fa diventare comunque, la casa dei pazzi di Girifalco, prigione forzata dove tutti si guardano con circospezione e, pur di non essere spiati, si nascondono. Come si può non impazzire in un manicomio dove ti tormenta dalla mattina alla sera il puzzo di piscio e di merda degli altri? Se matto non sei, matto ti ci fanno diventare, nel brutto inferno di Girifalco.
Nonostante poi la costante mancanza di soldi in famiglia – benché nel dopoguerra meridionale i soldi avessero ancora un valore relativo, prevalendo in ogni dove gli avidi pidocchi e le zecche – e nonostante l’essere cresciuto tra...