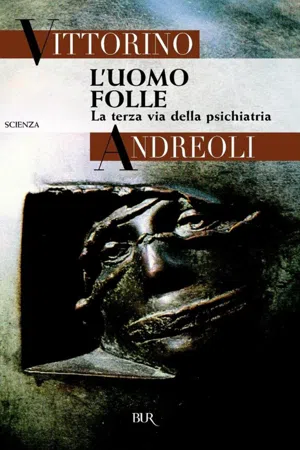![]()
LA TERZA VIA DELLA PSICHIATRIA
La terza via della psichiatria, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano 1980.
dp n="36" folio="36" ? dp n="37" folio="37" ? ![]()
Presentazione
La psichiatria uscita dalle istituzioni e dalla stretta cerchia degli psichiatri è diventata fatto culturale. La follia è stata rielaborata in interpretazioni nuove rispetto al filone tradizionale che ne faceva un ramo, anche se anomalo, della biologia. All’appropriazione della follia da parte degli esperti, espressa nel riduzionismo a lesioni cerebrali (psichiatria biologica), è seguita la sua incorporazione nella dinamica sociale diventando psichiatria sociale: le due grandi vie storiche di interpretazione della follia. Due vie che si combattono e che, pur diverse, si fondano entrambe su uno schema riduzionistico e dualistico, che vede il periodico rimando da una all’altra.
Negli ultimi anni, battuta con convinzione e insistenza la via sociale, si sono accumulati dati per un ritorno al biologico, come antitesi e quindi come restaurazione dell’altro riduzionismo.
Esiste una via diversa? Ecco La terza via della psichiatria o meglio un’altra via, fra le tante possibili. Una terza via che si propone come superamento dei dualismi e come necessità di instaurare l’unità del sistema encefalo-storia, premessa allo studio e alla comprensione del comportamento. Una psichiatria che abbiamo chiamato talora psichiatria dei sistemi, perché risultato di una dialettica tra sistema encefalico e sistema ambiente-cultura-storia (prodotta da tutti gli encefali umani e che per il singolo rappresenta il termine dinamicamente interagente con la sua biologia), talora antropsichiatria genetica per sottolineare l’insieme di una visione antropologica e di un divenire ontogenico dell’encefalo continuamente modificante e modificantesi in rapporto al mondo extrasomatico. Una via, dunque, che prevede uno sforzo di integrazione di sistemi biologici e sociali per una lettura nuova del fenomeno umano e dei suoi comportamenti.
dp n="38" folio="38" ? La terza via della psichiatria ha una giustificazione storica, inserendosi nella discussione culturale; va vista, però, anche come apporto metodologico alla ricerca in psichiatria. Ogni concezione che tenda alla comprensione della follia in termini biologici, pur se espressi nelle formule della biologia molecolare, è metodologicamente errata, come qualsiasi tentativo che veda il fenomeno comportamentale e la sua follia, risultato della meccanica encefalica. Solo nell’interazione tra questa macchina e l’ambiente storico-culturale si situa il comportamento e la follia; il campo della psichiatria è pertanto nella giuntura (sinapsi) tra encefalo e storia ed è estraneo all’encefalo o alla dinamica sociale, isolatamente considerati. Questo limite metodologico suggerisce un nuovo atteggiamento e richiede che la psichiatria si fondi su unità e sistemi derivati dalla integrazione di sottoinsiemi encefalici e storico-ambientali.
Questa visione apre prospettive per una nuova definizione della follia e soprattutto per una sua nuova lettura (semeiologia) e trattamento. Un lavoro che si apre in questo volume e che potrebbe trovare fruttuoso sviluppo. Una via, dunque, aperta, ma ancora tutta da percorrere.
Questo volume è prima di tutto un contributo all’analisi della patologia del comportamento e apre un dialogo con tutti e non soltanto con gli psichiatri. In questi termini culturali e teorici recupera spunti e sviluppa argomenti che potranno contribuire a una corretta formulazione dialettica tra biologia e storia in psichiatria.
La forza per aprire una via nasce solo dalla dedizione che abbiamo dato alla psichiatria, ancor prima di averne i carismi accademici, e soprattutto dalla anomalia, per la cultura e regole italiane, del nostro curriculum che ci ha visti per molti anni nel campo della biologia della follia, prima di essere anche operatori clinico-terapeutici.
Nella storia, la “follia” di chi ha pensato di aver trovato coordinate nuove per capire un vecchio fenomeno, è stata talora molto utile. Con questa motivazione abbiamo sostenuto il lungo periodo di lavoro che la stesura di questo volume ha richiesto.
![]()
I
La psichiatria nel “campo” delle scienze
L’attuale psichiatria è l’espressione del suo secolare “internamento” nei confronti della scienza e della cultura. Una storia di esclusione con tentativi di metamorfosi scientifica.
La psichiatria come scienza è la premessa necessaria a una valutazione e al superamento della crisi di identificazione che, in particolare in questi anni, sta vivendo. Un’analisi del rapporto tra psichiatria e scienze permette di identificare gli ostacoli che hanno impedito un suo inserimento nelle scienze. Finora ha costituito un esempio di disciplina non scientifica, variamente utilizzata.
La visione delle scienze che si era imposta a partire dal Seicento, ma nettamente nell’Ottocento, distingueva le scienze esatte da quelle inesatte, e poneva come modello di massima scientificità la fisica e la matematica: riferimento delle altre discipline scientifiche il cui sforzo doveva tendere a una loro trasformazione nelle leggi della fisica e della matematica. Tanto più una scienza era leggibile in termini fisico-matematici, tanto più era esatta. Ne era derivata una gerarchia di scientificità che andava dal mondo della précision a quello del à peu près. In questa concezione la psichiatria era lontanissima dal modello di riferimento proposto e il programma della sua catarsi scientifica sarebbe dovuto passare attraverso la neurofisiologia, la biochimica, la chimica. Un percorso di assiomatizzazione che, anche se progettato, appariva chimerico. Una metamorfosi che vedeva la psichiatria negarsi, perdere i propri connotati, per diventare scienza. La storia della psichiatria potrebbe essere descritta in questo sforzo di metamorfosi. Basterebbe valutare il lavoro di molecolarizzazione1 della psichiatria biologica a partire dal 1950. A mano a mano che gli studi di biologia molecolare progredivano, in particolare nella genetica, si moltiplicavano le ipotesi biochimiche delle più importanti sindromi psichiatriche.
Abbiamo più avanti riordinato storicamente questa ricerca molecolare per le sindromi schizofreniche e depressive. Anche solo scorrendo le sintesi fatte, appare il bisogno, quasi ossessivo, di scientificizzare la psichiatria, che nel senso della biologia molecolare significa identificare la molecola diversa cui ridurre il fenomeno del diverso mentale. Sono riportate alterazioni molecolari nel malato di mente per la maggior parte degli organi e le più diverse frazioni biochimiche, in uno sforzo di “salvazione” della psichiatria avvicinandola alle scienze esatte. La psichiatria si è così diretta verso una semplificazione, una elementarietà nei termini della chimica.
Dalla sua complessità dunque ha teso a un riduzionismo che permettesse un suo recupero, pur con gradienti di approssimazione maggiore, tra le scienze esatte. È singolare che la psichiatria abbia perseguito questo mito nel periodo in cui le scienze esatte, e in particolare la fisica, vivevano il superamento del concetto di esatto che sembrava loro intrinseco. Nel momento cioè in cui la fisica, alla ricerca dell’elemento costitutivo della materia e quindi all’interno dell’atomo, si allontanava dall’elemento primo ritrovando sistemi sempre più complessi, dominati da leggi dell’indeterminazione, del caso, la psichiatria lavorava intensamente per una assiomatizzazione biochimico-molecolare. A questo processo è legato fondamentalmente l’internamento attuale della psichiatria rispetto alle scienze. Mostreremo come le scienze, dalla fisica alla chimica alla neurofisiologia, si siano progressivamente allontanate dall’elemento e siano entrate nei sistemi.
L. von Bertalanffy nel 1925-26 definì il sistema come «un complesso costituito da elementi in interazione».2 Il sistema, dunque, è costituito da più elementi (o unità) che «si influenzano reciprocamente all’interno del sistema».3 Applicato all’encefalo, questo concetto permetterà di recuperare al discorso scientifico funzioni ritenute prima indipendenti. Si potrà superare lo studio elementaristico dell’encefalo, utile per un’anatomia dei sistemi, ma inservibile alla comprensione di funzioni encefaliche legate alla disposizione spaziale (in sistemi) di elementi anatomici già noti e che realizzano, nel loro insieme, tali funzioni, che dipendono pertanto dal collegamento di più neuroni. Un neurone, pur identico agli altri già collegati, che si aggiunga al sistema, permette una funzione nuova, che non sarà tanto l’espressione di quel neurone (indistinguibile dagli altri) ma dell’aver aumentato in elementi e complessità il sistema. È funzione nuova dell’insieme, non di quel neurone, o (in altri termini) di quel neurone in quanto inserito nell’insieme precedente. Il concetto di sistema applicato alla fisica, alla informatica, ha trovato difficoltà a entrare nell’analisi dell’encefalo, almeno per le sue funzioni più complesse. Analogamente a quanto è avvenuto per il concetto di campo applicato anch’esso alla fisica e solo con difficoltà ai comportamenti. “Campo” definisce propriamente lo spazio entro cui gli elementi si influenzano vicendevolmente. Il sistema è pertanto anche definibile come il raggruppamento di più elementi in un campo.
Al di là della discussione formale sulla definizione, già ampiamente trattata,4 è essenziale al nostro lavoro far percepire l’idea che le funzioni via via più complesse identificabili nell’evoluzione della materia, dall’atomo all’uomo, non si legano necessariamente al costituirsi di nuovi elementi, ma di nuovi sistemi e quindi si realizzano anche dall’acquisizione in un campo di un solo elemento identico a quelli già presenti, che permette interazioni più complesse nel sistema, e quindi una specifica e nuova funzione. È implicito che i termini “elemento” e “complesso” sono relativi e gerarchicamente analizzabili. Un sistema legato a una data funzione, può diventare elemento per una funzione differente e più complessa in termini di campo e di influenze tra sotto-sistemi.
Nello stesso tempo in cui discipline scientifiche incorporavano il concetto di sistema, altre, inclusa la psichiatria, hanno teso a una semplificazione, a una elementarizzazione ritenuta necessaria per la loro scientificità. Un andamento storicamente paradossale per cui la critica del concetto di elemento per un gruppo di scienze diventa il fondamento a cui tende un altro gruppo.
Negli ultimi anni si è imposto, anche se confusamente, un movimento che ha infranto la dicotomia esatto-non esatto applicata alla scienza. È prevalsa la concezione che esista una gerarchia di scienze, non sul parametro della esattezza ma su quello dell’oggetto della ricerca. Ogni scienza, cioè, ha una propria fetta dell’esperienza su cui ricercare e una metodologia proporzionale e idonea alla rispettiva complessità dell’oggetto. Mentre secondo l’idea delle scienze progressivamente lontane dalla precisione, si intravedeva una necessaria purificazione verso il modello della fisica e della matematica, ora, secondo la nuova proposizione, una scienza non è riducibile ad altre, ma nel proprio interno e secondo la propria metodologia si propone di spiegare i fenomeni cui è dedicata. Una gerarchia che potremmo definire della complessità, nel se...