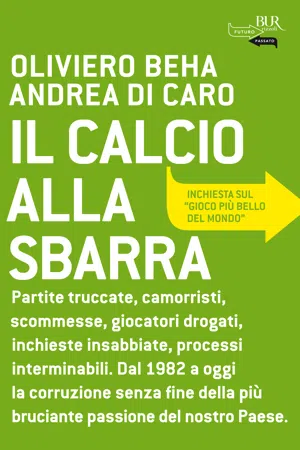![]()
Dedica
A Laura
A chi sa tutto, a chi non sa nulla,
a chi vuole sapere
![]()
Non rimbalza più (2006-2011)
Il pallone non rimbalza più. Per lo meno non rimbalza normalmente, come dovrebbe, come siamo abituati a vedere da oltre un secolo. Non rimbalza in mezzo al campo, perché il terreno di gioco è ormai una palude, e nella palude la sfera si ferma, si spiaccica e muore lì. Ma il calcio, il campionato, le partite devono andare avanti, per mille motivi per lo più evidentissimi. Quindi qualcosa si deve pur fare.
E allora i gestori del pallone, che in buona parte coincidono con i gestori del Paese – oppure da essi strettamente dipendono in filiere sempre più corte – sono costretti a chiedere agli arbitri un piccolo favore: per far rimbalzare la palla come da regolamento le giacchette giudiziarie, il terminale in calzoncini della giustizia sportiva che si regge sul concetto di lealtà secondo le carte federali, devono cercare il duro ovunque si trovi, anche per centimetri quadrati. In tutte le zone del campo, centrali o anche periferiche, magari nei punti vicini alle bandierine del corner, o addirittura in quelle fasce a bordo campo chiamate dal leggendario Sandro Ciotti il «campo per destinazione».
Non mi meraviglierei che prima o poi, ma temo di questo passo assai presto, il direttore di gara di turno, pur davanti a una superficie visibilmente e completamente putrefatta, sarà obbligato dalla necessità e dal business a far rimbalzare il cuoio plastificato nella piccola area tecnica di fronte alle panchine, dove per regolamento agli allenatori è permesso muoversi e agitarsi senza debordare... Cosicché si potrà sempre affermare, in regime di semi-verità, che il pallone rimbalza, il campo dunque è agibile e la partita si può giocare.
La lunga metafora può essere immediatamente comprensibile se si ripensa a quella domenica di maggio del 2000, anno del Giubileo, in cui si disputò Perugia-Juventus, ultima partita di campionato, decisiva per lo scudetto. Si giocò comunque, nell’impraticabilità quasi assoluta (nel «quasi» c’è tutto del calcio di oggi), dopo una pausa per l’uragano durata oltre ogni immaginabile proroga. L’arbitro era quello che sarebbe stato giudicato il miglior arbitro del mondo, Pier Luigi Collina, lo stesso poi intercettato e documentato nei suoi incontri con il tal Meani dello scandalo di Calciopoli, un ristoratore uomo di Galliani e da lui contrattualizzato perché seguisse i rapporti con gli assistenti di linea da parte del Milan. Lo stesso poi diventato designatore arbitrale dei fischietti nostrani a cifre folli, benedette dalla Federcalcio, così da «viziare» il mercato degli arbitri dall’alto in basso. Lo stesso poi passato a ottimo incarico UEFA.
L’obiezione di chi legge, sapendo come andò a finire quella partita – con la Juventus perdente e la Lazio di Cragnotti pre-galera campione d’Italia – è che in fondo in qualche modo era stata ridistribuita una fetta di torta, dopo anni in cui la squadra di Agnelli ne era stata consumatrice vorace. Che un arbitro disponesse molto discutibilmente (eufemismo!) del suo libero arbitrio per restituire ad altri un po’ del cosiddetto «maltolto» nell’egemonia juventina, raramente scalfita nella decade a cavallo del secondo millennio, sembrò al tifo italiano anti-juventino e alla vox populi una specie di rifusione.
Come fosse avvenuta, importò poco. Non si è sempre detto – io credo truffaldinamente – che alla fine (di un campionato, di una stagione, di un lasso di tempo) «nel calcio torti e ragioni si compensano»? E perché dovrebbero compensarsi, mi domando io, in base a quale criterio razionale, filosofico o manzonian-provvidenziale? Forse nella vita succede così? E allora perché dovrebbe accadere nel calcio?
Per raccontare quello che sta succedendo in questo periodo alla Rotondocrazia italiana, al regno della sfera e del tifo assediato dal nuovo scandalo di «Scommettopoli» (chiedo perdono per la scarsa fantasia neologistica... usando il termine per chiarezza, brevità e informazione «pubblicitaria») si potrebbe dunque partire da lontano, da ben prima del 1982 da cui prende le mosse la ricostruzione «storica» di quasi un quarto di secolo che troverete qui, più avanti. Oppure da vicino, da molto vicino, dalla cronaca più recente, che mi ha suggerito la metafora del campo pressoché impraticabile.
Il terreno di gioco impraticabile
In questa metafora ci sono vari elementi che concorrono a rendere lo stato-stadio del pallone comatoso. Gli attori attivi in campo, cioè giocatori, tecnici, arbitri e loro assistenti, quelli del «è fuorigioco, ma di pochissimo...»; gli attori attivi fuori campo, cioè le dirigenze dei club e il potere politicocalcistico, collegati o coincidenti con i tycoon delle TV e dei diritti televisivi grazie ai quali il calcio di vertice continua a vivere da finto nababbo al di sopra dei propri mezzi. E poi gli attori passivi da stadio e da bar-salotto TV, ossia il popolo italiano, popolo di tifosi che ormai da un pezzo ha esportato in altri campi, fuori dallo stadio e fuori dal pallone, una mentalità tifosa che sta conducendo al collasso il sistema-Paese.
Voglio dire che un conto è tifare per la Juve, il Milan o la Roma, e quindi per antonomasia venir accecati, o almeno spesso ottenebrati nella vista, dal tifo, esattamente il contrario dell’equilibrio e della razionalità di un vivere civile, un altro conto è trasferire il tifo dalla squadra del cuore e del fegato allo schieramento politico, al maggioritario del potere, al derby delle curve giornalistiche.
E nella metafora di un calcio ormai soprattutto televisivo rientra alla perfezione anche l’idea che comunque debbano giocare, con un calendario di tutti i giorni e di tutte le ore, in Italia e in Europa, e quindi che la praticabilità di un campo non sia più una condizione sine qua non, imprescindibile, ma una variabile da riassorbire negli interessi circostanti, che premono assai di più della «rimbalzabilità» della palla.
L’importante è il prodotto TV, il pubblico di telespettatori, di consumatori, di tifosi, che chiama pubblicità in base ai grandi numeri. È l’indotto che prevale sulla partita, sulla sua regolarità, sulla trasparenza del calcio, sulla credibilità di tutto un mondo rotondologico che ancora va avanti, in qualche modo, sempre più a fatica, ma va avanti.
Almeno in queste pagine di aggiornamento, però, invece che da lontano come ho già fatto nell’indagine sul pallone contemporaneo, ripartirò da vicino, da vicinissimo, dalla cronaca. E vi anticiperò l’identità dell’assassino, se convenite che nei confronti del calcio si sta compiendo una sorta di delitto, un omicidio alla moviola della passione «più bruciante» degli italiani. Obietterete che non è da buon giallista svelare l’assassino fin da subito: è come togliere suspense alle indagini del Montalbano di turno (e a proposito, Manuel Vásquez Montalbán, fenomenale scrittore catalano, da cui Camilleri ha derivato l’onomastica del suo «eroe», era un appassionato /addolorato di calcio...).
Avreste ragione se non si trattasse di un delitto speciale, di genere culturale o antropologico, di un peggioramento della vita degli italiani (è un fenomeno planetario, certo, la corruzione nello sport in virtù del Dio Mammone, ma qui stiamo alla rotondolatria nostrana), di un’offesa alla ragione.
Quindi subito la meccanica e il processo dell’omicidio, e l’identità finale di mandanti e sicari, spiegandone le ragioni. Poi seguiranno molte voci di un discorso che introduce la parte diciamo così «storica» che sorregge anche gli ultimi anni: Indagine sul calcio, pubblicato nel 2006, arrivava infatti fin sulla soglia di Calciopoli, erroneamente chiamata Moggiopoli, e alla vigilia di un Mondiale poi quanto mai opportunamente vinto da un’Italia pallonara (e politica) altrimenti in gramaglie per «lo scandalo più grave della storia del calcio», come cinque anni fa venne sbrigativamente definito.
Il calcio, da sempre e naturalmente con sensibili variazioni generazionali, è una formidabile arma di distrazione di massa, è uno sfiatatoio di umori, un modo di occupare tempo e cervelli, di devitalizzare preoccupazioni e problemi, sociali, economici, e quindi più in generale politici. Questo vale per l’Italia come per molti Paesi del mondo e anzi vediamo come l’Affare Rotondo stia colonizzando nuovi mercati, in Africa (Mondiali 2010) e in Oriente in passato. Aspettiamo la Cina, visto che il Qatar sembra già fissato per l’edizione del 2022.
Da queste premesse parrebbe evidente che un Paese che ha i nostri problemi economico-sociali, e una governance politica in disfacimento, avrebbe tutto l’interesse a far funzionare almeno il calcio: così il tifo dilaga, si rapprende, si giustifica, si rafforza, e l’arma di distrazione di massa funziona alla grandissima. Invece, come leggerete e come già sapete dall’istantaneità delle notizie che, giorno per giorno, scacciano dalla memoria quelle «vecchie» e dissolvono qualunque ipotesi e desiderio di visione d’insieme, sta capitando proprio il contrario.
Nonostante i tentativi di depistaggio e di insabbiamento di cui parleremo e di cui documento il passato e le radici nelle pagine seguenti, questo ulteriore scandalo legato alle scommesse certamente toglie credibilità e presentabilità a tutto il sistema pallonaro. Dunque danneggia il potere politico che rischia di ritrovarsi un’arma (di distrazione di massa) appunto danneggiata, anche se ancora funzionante.
Perché allora lo permette, perché, insomma, a quanto pare, i padroni del pallone si stanno dando la zappa sui piedi? È un potere stupido e miope?
La classe dirigente nel pallone
Sembrerebbe di sì, ma sarebbe una risposta banale, superficiale. Ve ne aggiungo altre due. La prima – a grandi linee, per brevità – è che per lo più il potere politico e il potere politico-sportivo coincidono o hanno coinciso ormai da molto tempo. Per dare l’idea, basterebbe il caso di quello che è, da una ventina d’anni, l’uomo più potente e più ricco d’Italia: Silvio Berlusconi. Quello che da un quarto di secolo è il lungimirante proprietario del Milan dopo aver provato in precedenza ad acquistare l’Inter (è un uomo d’affari, e se ne intende di calcio...).
Ma sono in molti i membri della classe dirigente del Paese intesa nel suo complesso, quindi non solo la politica ma l’imprenditoria, la finanza, le banche... (da Moratti a Della Valle e senza fermarmi agli eredi Agnelli), a comparire nella duplice veste di gestori di settori più o meno ampi del sistema-Italia e di feudatari dell’italico pallone. Quindi non dovrebbe sorprendere che nella più estesa palude italiana non si avverta l’allarme e la contraddizione del «rettangolo di gioco» di cui parlavo all’inizio: sono gli stessi, perché dovrebbero essere migliori e più avveduti nel pararsi populisticamente le terga grazie al calcio, oppio di un’opinione pubblica toccata assai più dal tifo («la Roma è una fede...!») che dalla passione politica, poi travasata, come dicevo, in tifo (oppure in investimento personale, ma è discorso differente che lascio ad altra occasione)?
E infatti non lo sono, e quindi campo ridotto a una poltiglia, proporzionato a un Paese paludoso, per Caimani...
Ma c’è una seconda risposta, a mio avviso, alla domanda sul perché non capiscano che far funzionare bene o meno peggio il calcio dovrebbe loro convenire per «ingannare il tempo, mentale e materiale» degli italiani. Ed è che, almeno finora, nel ventennio culturalmente più arretrato del dopoguerra, il calcio ha riempito ogni interstizio di ragionamento e di critica, emanando dosi industriali di tifo, raccogliendo deleghe umorali, proponendosi come una dimensione atemporale di cui il Paese pareva non poter fare a meno.
Giacché all’orizzonte non c’era (e forse non c’è) qualcos’altro di circense che potesse supplire a un pallone che non rimbalza quasi più, questa opinione pubblica ha rimosso e rimuove (ah, se rimuove!) disperatamente quella parte del calcio che è rappresentata dalle «cattive notizie», che ci dicono di come il campo sia sempre più impraticabile e il calcio che fanciullescamente ricordavamo e vorremmo frequentare ancora pressoché svanito.
Gli italiani che da cittadini immaturi e da consumatori lobotomizzati hanno assistito al declino del proprio Paese, nella loro veste di tifosi, di appassionati, di curiosi o di distratti, si sono fatti piacere il calcio com’era o com’è diventato, in mancanza d’altro. Triste, non è vero?
Recitano una parte, come gli attori attivi in campo di cui parlavo. Truccano le partite così da garantire le vincite al banco delle scommesse? E il tifoso non solo si è bevuto partite truccate, mascherate nella loro incredibilità dall’alea famosa di «la palla è rotonda», ma non vede l’ora che lo scandalo finisca, possibilmente che la squadra avversaria, che è stata promossa, venga penalizzata o retrocessa ma soltanto perché ci guadagni qualcosa la squadra propria, e che al più presto il calciomercato e il calcio giocato mettano in fuga scandalosi fantasmi.
C’è dunque un colossale concorso di colpa in questo delitto urbi et orbi della sfera pallonara: chi gestisce il Paese e indirettamente o direttamente il calcio è responsabile di una mala gestione; gli addetti ai lavori sanno ma tacciono in un’omertà di fondo che sembra loro, per debolezza, connivenza, conformismo o anche semplicemente totale assenza di spirito civico e invece acquiescenza a una «mafiosità» ambientale di fondo; gli italiani passivi non vogliono sapere e se costretti a sapere vogliono dimenticare in fretta. Aiutati in questo dalle enormi responsabilità spesso sfociate in vera e propria colpa mostrate dai mass media, ponte sospetto tra il potere e il tifoso che serve il primo e adopera il secondo.
Tutto ciò ha prodotto l’«impraticabilità di campo», mentre immagino metaforicamente e quasi fisicamente l’arbitro di turno che, seguito dalle squadre, entra sul terreno devastato dal maltempo (che travolge etica e legalità) e cerca un lembo di campo dove far rimbalzare un pallone, così da fischiare un inizio che è piuttosto una fine...
E pensare che non sarebbe obbligatorio che le cose andassero così: basterebbe voler davvero recidere la malapianta e seminare germogli sani. Da amante del calcio, credetemi, mi piange letteralmente il cuore.
La palla è quadrata
Calciatori, ex calciatori, medici e allibratori arrestati, altri indagati: ecco cosa c’è nei faldoni che si accumulano nella Procura di Cremona da molti mesi, fino alla deflagrazione degli arresti e degli avvisi di garanzia alla fine di maggio 2011.
Ovviamente in attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso nei tempi brevi, indispensabili perché il baraccone non si fermi. È il nuovo scandalo dai contorni quotidianamente rivisti di «Scommettopoli» che ha riempito i media, poi è tornato sotto traccia. A breve forse si capirà di quale fenomeno si tratti e quali dimensioni abbia assunto.
Della giustizia sportiva dirò più avanti, essendo cruciale il suo ruolo in questo come in tanti, se non in tutti, gli scandali del calcio (anche negli altri sport non hanno troppo da ridere: il doping che è fiorito un po’ ovunque grazie alla tolleranza delle stesse autorità, italiane e internazionali, che con un occhio guardavano con favore e complicità al business dello spettacolo sportivo e con l’altro all’antidoping per salvare la decenza o l’apparenza).
Ripartiamo dalle scommesse. E dal carcere, o dagli arresti domiciliari, cioè da situazioni in cui spesso se uno non è un delinquente incallito magari parla, poi rinnega, ma alla fine fornisce agli inquirenti delle importanti chiavi di lettura. Preziose per la Procura di Cremona, o per quella di Napoli che ha altra indagine in corso da tempo su «Camorra & scommesse» anche sul pallone. Ma chiavi di lettura per certi versi ancora più efficaci per la giustizia sportiva, che non lavora sul penale bensì sul concetto di correttezza sportiva, che è elemento fondante, architrave di qualunque disciplina.
Non c’è agonismo senza regole etiche, la lealtà è imprescindibile, basta il sospetto per condannare nella cittadella dello sport altrimenti, invece che agonista, agonizzante. Questo però impone a chi indaga e a chi giudica di essere integerrimo, davvero al di sopra di ogni particella di sospetto, proprio per essere all’altezza di questa forma di giustizia istantanea che chiamiamo sportiva. Il paradosso è che abitualmente si è frettolosi e magari giusti (ma parziali) giacobini nel giudicare, mentre si è permissivi, obliqui, opachi nei comportamenti e nelle decisioni: il che sbarella tutta la faccenda, tra imputati e giudici. Niente di nuovo: è l’antica questione, da Giovenale in poi: «Quis custodiet ipsos custodes», chi sorveglia i sorveglianti.
Le scommesse, allora. Il giro di denaro è vertiginoso e quelle sul calcio in Italia la fanno da padrone. Ovviamente le centrali sono nei patri confini come all’estero, e c’è un esotismo romanzesco anche in questo. Dunque non è semplicemente uno scandalo italiano, e scommettere – al di là della già grave dipendenza che basterebbe da sola ad attivare un allarme sociale e della penetrazione delle mafie nel settore che vi sono entrate come nel burro, specie la camorra –, non è un reato.
Per raccogliere le scommesse però, dalla legge del 1998, c’è bisogno di una concessione statale e questo vale anche per eventuali agenzie straniere in corrispondenza ormai diffusamente via web con le ricevitorie italiane. È esattamente il contesto dell’inchiesta di Cremona sventolata sui media.
Nell’80 invece, quando scrivendo per «Repubblica» tirai fuori il primo scandalo del cosiddetto Totonero che portò all’arresto in flagrante negli stadi di giocatori famosi come Paolo Rossi, Bruno Giordano, Lionello Manfredonia e altri, le scommesse erano clandestine. Fuori legge. C’era da difendere il Totocalcio che reggeva tutto lo sport italiano attraverso la storica schedina nata nel secondo dopoguerra (Sisal), e le scommesse erano un’acuminata spina nel fianco anche dello Stato, supremo esattore delle giocate.
Ma non c’era una legge che regolasse il settore, e quindi penalmente in assenza di reato per truffa sportiva per tutta la sfilza dei coinvolti (Enrico Albertosi, Carlo Petrini e dirigenti come Felice Colombo presidente del Milan ecc.) ci fu un’assoluzione generale, a partire dai due fantastici «cervelli» dell’operazione, tal Trinca ristoratore e tal Cruciani, grossista di frutta e verdura, che sollevò lo scandalo presentando un esposto alla magistratura contro i giocatori che l’avrebbero raggirato, ovviamente essendo la Federcalcio all’oscuro di tutto... L’unica condanna fu per assegni post-datati.
Invece la giustizia sportiva menò e squalificò, salvo ridurre la pena da tre a due anni per esempio a Paolo Rossi che poi benedisse l’operazione di «riverginizzazione pallonara» guidando l’Italia di Bearzot, di Pertini e di Craxi al titolo Mundial di Madrid, nel 1982, e da capocannoniere. Un Mundial anche allora percorso dalle scommesse, un Mundial equivoco sul quale venne steso un telo, o un velo, come sempre o quasi.
Per dire che non si inventa niente, e che allora come oggi la palla non era più tanto rotonda ma casomai squadrata come il perimetro di una cella.
Solo che oggi le scommesse sono appunto legali, il fenomeno è planetario da un pezzo e il meccanismo disonesto risulta più o meno lo stesso: qualcuno convince qualcun altro a dare dei risultati sicuri, come nell’ippica le cui sale corse risentono infatti tantissimo della lievitazione del «betting» pallonaro.
E per farlo bisogna pilotare il risultato: quello finale, quello di un tempo, il primo o il secondo, quello del numero di gol... Si scommette perfino live, cioè durante la partita, mentre al casinò a quanto mi risulta c’è ancora un croupier che dice «rien ne va plus». E la pallina corre. Qui corre il pallone, e intanto ci si scommette sopra.
Scommettere o truccare
È ovvio che soprattutto chi scommette forti cifre vuole avere delle probabilità di vittoria. Qualcuno addirittura la certezza: l’inghippo, il reato, la frode, la truffa nei confronti degli scommettitori corretti che possono venirne fregati, consistono nel far andare una partita in una direzione prestabilita, così da essere certi che la somma scommessa tornerà a casa in forze.
Chi volete che trucchi una partita, allora, se non chi la gioca, oppure la dirige? Quindi è evidente che senza complici una partita predeterminata non esiste, oppure si affida all’alea, ma allora rimaniamo nel consentito, o ancora dilaga nel millantato, con le conseguenze di cui si parla sui giornali.
Chi ha avuto una fonte ritenuta sicura, e ha scommesso e fatto scommettere delle fortune (mi dicono di un importante giocatore italiano che nella stagione scorsa ha scommesso 500 mila euro su un risultato... e ha vinto), se la partita non va nel verso garantito poi ha qualc...