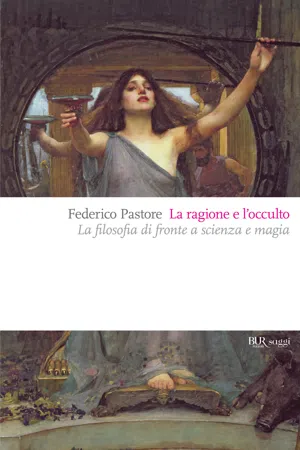1. Introduzione al problema della magia.
Definizione storica della questione e criteri dell’analisi
La Grecia classica, e di conseguenza la nostra cultura occidentale, deve il termine «Mago» («Magi» al plurale) a Erodoto, che lo usa molto spesso nelle sue Storie. Con il termine «Μάγοι» (plurale di «Μάγος», da cui «Μαγεία», «magia») Erodoto traslitterava la parola iraniana «magush», e indicava una delle sei tribù in cui era divisa la Media:
Il popolo dei Medi fu il solo che Deioce riuscì a unificare e a sottomettere al suo dominio. Ma parecchie sono le tribù che esso comprende: Busi, Paretaceni, Strucati, Arizanti, Budi, Magi.
Secondo quanto dice nelle Storie, i Magi erano i re-sacerdoti dello Zoroastrismo, dediti allo studio dell’astronomia e dell’astrologia, dell’interpretazione dei sogni e della divinazione. Erodoto li descrive come perfettamente e profondamente inseriti nella situazione politica dell’impero persiano e li definisce uomini differenti da tutti gli altri, soprattutto dai sacerdoti egiziani:
I Magi sono molto diversi dagli altri uomini e anche dai sacerdoti egiziani: mentre questi ultimi ritengono un atto impuro uccidere qualunque animale, eccetto quelli che immolano per i sacrifici, i Magi possono uccidere di propria mano ogni essere vivente, tranne il cane e l’uomo; e reputano gran cosa poter dare la morte ugualmente alle formiche, ai serpenti e agli altri animali della terra e dell’aria.
In Erodoto tuttavia non compare mai il termine «Magia», ma soltanto quello di «Magi» o, al singolare, di «Mago», e sempre, comunque, come individuazione non di un’attività, ma dell’appartenenza a una tribù, esattamente come il termine «Magia» non appare mai nei canti «magici» (i quattro canti, la cui analisi costituirà il primo capitolo di questo lavoro, che vanno dal IX al XII) dell’Odissea: Omero non definisce mai «maga» Circe, le attribuisce soltanto la patente di «esperta di filtri» e la capacità di tramutare gli uomini in animali e comunque di soggiogarli al suo volere, e questo in accordo con tutta una tradizione fiabesca e culturale a cui il poeta attinge.
In realtà il termine «Magia», come termine connotativo generale dei saperi e delle attività dei sacerdoti che erano membri della tribù dei Magi nella Media del tardo impero persiano, e il cui compito era precisamente quello di fornire l’interpretazione di segni e di presagi, come appunto sogni o fenomeni celesti, permettendo un adeguamento del comportamento a probabili eventi futuri, è un termine più tardo: probabilmente nasce intorno al IV secolo a.C. I Magi, dunque, secondo Erodoto, erano uomini in possesso di un sapere iniziatico, che permetteva loro di penetrare i misteri di una natura che «ama nascondersi», secondo il celeberrimo frammento di Eraclito, ma che, pur nascondendosi, fornisce indizi che permettono di conoscerla e di interpretarla, e perciò, anche, non secondariamente, di utilizzare le conoscenze così acquisite per se stessi.
La scienza che si è occupata a fondo del problema della magia, come tentativo di istituire un rapporto con una natura considerata «animata», cioè dotata di virtualità riconducibili all’azione di principi vitali all’interno della natura è senz’altro l’antropologia culturale. Secondo gli antropologi la magia è il primo approccio da parte dell’uomo al mondo esterno a lui. Una delle prime ipotesi riguardo la magia e il suo sorgere è quella che individua la magia come un fenomeno strettamente legato alla religione di cui costituirebbe una sorta di manifestazione anteriore e più immediata: in questo senso, allora, la religione sarebbe il risultato di una sorta di evoluzione dal concetto magico-animistico della natura. Secondo questa teoria, che, com’è noto, fu elaborata dall’antropologo britannico Edward Burnett Tylor, a uno stadio primitivo di sviluppo i membri di una società tendono ad attribuire a ogni fenomeno naturale e, in generale, a tutta la realtà circostante un principio incorporeo e animato, di grande potenza, che ne determina il comportamento. Ciò diventa particolarmente importante e significativo nel momento in cui questo principio animato presente nella natura si esplica o interferisce con le attività o con le condizioni fondamentali per la sopravvivenza, quali la caccia, la coltivazione dei campi, i fenomeni atmosferici, la costruzione di un riparo, la perpetuazione della specie. Da questo punto di vista la magia pertanto è il patrimonio di conoscenze intorno a quest’anima naturale e, contemporaneamente, le operazioni rituali che devono essere approntate sulla base di queste conoscenze, per ingraziarsi quest’anima o, perlomeno, per ottenerne la neutralità. Sempre secondo Tylor, è su questa base magica che sorge la religione, o, ancora più precisamente, la concezione magico-animistica della natura costituirebbe la «definizione minima di religione», una sorta di «minimo comun denominatore» da cui gli uomini primitivi muovevano per cercare di spiegare tutti quei fenomeni che sfuggivano alla loro comprensione.
È impossibile, ovviamente, dare qui un panorama anche soltanto succinto del dibattito sviluppatosi intorno alle teorie di Tylor e delle posizioni che altri antropologi, come ad esempio, il suo allievo Robert Ranulph Marett, sostennero in seguito; si può però accennare al fatto, senza volerci addentrare in una discussione estremamente complessa e tecnica, che Marett contestava al suo maestro Tylor la priorità dell’animismo come forma primordiale di religiosità, a favore di un preanimismo inteso come credenza in una potenza trascendente, precedente all’immanenza animistica, che lo porterà a individuare nel mana melanesiano il prototipo di tutte le entità trascendentali in cui l’uomo ha riposto le sue credenze. Certamente, però, come hanno messo bene in luce gli studi antropologici, è da respingere qualsiasi interpretazione che individui nella concezione animistica un momento precedente il sorgere della religione, che farebbe la sua comparsa a mano a mano che progredisce la consapevolezza dell’oggettività dei fenomeni naturali e, dunque, la loro conoscenza, come se la religione fosse una risposta in qualche modo scientifica alla superstizione della magia, a cui poi, necessariamente, dovrebbe seguire un ulteriore progresso in cui la religione verrebbe a occupare uno spazio differente da quello occupato dalla scienza naturale. Esattamente allo stesso modo non regge neppure l’interpretazione simile, ma di segno opposto, secondo la quale la magia sarebbe la conseguenza dello smarrimento di un monoteismo originario, una sorta di sapere unitario e primordiale in dote all’umanità, a favore di un’interpretazione della natura in senso animistico, e cioè nella linea dell’analisi settoriale di una realtà parcellizzata, dalla quale poi l’uomo muoverebbe successivamente, percorrendo un cammino inverso e in qualche modo coincidente con quello descritto appena sopra, verso la riconquista del monoteismo. In realtà è facile constatare come questi processi non siano assolutamente lineari: all’interno di religioni anche molto sofisticate, come la religione cattolica, accanto a concetti di grande spessore dottrinale e teorico permangono e convivono credenze e ritualità che richiamano molto chiaramente concezioni magiche e animistiche secondo le quali determinati oggetti hanno, per virtù propria o per virtù acquisita, poteri particolari, che possono essere messi a disposizione attraverso la celebrazione di liturgie che soltanto pochi iniziati conoscono e sono titolati a mettere in atto. Un caso particolarmente tipico è quello che, ancora al giorno d’oggi, è presente in alcune zone anche del nostro Paese e, più in generale, nelle zone a cultura contadina, per cui un rimedio naturale, a base di erbe, funziona soltanto se è somministrato da una determinata persona, in un determinato momento del giorno e se la sua somministrazione è accompagnata dalla recitazione di formule, che soltanto qualche persona, in genere di sesso femminile, conosce e il cui scopo, assolutamente magico, è quello di attivare i principi curativi, che altrimenti resterebbero inerti. Oppure al culto delle reliquie, o a quello dei santi guaritori, o allo stesso calendario, che altro non sono se non persistenze di dottrine magico-animistiche e di culti dei morti, che non solo convivono, ma che addirittura sono state inglobate all’interno di una dottrina assai più complessa e articolata.
Vorrei terminare questo brevissimo excursus sulla magia dal punto di vista dell’antropologia culturale cercando di mettere in luce come la magia – intendendo per magia il complesso di dottrine e i riti che vengono compiuti per assoggettare alle proprie necessità la natura – non possa essere compresa se non si mette in un preciso rapporto di relazione con una gerarchizzazione dei ruoli all’interno della società. In sostanza, la magia svolge anche un ruolo di controllo sociale, che, da una parte, garantisce la stabilità della società e, dall’altra, crea il contesto in cui le azioni del mago possono essere compiute e avere successo. Dobbiamo a Ida Magli l’introduzione nell’antropologia culturale italiana della categoria della potenza, intesa come il processo attraverso il quale l’uomo proietta al di fuori di sé, oggettivandola, una forza che egli intuisce e sperimenta come esterna e infinitamente più potente di lui. Questa categoria permette di comprendere e di spiegare, se non totalmente, almeno in buona parte un vastissimo àmbito di comportamenti umani e di sensazioni, che vengono vissuti in maniera assolutamente «naturale», ma che, invece sono ricchi di significati reconditi che spesso sono stati rimossi: si pensi, ad esempio, alla sessualità, che esprime in tutte le società e in tutti i periodi storici la sua potenza attraverso un’ampia serie di norme tabuizzanti e repressive, ma si pensi anche alla parola, nel momento in cui la sua pronuncia viene rivestita di sacralità, come nel giuramento, nelle profezie, nella bestemmia, nella parola che Johannes, guarito dalla sua follia, pronuncia sulla bara della moglie del fratello maggiore morta di parto, facendola resuscitare. E proprio alla categoria della potenza va fatta risalire l’inutilità della domanda se la magia funziona oppure no, se produ...