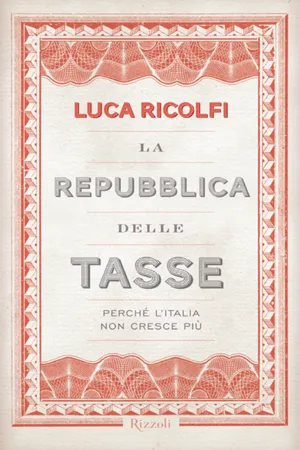![]()
Perché le tasse sono nemiche della crescita
Le due facce dell’evasione
Da qualche mese a questa parte il tema dell’evasione fiscale è tornato alla ribalta. Ma è un ritorno strano. A differenza di un tempo, neanche poi tanto remoto, in cui la lotta all’evasione fiscale era una bandiera della sinistra, mentre la destra mostrava una certa indulgenza, oggi il tema dei miliardi (oltre 120) sottratti ogni anno al fisco è diventato uno strumento di agitazione politica universale. Lo usa come sempre l’opposizione di sinistra, ma lo usa anche la Chiesa per impartirci lezioni di moralità, lo usano gli indignati di ogni colore politico, lo usa la destra di governo alla disperata ricerca di soldi per tappare le falle dei conti pubblici. Accade così che, poco per volta, alle preoccupazioni per i sacrifici che le recenti manovre ci impongono si mescoli e si sovrapponga un malessere sordo, una specie di risentimento, che alimenta un clima vagamente maccartista, di moderna caccia alle streghe. Gli evasori sono visti sempre più come la causa di tutti i nostri mali, la loro individuazione diventa una missione morale, e ci capita persino di vedere un governo di destra – che ha sempre strizzato l’occhio all’evasione – accarezzare l’idea di fare gettito mediante la delazione.
Meno male, verrebbe da dire. Era ora, finalmente ci decidiamo a combattere questa piaga. Quando avremo vinto questa battaglia, l’Italia sarà finalmente un Paese civile e prospero.
E invece, su questa visione dei nostri problemi, vorrei insinuare qualche dubbio. Se quello che vogliamo è solo sentirci migliori del nostro vicino, la caccia alle streghe va benissimo. Ma se per caso il nostro sogno fosse anche di rimettere in carreggiata l’Italia, quella medesima caccia andrebbe reimpostata radicalmente. Perché l’evasione è un fenomeno che va innanzitutto spiegato e compreso, prima di combatterlo a testa bassa. Altrimenti la testa rischiamo di rompercela noi, anziché romperla (metaforicamente) agli evasori.
In Italia l’evasione fiscale ha due facce. La prima è quella che fa imbestialire i lavoratori dipendenti in regola: c’è chi potrebbe benissimo pagare le tasse e non lo fa semplicemente perché vuole guadagnare di più. Questo tipo di evasione, da mancanza di spirito civico, si combatte con due strumenti: più controlli e aliquote ragionevoli. Se la si combatte solo con più controlli, il risultato è prevalentemente un aumento dei prezzi, come sa chiunque abbia a che fare con idraulici e ristoratori. Detto per inciso, è il ragionamento che – implicitamente – fanno milioni di cittadini di fronte alla domanda: preferisci pagare 100 senza fattura o 140 con fattura?
C’è poi un secondo tipo di evasione fiscale, di sopravvivenza o di autodifesa. È l’evasione di quanti, se facessero interamente il loro dovere fiscale, andrebbero in perdita o dovrebbero lavorare a condizioni così poco remunerative da rendere preferibile chiudere l’attività. In questo caso quel che serve è innanzitutto una drastica riduzione delle aliquote che gravano sui produttori, altrimenti il risultato della lotta all’evasione è semplicemente la distruzione sistematica di posti di lavoro, un’eventualità che peraltro si sta già verificando: le regioni in cui Equitalia ha ottenuto i maggiori successi sono le stesse in cui ci sono stati più fallimenti (vedi il dramma recente della Sardegna).
Immagino l’obiezione a questo ragionamento: «It’s the market, stupid!». Detto altrimenti: è un bene che nei periodi di crisi ci siano fallimenti, perché questo significa che il mercato riesce a far uscire le imprese meno efficienti, e a sostituirle con altre più dinamiche e competitive. Ma questa obiezione, che si basa sul concetto schumpeteriano di «distruzione creativa», vale solo se i regimi fiscali sono comparabili e ragionevoli. Oggi in Italia ci sono aziende in crisi che starebbero tranquillamente sul mercato se il nostro Ttr (Total Tax Rate) fosse quello dei Paesi scandinavi, e simmetricamente ci sono floride aziende scandinave che uscirebbero dal mercato se le aliquote fossero quelle dell’Italia. Il mercato è un buon giudice dell’efficienza solo se le condizioni in cui le imprese operano sono comparabili. E in Italia le condizioni in cui le imprese sono costrette a operare sono così sfavorevoli per tasse, adempimenti e infrastrutture, che la domanda vera non è «Perché le imprese italiane arrancano?», bensì «Perché ne sopravvivono ancora così tante?».
Ecco perché l’idea di risolvere i nostri problemi intensificando la lotta all’evasione fiscale andrebbe maneggiata con cura. Quello di far pagare gli evasori non è solo il sogno degli onesti, ma è l’ultima zattera con cui un ceto politico che non sa più che pesci pigliare cerca di salvare se stesso e sfuggire alle proprie responsabilità. Incapaci di varare le riforme promesse, inadatti a prendere qualsiasi vera decisione, irresoluti a tutto, i nostri politici, di governo e di opposizione, hanno trovato nell’evasore fiscale il capro espiatorio con il quale distrarre l’opinione pubblica.
Ma è un grande inganno. Se la lotta all’evasione viene condotta unicamente per aumentare le entrate è inevitabile che essa produca effetti recessivi: disoccupazione (specie al Sud), aumenti di prezzo, contrazione dei consumi. E inoltre nulla assicura che l’obiettivo di far cassa venga raggiunto: quando la pressione fiscale sui produttori è già altissima (e quella italiana lo è: nessun Paese avanzato ha un Ttr più elevato), non è detto che il gettito che si recupera grazie a nuovi balzelli e più controlli superi il gettito che si perde a causa dei fallimenti e dei passaggi all’economia sommersa. Tanto più in un periodo come questo, in cui è già in corso una drammatica riduzione della base produttiva.
Se però ogni euro recuperato dall’evasione fosse destinato – per legge – a rendere meno difficile la vita a lavoratori e imprese, allora otterremmo almeno due risultati, uno economico e uno morale. Il risultato economico è che, poco per volta, i produttori di ricchezza che le tasse le pagano potrebbero finalmente rialzare la testa, consentendo all’Italia di tornare a crescere. Il secondo è che, con aliquote via via più ragionevoli, l’evasione fiscale non solo diverrebbe meno conveniente, ma perderebbe ogni giustificazione morale. Il «mostro» dell’evasione fiscale non ha un solo genitore, ma ne ha due. Ed è solo quando la mancanza di cultura civica (la madre) si sposa a un fisco oppressivo (il padre) che il ragazzaccio diventa un mostro.
Non possiamo più aspettare
Che sorprese ci riserva lo scenario economico nel nostro immediato futuro?
In parte non lo sappiamo e non possiamo saperlo. Non sappiamo se l’economia del pianeta si riprenderà in un tempo ragionevole, non sappiamo come finirà la guerra strisciante in atto fra le principali valute del mondo, e in particolare non sappiamo se l’euro si indebolirà, dando ossigeno all’export, o invece si rafforzerà ulteriormente, aggravando la crisi delle nostre imprese esportatrici.
Alcune cose invece le sappiamo. Sappiamo per esempio che l’Europa, non paga della stretta sui conti pubblici imposta nella primavera 2010, ci chiede ulteriori sacrifici, sotto forma di un piano pluriennale di riduzione del debito pubblico. Sappiamo anche che le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli (Stato, regioni, province, comuni) sono sommerse dai debiti e quindi ritardano sistematicamente i pagamenti, mettendo così in crisi i fornitori. Sappiamo anche che il ritardo nei pagamenti si propaga da impresa a impresa e che, combinato con la prudenza delle banche nel concedere credito, è una delle cause di molte crisi aziendali, con il loro triste seguito di cassa integrazione e licenziamenti. E sappiamo infine che il problema di fondo di molte aziende non è il costo del lavoro ma la debolezza degli ordinativi, che costringe a un sottoutilizzo della capacità produttiva, non di rado anticamera della chiusura definitiva. Insomma è il debito pubblico la nostra più grande palla al piede, ma è solo il ritorno alla crescita che può aiutarci a uscire dai nostri guai.
Che cosa può fare un governo in una situazione simile?
Assai poco, a mio parere, e considero un segno di grave immaturità delle opposizioni aver fatto credere alla gente che esistessero alternative serie ai tagli del governo Berlusconi: si può discutere a lungo della ripartizione dei tagli, ma quanto alla loro entità ci sarebbe semmai da chiedersi se possano bastare, e se alla prossima bufera finanziaria non si rischi di doverne fare di ancora maggiori.
Però, fortunatamente, ci sono anche alcune cose che si possono fare. Non solo le liberalizzazioni e le semplificazioni normative, di cui molto si parla ma che, nonostante siano a costo zero, procedono a passo di lumaca – chiunque sia al governo – e finora non hanno mai prodotto una riduzione significativa degli adempimenti delle imprese. Ma anche interventi più radicali, capaci di incidere rapidamente sulla crescita. Il primo è un drastico e generalizzato abbassamento delle imposte sui produttori, a partire da Irap e Ires, finanziato con un disboscamento della selva degli incentivi alle imprese, ivi compresi gli innumerevoli regimi fiscali agevolativi (una strategia spesso invocata da imprenditori e politici, e di recente ventilata dallo stesso ministro dell’Economia). È una cosa che si può fare subito, senza aspettare l’estenuante balletto di incontri, tavoli tecnici e negoziali, che inevitabilmente accompagnerà il sogno di qualsiasi ministro dell’Economia di ridisegnare il nostro fisco.
Il secondo intervento è un abbassamento, finanziato con parte dei proventi della lotta all’evasione fiscale, delle imposte che gravano sull’energia, che rendono proibitivo il prezzo del kilowattora italiano e pesano come un macigno sui conti delle piccole imprese, come più volte denunciato e documentato da Confartigianato (un’idea potrebbe essere quella di destinare a questo scopo una quota delle somme recuperate grazie alle nuove norme sulle compensazioni Iva).
Ma c’è anche un terzo intervento che potrebbe avere effetti benefici sulla crescita. Il governo potrebbe decidere, senza aspettare le tirate d’orecchi dell’Europa, di mandare un segnale di «virtuosità finanziaria» ai mercati internazionali, varando un piano ventennale di dismissioni del patrimonio pubblico (la quota collocabile sul mercato è di diverse centinaia di miliardi di euro). Privatizzazioni e dismissioni sono sostanzialmente ferme dal 2006, e questo a dispetto dell’impegno a farle ripartire sottoscritto nel programma elettorale del centro-destra. Rispettare quell’impegno avrebbe reso i conti pubblici dell’Italia meno vulnerabili alla speculazione internazionale, limitando i rischi di un innalzamento dei tassi di interesse sui nostri titoli pubblici. Ma avrebbe anche avuto un potente effetto di rassicurazione all’interno, verso famiglie e imprese, ove fosse stato accompagnato dall’impegno solenne a interrompere la deriva attuale, in cui la tenuta dei conti pubblici è assicurata da tagli e dilazioni dei pagamenti, in buona sostanza dal soffocamento dell’economia.
È realistica questa via? È davvero possibile, contemporaneamente, dare ossigeno alle imprese e aggredire il debito pubblico?
Difficile dirlo, ma due riflessioni mi inducono a credere che possa esserlo. La prima è che il patrimonio pubblico è dello stesso ordine di grandezza del debito (1800 miliardi) e la parte di esso che è effettivamente collocabile sul mercato non è affatto trascurabile (almeno 400 miliardi di euro secondo le valutazioni degli specialisti). Venderne una parte non basterebbe a portarci al 60% del Pil, come vorrebbero le regole europee, ma scendere sotto il 100% sarebbe già un grande risultato. Senza considerare che un contributo non irrisorio alla riduzione del debito pubblico potrebbero darlo anche sequestri e confische dei patrimoni della criminalità organizzata, il cui ammontare è sconosciuto ma presumibilmente non inferiore a parecchie centinaia di miliardi.
Ma la riflessione più importante è un’altra. Le strade alternative per tornare a crescere, ossia investimenti in capitale umano e federalismo fiscale, sono entrambe fondamentali, ma potranno dare i loro frutti solo fra una decina d’anni. Noi tutto questo tempo non l’abbiamo, o meglio non l’abbiamo più. Il nostro declino, relativo e assoluto, è iniziato 10 anni fa, intorno al 2001: non possiamo aspettarne altrettanti per invertire la rotta.
Rassegnati alle tasse
Il luglio 2011 è stato un momento importante per valutare le prospettive dell’Italia all’indomani della manovra-lampo voluta da Tremonti. Non è detto che i mercati siano i migliori giudici della bontà delle nostre politiche, ma non v’è dubbio che – finché non si saranno realizzate le utopie di chi sogna istituzioni economiche europee funzionanti – è con i mercati che dobbiamo fare i conti.
Le previsioni degli osservatori, in proposito, non sono state particolarmente ottimistiche. La manovra allestita in fretta e furia dal governo, e «responsabilmente» lasciata passare in tempi rapidissimi dalle opposizioni, non è piaciuta innanzitutto per la sua iniquità, ossia per la sua incapacità di distribuire in modo razionale e selettivo i sacrifici imposti, con l’aggravante – vero e proprio schiaffo in faccia ai cittadini – di avere ridotto al minimo quelli richiesti alla casta dei politici. Ma non è piaciuta nemmeno sotto il profilo della sua capacità di calmare i mercati e rassicurare gli investitori, ricostituendo un po’ di fiducia nel sistema Italia.
Quasi tutti gli analisti hanno individuato tre punti deboli della manovra. Primo: è di entità risibile nel 2011-2012, mentre diventa draconiana solo nel 2013-2014, il che significa che i suoi effetti certi sono minimi, mentre gli effetti significativi non sono certi (gli impegni del 2013-2014 molto difficilmente potranno essere onorati, visto che non si sa nemmeno chi dovrà farlo: dalla fine del 2012 saremo in campagna elettorale). Secondo: una componente della manovra, quella fiscale, non solo è spostata avanti nel tempo, ma è di contenuto sconosciuto, in quanto affidata a una delega fiscale. Terzo: la manovra è troppo incisiva dal lato delle entrate (tasse), e lo è troppo poco dal lato delle uscite (spesa pubblica).
Di qui il timore che la manovra ottenga il doppio effetto di non convincere i mercati, con conseguente innalzamento del costo del nostro debito pubblico, e di azzoppare l’economia, già sufficientemente in difficoltà prima della manovra. Non sono particolarmente ottimista sulla reazione dei mercati, che non mi paiono così ingenui da non accorgersi del bluff di un pacchetto inflazionato di semplici intenzioni future. È questa preoccupazione che ha indotto non pochi osservatori, anche di sinistra come Eugenio Scalfari, a invocare un significativo anticipo di sacrifici al 2011-2012.
Quanto al rischio che la manovra soffochi del tutto la crescita, il mio pessimismo è invece totale, e discende da un fatto (incontestabile) e da un’opinione, ovviamente discutibile. Il fatto è che nessun Paese sviluppato ha una pressione fiscale sui produttori alta come la nostra, una circostanza aggravata dagli elevatissimi costi dell’energia e dalla doppia zavorra degli adempimenti burocratici e dell’inefficienza della giustizia civile. L’opinione (discutibile, ma supportata da qualche evidenza empirica) è che il fardello che un Paese impone ai produttori – lavoratori e imprese – sia di gran lunga la causa più importante del suo ristagno. Molto, ma molto più importante di tutti gli altri fattori che, sotto la voce riforme mancate, vengono ritualmente elencati, e da cui a mio parere ci si aspetta troppo.
Vista da questa angolatura – quella della permanente mortificazione di chi produce ricchezza – la storia che ha portato a questa manovra-lampo è semplicemente agghiacciante. Ancora nel giugno del 2011 si dibatteva di riduzione della pressione fiscale, di un possibile ritorno del Pdl allo spirito originario del 1994. Poi si è cominciato a dire che la pressione fiscale non poteva scendere, ma che si poteva redistribuire il carico, spostandolo dalle persone (Irpef) alle cose (Iva), con ben poca attenzione al fatto che la crescita non dipende genericamente dalle «persone» ma da chi genera ricchezza, ossia lavoratori e imprese. E infine, nei giorni scorsi, ci si è arresi al fatto che le tasse non solo non potranno essere diminuite, ma dovranno salire. Nel giro di un mese un micidiale 1-2-3 si è abbattuto sulle prospettive dell’economia italiana, di cui – a me sembra – si continua a sottovalutare il problema centrale: a queste condizioni ci vuole una dose spropositata di coraggio per operare in Italia, come del resto mostra al di là di ogni ragionevole dubbio il livello risibile degli investimenti diretti dall’estero.
Ed è sorprendente, almeno ai miei occhi, che una tale sottovalutazione della crucialità del problema delle tasse, e della drammaticità della situazione di chi cerca di stare sul mercato, non provenga solo dagli attori da cui ce lo aspettiamo, ossia sinistra, sindacati, pubblico impiego, ma anche da settori importanti dell’accademia e del mondo economico-finanziario. Io leggo tutti i giorni «Il Sole 24 Ore», quotidiano vicino alla realtà delle imprese, e sono perennemente stupito dal profluvio di discorsi, inviti e ammonimenti a «fare le riforme» e dalla relativa rarità delle richieste di ridurre significativamente la pressione fiscale, quasi che uno strano cocktail di rassegnazione e senso di responsabilità nazionale avesse convinto gli stati maggiori dell’economia italiana che, per ora, su quel fronte nulla è possibile. E quando leggo che, davanti a una manovra tutta sbilanciata dal lato delle entrate, la presidente degli industriali dichiara che «abbiamo l’impressione che ci possa essere un aumento delle tasse», irresistibile mi si accende nella testa l’immagine di Titti, il canarino perennemente inseguito da Gatto Silvestro, che dice «Oh, oh, mi è semblato di vedele un gatto».
Insomma, la mia sensazione è che spesso anche chi fatica, compete e si batte ogni giorno per non far affondare la barca sia ormai da molti anni assuefatto a questo ceto politico, a questo Stato, e non percepisca fino in fondo il tasso di eroismo che oggi è richiesto in Italia a chi intende lavorare e produrre nella legalità, senza scorciatoie e protezioni politiche. Né mi sembra si possa escludere che la severità dei mercati nei confronti dell’Italia abbia anche qui una delle sue radici. Pensare che il debito pubblico si possa abbattere senza crescita, semplicemente azzerando il deficit, è già alquanto azzardato, ma pensare che la crescita possa ripartire con questo livello di pressione fiscale sui produttori lo è forse ancora di più. C’è solo da augurarsi che questa non sia la visione dei mercati, perché se lo fosse sarebbe ben difficile per l’Italia uscire dalla tempesta.
La crisi colpisce i forti
Se non abbiamo certezze sul futuro, quel che invece si può già tentare è un primo bilancio della crisi in Italia, a circa quattro anni dal suo inizio oltreoceano, quando nell’agosto del 2007 scoppiò la bolla dei mutui immobiliari americani.
Sull’impatto della crisi circola da tempo una diagnosi – accreditata da diverse e autorevoli istituzioni, dalla Chiesa alla Banca d’Italia – secondo cui la crisi avrebbe colpito soprattutto i deboli. Ma è davvero così?
Molti elementi fanno pensare il contrario. Il primo impatto della crisi, si ricorderà, fu di tipo finanziario, con il crollo dei titoli azionari: questo meccanismo colpì innanzitutto i ceti superiori, ben più esposti a questo genere di rischi di quanto lo siano i piccoli e medi risparmiatori. Poi, poco per volta, la crisi si estese all’economia reale, in alcuni casi distruggendo posti di lavoro, in altri casi congelandoli attraverso la messa in cassa integrazione di operai e impiegati. Ma chi furono i gruppi sociali maggiormente colpiti? I cittadini del Mezzogiorno o quelli del Nord? I lavoratori dipendenti o quelli indipendenti? Gli stranieri o gli italiani?
Qui i dati riservano diverse sorprese. Secondo la serie storica dell’Isae (l’Istituto di studi e analisi economica) le famiglie in difficoltà, quelle che «non arrivano a fine mese», sono da sempre più numerose al Sud che nel Nord, ma durante la crisi sono aumentate più al Nord che al Sud, con conseguente riduzione del divario. La crisi sembra dunque aver ridotto le diseguaglianze territoriali, probabilmente anche grazie alla social card, il cui meccanismo di accesso non tiene conto del costo della vita, molto minore nelle regioni meridionali: e infatti il Sud, con il 45% dei poveri, ha ottenuto il 70% delle social card (il meccanismo è questo: poiché la soglia di reddito per accedere è uguale in tutto il territorio nazionale, ma al Sud i prezzi sono più bassi, il numero di «veri poveri» raggiunto è molto più alto al Sud, con significativi effetti di riduzione della disuguaglianza).
Ancora più sorprendenti i dati dell’occupazione. In due anni, ossia fra l’estate del 2007 e quella del 2009, l’occupazione totale è diminuita di 407 mila unità, ma le vittime di questo calo non sono stati i gruppi sociali considerati più deboli bensì quelli più forti. In questo biennio, per operai e impiegati i nuovi posti di lavoro avevano sostanzialmente eguagliato i posti di lavoro perduti (il saldo è negativo per sole 5 mila unità). Per i lavoratori indipendenti, invece, le chiusure di attività avevano largamente superato le aperture, con un saldo negativo di 402 mila unità. Una parte di queste chiusure era costituita da contratti di lavoro parasubordinato non rinnovati, ma la parte preponderante era dovuta alle difficoltà finanziarie delle partite Iva, strangolate dalle restrizioni creditizie e dai ritardi nei pagamenti, a partire da quelli della pubblica amministrazione.
Quanto alla nazionalità dei lavoratori coinvolti nella crisi, i dati Istat ci riservan...