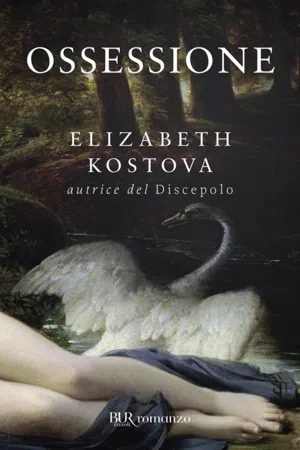![]()
1
Marlow
Ricevetti la telefonata che riguardava Robert Oliver nell’aprile del 1999, meno di una settimana dopo che aveva estratto un coltello in una sala della collezione di dipinti dell’Ottocento alla National Gallery. Era martedì, una di quelle mattine terribili che a volte flagellano la zona di Washington, quando la primavera è già piena di fiori e perfino calda; una grandinata battente, il cielo cupo, il fragore del tuono nell’aria improvvisamente fredda. Era passata esattamente una settimana dal massacro della Columbine High School a Littleton, Colorado: pensavo ancora a quell’evento in modo ossessivo, come avrà certamente fatto qualsiasi psichiatra di questo Paese. Il mio studio sembrava pieno di quei ragazzi armati di fucili a canne mozze e di rancore folle. In che modo li avevamo traditi, loro e – ancora di più – le loro vittime innocenti? Mi sembrava che la furia del temporale e lo sconcerto della nazione fossero una cosa sola.
Quando squillò il telefono, la voce all’altro capo del filo era quella di un amico e collega, il dottor John Garcia. John è un uomo perbene – e un eccellente psichiatra – con cui ho frequentato l’università molto tempo fa, e che ogni tanto mi porta a pranzo in un ristorante scelto da lui; è raro che mi permetta di pagare. Si occupa dei ricoveri di emergenza e della cura dei degenti in uno dei più grandi ospedali di Washington, e come me ha anche uno studio privato.
John mi stava dicendo che voleva farmi ricoverare un paziente, affidarlo alle mie cure, io sentivo la preoccupazione e l’ansia nella sua voce. «Questo tizio potrebbe rivelarsi un caso difficile. Non so che cosa ne caverai, ma preferisco che stia da te al Goldengrove. A quanto pare è un artista, e anche di successo. È stato arrestato una settimana fa, poi l’hanno portato da noi. Non parla molto e non gli andiamo granché a genio, qui. Si chiama Robert Oliver.»
«Ne ho sentito parlare, ma non conosco le sue opere» ammisi. «Vedute e ritratti; credo che fosse sulla copertina di “ARTnews” un paio di anni fa. Cos’ha combinato per farsi arrestare?» Mi volsi verso la finestra e osservai la grandine, che si abbatteva come una pioggia di diamanti sul giardinetto dietro casa circondato da un muro e su una magnolia. L’erba del prato era già di un verde brillante, e per un attimo la luce di un raggio di sole dilagò ovunque, cancellata dopo qualche istante da un altro scroscio di grandine.
«Ha cercato di colpire un quadro della National Gallery con un coltello.»
«Un quadro? Non una persona?»
«Be’, in quel momento nella sala non c’era nessuno, ma è entrato un guardiano e l’ha visto che si scagliava contro un quadro.»
«Ha opposto resistenza?»
«Sì. Alla fine ha lasciato cadere il coltello, ma poi se l’è presa con il guardiano e lo ha malmenato. È un uomo gigantesco. Poi si è fermato e ha lasciato che lo portassero via, chissà perché. Il museo sta decidendo se denunciarlo o meno per aggressione. Non credo che lo faranno, ma ha rischiato grosso.»
Continuai a osservare il giardino. «I dipinti della National Gallery sono di proprietà federale, vero?»
«Sì.»
«Che tipo di coltello era?»
«Solo un temperino. Niente di eccezionale, ma avrebbe potuto fare un sacco di danni. Era molto agitato ed era convinto di compiere una missione eroica. Poi alla centrale di polizia è crollato, ha confessato di non dormire da giorni, ha perfino pianto. L’hanno portato al pronto soccorso psichiatrico e l’ho ricoverato da noi.» Capivo che John si aspettava da me una risposta.
«Quanti anni ha questo tizio?»
«È giovane... be’, ha quarantatré anni, ma a me ormai sembra giovane, ti rendi conto?» Mi rendevo perfettamente conto, e mi misi a ridere. Il nostro cinquantesimo compleanno, solo due anni prima, era stato uno shock per entrambi, e avevamo cercato di sdrammatizzare festeggiando insieme a un paio di amici che si trovavano nella medesima situazione.
«Aveva con sé anche un album per schizzi e un pacchetto di vecchie lettere. Non permette a nessuno di toccarli. »
«Cosa vuoi che faccia per lui?» Mi resi conto di essermi appoggiato alla scrivania per riposare; era stata una mattinata intensa e avevo fame.
«Prendilo» rispose John. «Voglio che te ne occupi tu.»
Ma nella nostra professione la cautela è un riflesso condizionato. «Perché? Stai cercando di rendermi la vita ancora più difficile?»
«Oh, andiamo.» John stava sorridendo, era come se lo vedessi. «Che io sappia non hai mai rifiutato un paziente, dottor Sacrificio, e questo dovrebbe valere i tuoi sforzi.»
«Perché sono un pittore?»
La sua esitazione fu quasi impercettibile. «Francamente, sì. Non mi vanto di capire gli artisti, ma credo che tu possa scoprire cosa c’è che non va in questo tizio. Ti ho detto che non parla molto, e quando dico che non parla molto intendo che sono riuscito a strappargli tre frasi al massimo. Credo che stia cadendo in depressione, nonostante i farmaci che gli abbiamo prescritto. È anche pieno di rabbia, e in certi momenti è molto agitato. Sono preoccupato per lui.»
Fissai l’albero, il prato color smeraldo, i chicchi di grandine sparsa che si stavano sciogliendo, poi ancora l’albero. Non era proprio al centro della finestra, ma leggermente a sinistra, e la luce plumbea del giorno aveva regalato ai suoi boccioli bianchi e violetti una luminosità che non avevano quando splendeva il sole. «Cosa gli hai prescritto? »
John elencò i farmaci: uno stabilizzatore dell’umore, un ansiolitico e un antidepressivo, tutti dosati opportunamente (o in dose massiccia?). Presi penna e blocchetto dalla scrivania.
«Diagnosi?»
John me lo disse e non fui sorpreso. «Per nostra fortuna ha firmato un consenso informato al pronto soccorso, quando parlava ancora. Abbiamo anche ricevuto da poco la copia della sua cartella clinica; ce l’ha inviata uno psichiatra della Carolina del Nord e risale a circa due anni fa. È stata l’ultima volta che ha visto un medico.»
«Ha crisi d’ansia significative?»
«Non ne parla, ma il comportamento è inequivocabile. E questa non è la prima volta che assume farmaci, stando alla sua cartella. Anzi, quando è arrivato qui gli abbiamo trovato nella tasca della giacca alcune compresse di clonazepam in un tubetto di due anni fa. Probabilmente non gli giovavano molto, visto che non erano associate a un calmante. Poi siamo riusciti a rintracciare la moglie nella Carolina del Nord – la ex moglie, a dire la verità – e ci ha detto qualcosa di più sulle terapie che ha seguito in passato.»
«Tendenze suicide?»
«Forse. È difficile fare una valutazione attendibile, visto che si rifiuta di parlare. Qui da noi non ha fatto tentativi in quel senso. È come tenere un orso in gabbia... un orso silenzioso. Più che altro prova moltissima rabbia. Ma con un quadro clinico simile non me la sento di limitarmi a dimetterlo. Dovrebbe passare un periodo da qualche parte, e trovare qualcuno che sia in grado di capire cosa gli stia succedendo. I farmaci che assume andranno dosati con maggior precisione. Ha firmato di sua volontà, quindi credo che verrà spontaneamente in clinica da te. Qui non gli piace.»
«Insomma, credi che possa riuscire a farlo parlare?» Era una battuta ricorrente tra noi, e come al solito John stette allo scherzo.
«Marlow, tu riusciresti a far parlare un sasso.»
«Grazie per il complimento. E soprattutto grazie per avermi mandato all’aria la pausa pranzo. L’assicurazione ce l’ha?»
«In parte. L’assistente sociale se ne sta occupando.»
«D’accordo. Fallo accompagnare al Goldengrove. Domani alle due, con tutta la documentazione. Lo farò ricoverare. »
Riagganciammo, e rimasi in piedi a chiedermi se sarei riuscito a trovare il tempo di disegnare per cinque minuti mentre mangiavo; mi piace farlo quando ho una giornata piena di visite. Avevo appuntamenti all’una e mezzo, alle due, alle tre, alle quattro, seguiti da una riunione alle cinque. E il giorno dopo mi aspettavano dieci ore filate al Goldengrove, la clinica privata dove lavoravo da dodici anni. Adesso avevo bisogno del mio pranzo a base di zuppa e insalata, e di tenere la matita tra le dita per qualche minuto.
Pensai anche a una cosa che avevo dimenticato da tempo, ma che in passato mi tornava in mente spesso. Quando avevo ventun anni ed ero fresco di laurea alla Columbia (dove mi avevano riempito la testa di nozioni di storia e letteratura oltre che di scienza), e stavo per entrare alla facoltà di medicina dell’Università della Virginia, i miei genitori mi avevano regalato un viaggio di un mese in Italia e Grecia, insieme al mio compagno di stanza. Era il mio primo viaggio fuori dagli Stati Uniti. Rimasi incantato dai dipinti nelle chiese e nei monasteri italiani, dall’architettura di Firenze e Siena. Sull’isola greca di Paros, dove si estrae il marmo più perfetto e luminoso del mondo, un giorno mi ritrovai da solo in un museo archeologico.
Quel museo conservava un’unica statua preziosa, che troneggiava tutta sola in una stanza. Era una Nike in pessime condizioni, alta circa un metro e mezzo, acefala e priva di braccia, con cicatrici sulla schiena al posto delle ali e macchie rosse sulla carne di marmo, causate dalla lunga sepoltura nella terra dell’isola. La maestria delle sculture era ancora ben visibile nei drappeggi intorno al corpo, leggeri come giochi d’acqua. Le avevano riattaccato uno dei piccoli piedi. Ero solo nella sala e le stavo facendo un ritratto quando il custode fece capolino per annunciare: «Si chiude tra poco!». Quando se ne andò riposi il materiale da disegno e poi – senza pensare neanche per un attimo alle possibili conseguenze del mio gesto – mi avvicinai alla Nike un’ultima volta e mi chinai a baciarle il piede. Il custode mi fu addosso in un secondo, e mi agguantò urlando. Non mi ero mai fatto buttare fuori da un locale notturno, ma quel giorno fui cacciato da un museo che aveva un solo custode.
Sollevai la cornetta e richiamai John, che trovai ancora in studio.
«Che quadro era?»
«Come?»
«Il quadro che il tuo paziente, il signor Oliver, voleva colpire.»
John rise. «Non avrei mai e poi mai pensato a chiederlo, sai? Ma era scritto nel verbale della polizia. Si intitola Leda. Credo sia un mito greco. Se non ricordo male, almeno. Sul verbale c’era scritto che il quadro raffigurava una donna nuda.»
«Una delle conquiste di Zeus» dissi. «Andò da lei con le sembianze di un cigno. Chi l’ha dipinto?»
«Oh, ma per piacere... che cos’è, un esame di cultura generale? Tra parentesi, per poco non mi hanno bocciato in storia dell’arte. Non so chi l’abbia dipinto e credo non lo sapesse nemmeno il poliziotto che l’ha arrestato.»
«D’accordo, torna pure al tuo lavoro. Buona giornata, John» dissi cercando di sgranchirmi il collo e di reggere la cornetta nello stesso tempo.
«Anche a te, vecchio mio.»
![]()
2
Marlow
Sento già l’impulso di cominciare da capo la mia storia, ribadendo che è del tutto privata. E non solo privata, ma soggetta alla mia immaginazione nella stessa misura in cui è soggetta ai fatti. Mi ci sono voluti anni per riordinare i miei appunti su questo caso, e anche le idee: confesso di aver pensato, in un primo tempo, che avrei scritto qualcosa su Robert Oliver per una delle riviste psichiatriche che ammiro di più e che ha già pubblicato alcuni miei articoli, ma chi scriverebbe un articolo destinato a comprovare la sua cattiva condotta professionale? Viviamo in un’epoca caratterizzata da talk show e indiscrezioni senza fine, ma la nostra professione è estremamente rigida nei suoi silenzi: rigorosa, legale, responsabile. Nei casi migliori. Naturalmente vi sono situazioni in cui la saggezza deve avere la meglio sulle regole; ogni medico ha avuto a che fare con simili emergenze. Ho preso la precauzione di cambiare tutti i nomi delle persone coinvolte in questa vicenda, compreso il mio, con l’eccezione di un nome di battesimo così comune, ma anche così bello per me, oggi, che non vedo motivo di non mantenerlo.
Non vengo da una famiglia di medici: i miei genitori erano entrambi pastori protestanti; anzi, mia madre fu il primo pastore donna della loro piccola setta, e io avevo undici anni quando fu ordinata. Vivevamo nella casa più antica della nostra città del Connecticut, una casa dal tetto basso, rivestita di assicelle di legno marrone, con un giardino simile a un cimitero inglese, dove tuje, tassi, salici piangenti e altri alberi funerei si accalcavano intorno al vialetto di ardesia che conduceva alla porta d’ingresso.
Ogni pomeriggio alle tre e un quarto rientravo in quella casa dopo la scuola, trascinandomi dietro la cartella piena di libri e briciole, palle da baseball e matite colorate. Mia madre apriva la porta, di solito in gonna blu e maglioncino, e in seguito, a volte, con la veste talare nera dal colletto bianco inamidato, se aveva fatto visita a malati, anziani, reclusi e penitenti. Ero un bambino lagnoso, un po’ curvo, e perennemente oppresso dalla sensazione che la vita non fosse ciò che aveva promesso di essere. Quando mia madre si avvide del mio precoce talento per il disegno e la scultura, mi incoraggiò giorno dopo giorno con tranquilla certezza, senza lodi sperticate ma senza concedermi mai di dubitare dei miei sforzi. Non avremmo potuto essere più diversi, fin dal momento della mia nascita, credo, e ci legava un amore intenso.
È curioso, ma anche se mia madre morì ancora relativamente giovane, o forse proprio per questo, col sopraggiungere della mezza età mi sono accorto che divento sempre più come lei. Per anni sono stato non esattamente uno scapolo, ma comunque un uomo non sposato, anche se poi ho finalmente regolarizzato la mia posizione. Le donne che ho amato sono (o erano) tutte simili al bambino che sono stato: lunatiche, caparbie, interessanti. Vivendo accanto a loro ho finito per assomigliare sempre più a mia madre. La donna che ho sposato non fa eccezione alla regola, ma siamo adatti l’una all’altro.
In parte come risposta a quelle donne un tempo amate e a mia moglie, e in parte, su questo non ho dubbi, in risposta a una professione che ogni giorno mi rivela il lato oscuro della mente, la tristezza della sua evoluzione nell’ambiente e i suoi capricci genetici, mi sono allenato, dopo l’infanzia, ad avere una sorta di atteggiamento diligentemente positivo nei confronti della vita. La vita e io siamo diventati amici qualche anno fa: non si tratta però dell’amicizia inebriante che sognavo da bambino, ma di una benevola tregua, il piacere che provo ogni giorno a tornare nel mio appartamento di Kalorama Road. Di quando in quando c’è un momento – mentre sbuccio un’arancia e la porto dalla cucina al tavolo – in cui avverto quasi un fremito di soddisfazione, forse grazie a quel colore così vivo.
Sono arrivato ad apprezzare questi piaceri solo nell’età adulta. Si pensa che i bambini amino le piccole cose, ma nella mia infanzia io ricordo solo sogni di grandezza, e poi il restringersi di quel sogno da un interesse all’altro, e quindi l’incanalarsi di tutti i miei sogni nella biologia e nella chimica e nell’obiettivo della facoltà di medicina. Solo alla fine ho avuto la rivelazione dei dettagli minimi della vita, con i loro neuroni, le loro spirali e gli atomi vorticanti. All’inizio ho imparato a disegnare molto bene, in effetti, ispirandomi a quelle forme e ombre infinitesimali nelle lezioni di biologia in laboratorio, e mai a soggetti grandi come montagne, figure umane o ciotole di frutta.
Se oggi sogno in grande lo faccio per i miei pazienti, nella speranza che un giorno provino anche loro gioie banali come quella della cucina e dell’arancia, e possano stare sul divano con i piedi appoggiati sul tavolino davanti a un documentario trasmesso in tivù. Sogno per loro anche piaceri ancora più grandi, come tornare sani di mente dai loro cari, non farsi licenziare e riuscire a guardare in faccia serenamente gli altri esseri umani. Per me, ho imparato a sognare in piccolo: una foglia, un pennello nuovo, la polpa di un’arancia e i particolari della bellezza di mia moglie, un bagliore all’angolo dei suoi occhi, la lieve peluria sulle sue braccia, illuminate dalla lampada del salotto quando è seduta e legge un libro.
Ho detto che non vengo da una famiglia di medici, ma forse non è così strano che abbia scelto una specializzazione simile. Mio padre e mia madre non avevano né una formazione né una mente scientifica, anche se la loro disciplina personale, che mi venne trasmessa dal porridge e dai calzini puliti, con l’intensità riversata dai genitori su un figlio unico, mi tornò assai utile per affrontare i rigori della biologia al college e i rigori ancora più difficili della facoltà di medicina: il rigor mortis di intere nottate passate a studiare e imparare a memoria, e il sollievo relativo di altre nottate insonni più avanti, durante i turni in ospedale.
Avevo anche sognato di diventare un artista, ma quando venne il momento di scegliere la professione che avrei svolto tutta la vita decisi per medicina, e seppi dall’inizio che mi sarei dedicato alla psichiatria, che per me era sia una professione in grado di curare, sia la scienza definitiva dell’esperienza umana: a dire il vero dopo il college avevo fatto domanda anche all’Accademia di belle arti, e con mia grande gioia ero stato ammesso in due ottime scuole. Vorrei poter dire che la mia fu una decisione sofferta, che l’artista dentro di me si ribellò alla mia scelta. In realtà sentivo che come pittore non sarei riuscito a dare un contributo sufficientemente valido alla società, e in fondo al cuore temevo le fatiche che guadagnarsi da vivere in quel modo poteva comportare. La psichiatria sarebbe stata il modo più diretto per aiutare un mondo sofferente. Intanto avrei continuato a dipingere per me stesso, e sarebbe stato abbastanza, pensai, sapere che avrei potuto intraprendere la carriera di artista.
I miei genitori rifletterono a lungo sulla branca della medicina che avevo scelto; me ne avvidi quando gliene parlai durante una delle nostre conversazioni telefoniche del fine settimana. Dall’altro capo del filo ci fu una pausa, mentre digerivano quello che ave...