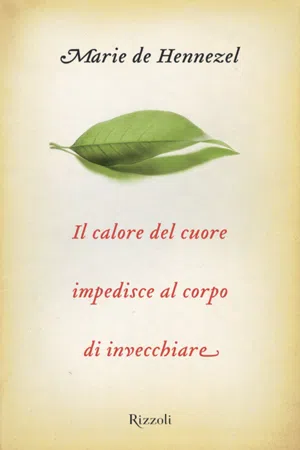![]()
Domande sulla vecchiaia
Dopo la trasmissione, fortemente impressionata dal cambiamento di opinione avvenuto sul palco dell’Arène de France, ho deciso di riprendere, una dopo l’altra, le paure e le domande angoscianti che mi avevano assalita all’inizio della mia ricerca.
Noi, giovani anziani, abbiamo ancora i nostri genitori, che hanno raggiunto la quarta età. Non sempre ci rimandano un’immagine invidiabile dell’estrema vecchiaia. Alcuni sono divenuti dipendenti o dementi. Siamo stati costretti a sistemarli, non senza dolore, non senza sensi di colpa, in case di riposo o strutture specializzate. Non abbiamo i mezzi per permettere loro di invecchiare in casa con una persona fissa a domicilio, né la volontà di prenderli a stare con noi. Ci troviamo così ad accompagnare i nostri genitori con una domanda angosciante dentro di noi: siamo dunque destinati a invecchiare soli, con la sensazione di essere inutili? Verremo anche noi parcheggiati in quei ghetti per vecchi che sono le case di riposo? Termineremo la nostra vita nella notte della demenza?
Anche se resta molto da fare perché le residenze per anziani dipendenti o dementi siano veri luoghi di vita, esistono già, tuttavia, alcuni modelli di umanità in questo campo. In fondo, bisogna riconoscerlo, le classi dirigenti sono consapevoli della posta in gioco in tema di invecchiamento della popolazione e sanità pubblica. Hanno annunciato numerosi piani, e starà a noi vegliare affinché siano seguiti da misure concrete per rispondere ai timori che ci pervadono.
Ma tutte queste iniziative, tutti questi progetti, non saranno efficaci se la nostra generazione, quella di coloro che hanno tra i cinquantacinque e i settantacinque anni, la generazione perno tra i più anziani e i più giovani, non prenderà coscienza dell’importanza essenziale della solidarietà. Siamo «l’anello forte della catena di solidarietà in Francia» dichiarava recentemente un viceministro.1 Tocca a noi sviluppare tutte le buone idee che stanno fiorendo un po’ dappertutto, come i «cafés delle età», che permettono l’incontro tra diverse generazioni, o gli alloggi sociali, che raggruppano giovani coppie con bambini piccoli e pensionati.2 Sappiamo quanto gli anziani amino il contatto con i piccoli. Me ne sono persuasa il giorno in cui ho assistito alla scena di una giovane donna che portava il suo bimbo di sei mesi sul letto del padre morente, in ospedale. Ho visto il vecchio, che aveva lo sguardo un po’ perso e triste, raddrizzarsi, e il suo volto venire illuminato da un bel sorriso, essere attraversato dalla gioia.
Un’amica americana mi ha raccontato che, in un centro commerciale negli Stati Uniti, esiste uno spazio pubblico, in cui i genitori possono lasciare il loro bebè mentre fanno la spesa. E sono volontari anziani, sotto la guida di un’assistente all’infanzia professionista, a occuparsi dei piccoli.3 Non è difficile immaginare il bene reciproco che deriva da questi contatti.
Possediamo, noi tutti, una scarsa consapevolezza di quanto abbiamo perduto con i cambiamenti sociologici degli ultimi anni. I contatti tra nonni e nipotini avvenivano naturalmente al tempo delle famiglie allargate, che vivevano sotto lo stesso tetto. Bisogna essere caduti davvero in basso nella separazione tra le età se è necessario fare appello a un’associazione per stabilire dei legami affettivi tra generazioni!4
Jérôme, un giovane studente di Scienze politiche che ho incontrato di recente da amici, mi ha raccontato che vive a casa di una vecchia signora di ottantacinque anni, in un grande appartamento del Quartier Latin. È venuto a conoscenza dell’operazione «Un tetto, due generazioni», sostenuta dagli studenti della sua facoltà, che hanno anche redatto la carta delle condizioni di alloggio, basata su un impegno reciproco di discrezione, rispetto, fiducia e tolleranza. In cambio della sua presenza e di piccoli servizi, come cambiare una lampadina o portare le bottiglie d’acqua, è dunque confortevolmente alloggiato in una camera con bagno privato. Tre volte a settimana passa la serata con questa signora, molto colta, vedova di un professore di Diritto, ma sola, perché non ha avuto figli. Capita che la porti a mangiare fuori, ma il più delle volte cenano a casa e ascoltano un po’ di musica o guardano un film insieme. Il fatto di condividere con un ragazzo questi momenti di svago la stimola. Si sente ringiovanire. Lui, dal canto suo, impara molto da questa donna che ha tanto viaggiato e sa raccontargli le avventure che ha vissuto con grande senso dell’umorismo.
Abbiamo paura di diventare trasparenti, di non interessare più a nessuno. «Quello che avevate di prezioso e di importante da trasmettere ai vostri discendenti non importa più. Quanto alla vostra esperienza, è semplice, per loro è una rottura di scatole!» scrive Benoîte Groult. «Non si aspettano alcuna sorpresa da noi, se non un infarto, la frattura di un femore, un problema vascolare cerebrale o il lento orrore dell’Alzheimer… Come sorprenderli?»5 si chiede.
Alla nostra generazione è affidato il compito di lottare contro l’isolamento degli anziani e valorizzare tutto quello che sono in grado di offrirci. Perché non trarre ispirazione dall’esperienza americana? In certi quartieri di New York vengono istituiti dei «circoli di anziani» per permettere a coloro che soffrono della propria condizione di solitudine e inutilità di trasmettere alle giovani generazioni il loro sapere sulla vita. In questi circoli le persone più avanti con l’età si siedono in cerchio in mezzo e i più giovani si sistemano tutt’intorno. Come nella tradizione degli Indiani d’America, al centro è posto il «bastone della parola». Gli anziani possono, quando vogliono, andarlo a prendere e tornare al loro posto per condividere le esperienze e le riflessioni personali con il resto del gruppo. In questo modo si costruisce una saggezza collettiva a cui ognuno apporta il proprio contributo.
Un lavoro notevole è anche quello a cui ha dato vita Claudine Attia-Donfut,6 in collaborazione con la Fondazione nazionale di gerontologia. È stato proposto ad alcuni ottuagenari e novantenni di scrivere lettere indirizzate ai loro nipoti. Queste lettere di persone ridotte dalla nostra società al silenzio sono un documento inedito. Quasi tutte firmate da donne. Vi parlano delle loro gioie e delle loro sofferenze, della loro vita passata e di quella presente. Una di loro mi ha particolarmente commossa, perché si rivolge alla coscienza di ciascuno di noi. Si tratta di una donna di novant’anni che scrive ai suoi «cari figli» che hanno preso, al suo posto, la decisione di ricoverarla in una casa di riposo. «Vorrei dire alle famiglie: parlate con i vostri parenti! È la loro vita che manipolate! Non siamo giocattoli. Alla nostra età, prendiamo tutto a cuore, un nulla ci ferisce. Quindi, per favore, non considerateci come burattini privi di sentimenti non appena cominciamo a essere ingombranti. Parlateci. Lasciateci essere un po’ attori della nostra vita. Grazie.»
Ci poniamo domande angoscianti. Che fare dei nostri vecchi genitori quando non saranno più autonomi, quando non saranno più in grado di guidare o andare a fare la spesa? E i nostri figli, cosa faranno di noi quando arriveremo allo stesso stadio? Questo interrogativo ci preoccupa. Perché tutti noi vorremmo invecchiare e morire a casa nostra, nel luogo in cui ci sentiamo bene. Dove abbiamo le nostre abitudini, i nostri ricordi. Dove viviamo secondo il nostro ritmo. Dove possiamo invitare chi vogliamo. Molti di noi preferiscono l’idea di invecchiare a casa a dispetto del rischio di restare senza assistenza in caso di malore o di incidente. Tuttavia, nonostante tutti gli aiuti a domicilio possibili al giorno d’oggi,7 nonostante i progressi della robotica e dei dispositivi che segnalano le eventuali cadute, le fughe di gas e altre anomalie, può succedere che la perdita di autonomia fisica, e talvolta mentale, renda la vita a casa propria impossibile.
Le molte testimonianze sul dispiacere di coloro che terminano la propria vita in un istituto e la cattiva reputazione delle case di riposo hanno contribuito ad aggiungere un po’ di peso sull’altro piatto della bilancia. Oggi ci sono diverse famiglie che non esitano a prendere in casa con sé un parente anziano. Le stime dicono che una persona su cinque al di sopra degli ottant’anni vive con la sua famiglia. Ma questa solidarietà tra figli e genitori comporta uno sforzo.8 È una scelta che richiede l’accettazione di forti limitazioni e una buona dose di pazienza. Per questo, è necessario prepararsi, altrimenti la realtà prende velocemente piede sulle buone intenzioni. Tenere un genitore anziano a casa con sé può rivelarsi un’esperienza talmente estenuante da diventare insostenibile. Un certo maltrattamento – in seno alla famiglia – trova lì la sua origine. La coabitazione con un genitore non più autosufficiente è certamente possibile, ma a due condizioni essenziali: essere ben organizzati e andare d’accordo con il proprio anziano ospite.
Le autorità pubbliche sono sempre più consapevoli della necessità di sostenere quelli che vengono definiti gli «aiutanti naturali». Il finanziamento di un congedo di presenza famigliare, la creazione di strutture d’accoglienza temporanee, lo sviluppo del volontariato,9 si rivelerebbero interessanti piste da percorrere.
I miei amici belgi Evence e Kathy Coppée, molto impegnati nel volontariato di assistenza, si sono lanciati in un’esperienza interessante, ispirata al Québec: il baluchonnage, da baluchon, «fagotto».10 Vanno a stare qualche giorno, col loro fagotto, appunto, presso famiglie che hanno un parente affetto da Alzheimer e che sentono il bisogno di prendersi un po’ di vacanza. Ci rimangono per una o due settimane e si occupano in tutto e per tutto della persona malata. Un diario di bordo permette di condividere al ritorno della famiglia gli eventi quotidiani.
La personalità del parente anziano che si accoglie in casa, la sua capacità di invecchiare bene, cioè di accettare le perdite che l’età gli infligge sviluppando le sue qualità di cuore, e di sorvolare quando i conflitti, le gelosie o semplicemente la stanchezza turbano l’atmosfera, giocano un ruolo fondamentale nella coabitazione.
Una coppia di miei amici, Pierre e Georgina, ha deciso due anni fa di accogliere in casa Chantal, la madre di lei. Numerose cadute, perdite di memoria, difficoltà a fare la spesa, hanno segnato un inizio di dipendenza. La coppia ci ha riflettuto bene. La relazione tra madre e figlia era forte. La disponibilità della pensione, le dimensioni della casa, rendevano possibile lanciarsi nell’avventura, o quantomeno tentarla. «Non sarei riuscita a perdonarmi se non ci avessi provato» mi ha confidato Georgina.
Chantal si è dunque trasferita. Anche per lei non è stato facile lasciare la sua abitazione e sbarcare in quella della figlia. Non era più a casa sua. Provava sentimenti contraddittori: il benessere di sentirsi in sicurezza, in una piacevole intimità con sua figlia e suo genero, che apprezza, ma anche angoscia di fronte al futuro. Come si sarebbe evoluta la situazione nel tempo, con una perdita sempre maggiore di autonomia? Presentiva che poco a poco i gesti della vita quotidiana le sarebbero sfuggiti di mano: la gestione delle sue cose, del conto in banca. Come avrebbe vissuto sua figlia quell’inversione di ruoli, quando lei sarebbe diventata, in qualche modo, la figlia di sua figlia? Come avrebbe tollerato Pierre l’intrusione permanente di un terzo incomodo nella loro vita di coppia? Come avrebbero fatto ad accettare senza risentimento di non avere più weekend, vacanze, di essere obbligati ad alzarsi la notte per occuparsi di lei?
Consci delle difficoltà che potevano presentarsi, Georgina e Pierre hanno scelto, comunque, di vivere il presente. Che saggezza! Per il momento lo stravolgimento della loro vita è ampiamente compensato dalla ricchezza degli scambi con Chantal. È una donna forte e paziente. Ha il dono di saper ricevere, ed è un piacere prendersi cura di lei. Sembra così felice delle attenzioni che la coppia le dedica! Distribuisce con gioia i suoi sorrisi e i suoi baci. Si fa leggera, consapevole del peso che rappresenta.
Non si è esclusa la probabilità che un giorno potrebbe essere necessario un trasferimento in un istituto e ne hanno parlato con Chantal. Ma per adesso, fanno provvista di bei momenti.
Misuriamo, ascoltando questa testimonianza, quanto la coabitazione possa rivelarsi un’esperienza ricca di umanità. Ma tutto ciò ha un prezzo. Richiede molti sforzi e molto amore.
Tra una vecchiaia passata in casa, che si rivela difficile, e la casa di riposo, guardata con grandissimo timore e anzi vissuta da molti come un vero e proprio ingresso in prigione, una soluzione intermedia sta prendendo piede, quella delle «comunità alloggio». Queste conciliano il rispetto di uno spazio privato, una stanza in cui si possono sistemare i propri mobili, vivere secondo i propri ritmi, andare e venire, pur beneficiando al tempo stesso di uno spazio comune se si desidera mangiare con altri o partecipare ad attività di gruppo.
Un progetto di comunità alloggio per pensionate è stato avviato di recente a Montreuil e l’esperienza merita di essere raccontata. Tre settantenni vi hanno lavorato per dieci anni.
La Maison des Babayagas, così chiamata in riferimento alle vecchie della tradizione popolare russa, ospita diciassette donne di oltre sessant’anni, vedove, celibi o divorziate. Ciascuna dispone di un appartamentino di trentacinque metri quadrati, alle stesse condizioni degli alloggi sociali. Al pianoterra si trovano spazi comuni dedicati all’animazione culturale o sociale e alle attività collettive. Nel piano interrato c’è una piscina. Si tratta di una residenza autogestita, autonoma, il che significa che funziona con un minimo aiuto da fuori, per quanto riguarda il supporto medico e le faccende domestiche. Propone, inoltre, senza imporla, una vita collettiva e attività che mettono in contatto con il mondo esterno, permettendo, al tempo stesso, di dividere alcune spese in modo da compensare le pensioni basse di donne che hanno spesso dovuto dare la precedenza ai figli rispetto al lavoro. «Un’anti-casa di riposo […] un vero baluardo contro il ripiegamento in se stessi.»11
Ecco un bel progetto di donne che vogliono rimanere libere, non pesare sui loro cari e soprattutto non essere ridotte a venire trattate come bambine. Donne che vogliono lottare contro l’isolamento, creare un ambiente amichevole e impegnato. Gli uomini possono fare loro visita, ma non vivere lì.
Le Baba Yaga diffidano del sapere medico e della patologizzazione della vecchiaia. Pensano che «le malattie dei vecchi siano malattie della noia e dell’isolamento».
L’unica falla di questo progetto sta nel fatto che esso non prevede la possibilità di ospitare persone non autosufficienti o colpite da una malattia degenerativa in stato avanzato. Se una delle Baba Yaga declina fino a quel punto, deve essere trasferita in un luogo attrezzato. Ma nei limiti del possibile è previsto che le donne in buona salute si prendano cura degli handicap delle altre. Il valore che dovrebbe unire queste pensionate tra loro è, infatti, quello della solidarietà.
Per fronteggiare gli inevitabili conflitti che tutte le comunità conoscono, le fondatrici, Thérèse, Suzanne e Monique, hanno pensato alla presenza regolare di una mediatrice. «Questo progetto richiede molto impegno da parte di ciascuna. Bisogna saper gestire bene quello che è nell’ordine del collettivo e quello che appartiene all’intimità.»
L’ambizione di questa «utopia realista» è di collocarsi in un vero e proprio movimento che scuota la vecchia Europa. Thérèse, Suzanne e Monique vorrebbero ispirare altri progetti.
Buona parte di questo libro è stata scritta nella piccola casa che ho fatto costruire sull’Île-d’Yeu. Durante una cena con alcuni amici, abbiamo parlato della nostra vecchiaia e del luogo in cui ci piacerebbe trascorrerla. Nessuno dei presenti voleva terminare la sua vita in una casa di riposo. Ho verificato una volta di più tutto l’orrore che questo pensiero suscita negli uomini e nelle donne della mia generazione.
«Bisognerebbe inventarsi qualcosa di simile a un beghinaggio» ho suggerito. «Nel Medioevo, in Belgio, alcune vedove si riunivano in gruppi di otto e formavano una piccola comunità di persone anziane, con l’intento di aiutarsi vicendevolmente nell’ultima fase della vita. Abitavano da sole, in piccole casette attaccate l’una all’altra, attorno a una chiesa o a un giardino. Sceglievano di vivere insieme rispettando al contempo la libertà di ciascuna, in un impegno di solidarietà e condivisione che all’epoca significava dedicarsi al giardinaggio o alle liturgie religiose. Quando una di loro moriva, le altre la accompagnavano. Poi cooptavano una nuova beghina.
«Quindi, dato che amiamo così tanto quest’isola, che abbiamo la fortuna, alcuni di noi, almeno, di averci un tetto e che le nostre case sono così vicine le une alle altre, perché non formiamo un beghinaggio moderno, un beghinaggio misto, ovviamente? Ognuno potrebbe abitare a casa propria, godere della sua libertà, ma ci si potrebbe inventare attività comuni e riunirsi per svolgerle, come fare passeggiate lungo l’isola o occuparci insieme dei giardini e, perché no, ritrovarci regolarmente attorno a una pratica spirituale, come la meditazione o la contemplazione. E se uno di noi si ammalasse o smettesse di essere autosufficiente, potremmo alternarci presso di lui in modo che possa restare a casa invece di rinchiudersi in una residenza per anziani. Tra di noi ci sarebbe un contratto di solidarietà.»
Ne seguì una discussione molto animata. Alcuni non si vedevano a invecchiare sull’isola. Volevano viaggiare ad vitam aeternam, percorrere le strade del mondo. E, soprattutto, non volevano diventare sedentari. Qualcuno ha citato la poesia di Baudelaire, Il viaggio, che dall’immensità degli spazi dell’infanzia ci conduce allo spazio ristretto del vecchio: «Un’oasi d’orrore in un deserto di noia». L’uomo in questione si chiedeva se l’isola non si sarebbe trasformata in quell’oasi di orrore non appena lui avesse deciso di restarci per sempre.
«Ma cosa farai il giorno in cui non sarai più in grado di viaggiare?» abbiamo ribattuto. «Bisognerà pure che ti fermi da qualche parte. E allora dove?» Alla fine della cena, la maggior parte degli amici presenti aveva aderito all’idea di un beghinaggio di nuova concezione. Ed è vero che il progetto di restare a casa propria, costruendo nel corso degli anni una catena di solidarietà sufficientemente forte da spalleggiarsi gli uni con gli altri, in caso di dipendenza e anche di demenza senile, è un progetto che «funziona». Non comporta alcuna implicazione economica, né giuridica; tutto si fonda su un contratto morale.
Il nostro ospite si domanda allora se l’amicizia vacanziera che ci unisce oggi sarebbe abbastanza forte e duratura per resistere al tempo, all’invecchiamento degli uni e degli altri. Ricorda i cambiamenti di carattere e di umore degli anziani, che divengono talvolta insopportabili. Come essere sicuri che manterremo la nostra personalità? Bisognerebbe, in effetti, che il legame spirituale tra di noi fosse molto forte. Le beghine del Medievo si ritrovavano attorno a una pratica religiosa. Non è il nostro caso. Alcuni di noi credono in Dio, altri no; alcuni pregano, altri no. Cosa abbiamo in comune sul piano spirituale? Valori di rispetto umano, di attenzione all’altro, di solidarietà, un certo gusto per la natura, una capacità comune di meravigliarci di fronte all’infinita diversità dei cieli, un amore per il silenzio e, soprattutto, la certezza che in fondo l’essenziale sia amare. Non è forse sufficiente come bagaglio spirituale?
La questione è rimasta aperta. Fa la sua strada. Questa possibilità ci pare in ogni caso preferibile a quei ghetti per vecchi che sono attualmente le case di riposo. Eppure un giorno, forse, ci troveremo a dover decidere di ricoverare uno dei nostri cari in un istituto. Forse anche i nostri figli non avranno altra scelta per quanto riguarda noi?
Patrick Dewavrin, direttore sanitario di strutture per persone colpite dal morbo di ...