Licenziare i Padreterni
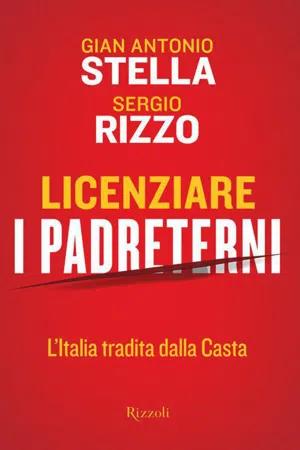
- 170 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Gli stipendi del Senato saliti di un altro 19% in 4 anni - I palazzi del Palazzo che sono diventati 52 - La trincea in difesa dei doppi e tripli vitalizi - Gli aereiblu che volano come mai prima - Sforbiciatine agli affi tti cresciuti di 41 volte dal 1983 - I menù di lusso con le lamelle di spigola ancora a 3, 34 euro - I bilanci "ritoccati" solo per fare bella fi gura - I rimborsi elettorali che hanno superato i 5 miliardi e mezzo - I Presidenti regionali che continuano a prendere come tre governatori Usa - Autoblu a vita che aumentano senza freni - La Parentopoli che impazza E DICEVANO D'AVERE TAGLIATO…
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Licenziare i padreterni di Gian Antonio Stella,Sergio Rizzo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politics & International Relations e Politics. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
A tutti coloro che confondono
i privilegi con la democrazia.
1
Come prima, più di prima
Di qua il Paese in crisi, di là chi non vuol capire
«Il sangue fluiva a torrenti dalle arterie, ma queste vennero tosto legate con filo di seta. Per ultimo, si segò l’osso. Maroncelli non mise un grido. Quando vide che gli portavano via la gamba tagliata, le diede un’occhiata di compassione.»
Pare si siano amputati pezzi di corpo, certi politici, quando descrivono il proprio eroismo nel fare qualche taglio. E invocano la comprensione dei cittadini manco fossero Piero Maroncelli descritto da Silvio Pellico in Le mie prigioni il giorno della mutilazione. Quasi che anche loro come il patriota fossero tenuti a digiuno «se non con qualche mezza chicchera di brodo con tuorlo d’uovo sbattuto».
E invece neppure la leggina più oscena hanno tagliato. Neppure quella leggina ignobile che tutti giuravano che avrebbero cambiato. Non c’era dibattito in cui, appena il discorso cadeva lì, il politico di turno, dal più perbene al più chiacchierato, non arrossisse e giurasse: «Sì, certo, è vero, adesso quella leggina la cambiamo».
E invece è ancora lì, quella regoletta immonda contenuta nel Dpr del 22 dicembre 1986 n. 917. E continua a recitare che chi regala soldi a un partito politico ottiene sconti fiscali fino a 50 volte superiori a chi dona quegli stessi soldi a una organizzazione umanitaria.
Ricordate? Mettiamo che un cittadino regali 100.000 euro alla Città della Speranza, il cuore pulsante della lotta alla leucemia infantile donato dalla generosità di tanti privati al Policlinico di Padova: può detrarre dalle tasse 392 euro e 50 centesimi. Pari al 19% del tetto massimo di 2065,83. Mettiamo che lo stesso cittadino regali gli stessi soldi al Pdl di Silvio Berlusconi, all’Api di Francesco Rutelli, al Fli di Gianfranco Fini o al Pd di Pier Luigi Bersani: potrà detrarre, stavolta, 19.000 euro. Pari al 19% dell’intero importo, perché in questo caso il tetto massimo sale appunto di 50 volte fino a 103.291,38 euro.
Una sperequazione ributtante. Contro la quale, cavalcando l’ira popolare, Antonio Di Pietro e Gianni Alemanno presentarono insieme nell’autunno del 2007 un disegno di modifica per uniformare i due tipi di donazioni. Disegno accolto da applausi alle feste di partito e poi seppellito in un cassetto sotto uno strato di polvere. Nella primavera del 2010, esasperato, il dipietrista Antonio Borghesi tornò alla carica con un nuovo progetto di legge che mettesse ai regali fatti ai partiti lo stesso tetto di 2065,83 euro fissato per le organizzazioni umanitarie.
Bloccato anche quello. Peggio: nell’ottobre 2010 l’Agenzia delle entrate, messa sotto pressione dai soliti noti, si avventurò in una «interpretazione autentica» della infame leggina comunicando che sì, gli sconti fiscali si potevano avere per le donazioni ai partiti presenti in Parlamento ma l’opportunità andava estesa anche ai partiti che magari non c’erano più né alla Camera, né al Senato, né all’Assemblea di Strasburgo ma nell’arco della legislatura qua o là avevano avuto almeno un parlamentare.
C’è tutto, nella storia di quella leggina immutabile. C’è la malafede di chi tuona la propria accorata indignazione nei comizi e poi se ne infischia. C’è l’ingordigia di chi non lascia sul tavolo neanche le briciole. C’è il disinteresse totale per queste cose da parte di chi ha altre faccende per la testa. E ormai vive come se stesse sulla luna. Estraneo al Paese che lo ha, sventuratamente, eletto.
Il 2 agosto 2011 sarà ricordato per tre notizie. La prima, la decisione dei deputati, nel pieno della tempesta finanziaria e del crollo delle Borse, di votare il bilancio: un miliardo, 51 milioni e 914.520 euro di spese correnti, con una limatina dello 0,71% rispetto al 2010. La seconda: la riconvocazione a Montecitorio il 13 settembre dopo un mese di ferie seguito da una settimana in più per un «pellegrinaggio parlamentare». La terza: il crollo del mercato dell’auto, al quale appartiene storicamente la nostra unica multinazionale privata, ritornato dopo tre anni di batoste alle vendite del 1983.
Non è un anno qualunque, il 1983. Avete presente? Un giovanotto di nome Vasco Rossi arriva penultimo al festival di Sanremo. A Ginevra muore in esilio l’ultimo re d’Italia Umberto II. Margaret Thatcher vince le elezioni inglesi. In Brasile finisce in manette il boss Tommaso Buscetta. Ma soprattutto è l’anno-chiave in cui la classe dirigente perde il controllo del debito pubblico, destinato a schizzare in un solo lustro da 456.031 a 1.011.646 miliardi di lire.
L’anno in cui, scriverà in I debiti degli italiani Dino Pesole, «l’aggressione sistematica alle casse statali da parte dei governi e del Parlamento diviene sistema, lo sfondamento rispetto alle previsioni iniziali la regola». Il segretario della Dc è Ciriaco De Mita, quello del Pci Enrico Berlinguer. Alle Finanze c’è Bruno Visentini, al Bilancio Pietro Longo, al Tesoro Giovanni Goria, a Palazzo Chigi Bettino Craxi. Il quale (promemoria per chi dirà che «è tutta colpa del debito che abbiamo ereditato») ha tra i suoi «golden boys» economici Giulio Tremonti, Renato Brunetta, Maurizio Sacconi e Domenico Siniscalco.
Dicono oggi i pensosi pensatori pensanti, bacchettando chi strabuzza gli occhi davanti a certi numeri, che «occorre distinguere tra i costi della politica e i costi della democrazia». Come se contestare la deriva megalomane e spendacciona significhi automaticamente contestare l’essenza stessa della libertà, dei valori repubblicani, della democrazia. Lo ha detto Luciano Violante, lo ha detto Pier Ferdinando Casini, lo ha detto Fausto Bertinotti, lo ha detto Gianfranco Fini, lo ha detto Ignazio La Russa, lo hanno detto così tanti di destra e di sinistra che non vale neanche la pena di elencarli. E il socialista Enrico Boselli si è spinto a ironizzare: «Di questo passo, visto che la legge elettorale dà ai segretari di partito il privilegio di compilare le liste elettorali si potrebbe ridurre il Parlamento a soli due leader, quelli della maggioranza e dell’opposizione, col risparmio pressoché totale di tutti i costi della democrazia».
Bene: nel 1983 di cui parliamo l’Italia aveva (dati del Fondo Monetario Internazionale) un Pil di 428.412 milioni di dollari, pari a quasi il doppio dell’India (che è già in corsia di sorpasso in anticipo di tre anni sul previsto), quasi il triplo del Brasile (che da qualche anno ci sta ora davanti) e del 30% superiore alla Cina, che adesso è tre volte e mezza più grossa di noi. Insomma, rispetto a oggi era un Paese economicamente più forte e meglio piazzato nelle classifiche. Eppure la Camera costava un quarto.
Per l’esattezza, in valuta attuale, calcolando l’inflazione, 291 milioni e mezzo di euro. Vale a dire che da allora le spese si sono moltiplicate per 3,67 volte. C’è chi dirà che parallelamente è cresciuto il Paese, che tutto si è moltiplicato per tre o quattro volte. Falso. Il Pil pro capite degli italiani, sempre in valuta attuale, era di 14.530 euro: è salito a 20.356. Dati del Fondo Monetario Internazionale. Facciamo i conti? Nello stesso periodo la ricchezza dei cittadini è cresciuta mediamente del 40,1% e i costi di Montecitorio del 367%. Nove volte di più.
Anche il Senato costava quasi un quarto. In quel 1983 pesava sulle tasche dei contribuenti per 107,2 miliardi di lire, cifra equivalente a 154,7 milioni di euro attuali. Il che significa che le spese di Palazzo Madama, che oggi assorbe 574 milioni abbondanti, sono cresciute in modo più o meno corrispondente a quello della Camera, moltiplicandosi per 3,7 volte.
Se poi andiamo a vedere alcune voci, sempre attualizzate calcolando l’inflazione, c’è da restare allibiti. A Montecitorio la spesa per l’indennità parlamentare è più che raddoppiata (da 45,9 a 94,5 milioni di euro), quella per i vitalizi più che quadruplicata, salendo da 33,9 a 133,8 milioni. Ma la progressione più folle (grazie all’«operazione Scarpellini» su cui torneremo, ma non solo) è nella tabella degli affitti.
Nell’Italia ricca e baldanzosa del 1983 (quella edonista che si preparava a brindare con lo slogan della «Milano da bere», mica quella impaurita di adesso) la Camera spendeva per la locazione di immobili 600 milioni di lire, cioè 868.000 euro attuali. Bene: a forza di allargarsi tracimando in decine di edifici dei dintorni, spende oggi di affitti nudi e crudi (senza considerare i servizi all inclusive) 35 milioni e 625.000 euro. Cioè 41 (quarantuno) volte di più. Mentre il Pil pro capite, ripetiamo, saliva parallelamente di 1,4 volte. Cioè 29 volte di meno.
Cosa diavolo c’entra la democrazia? Cosa c’entra la libertà? Cosa c’entra il ruolo del Parlamento? C’è qualcuno disposto a sostenere, guardando negli occhi i cittadini, che nel 1983 c’era meno democrazia? Che la Camera di Nilde Jotti, il Senato di Francesco Cossiga, la presidenza del Consiglio di Bettino Craxi, il Quirinale di Sandro Pertini non erano pienamente democratici?
Il costo immensamente più basso di «quei» palazzi della politica pregiudicava forse la libera dialettica delle opinioni? Impediva alla classe dirigente di accompagnare lo sviluppo del Paese, che al contrario stava vivendo allora, sia pure tra mille contraddizioni, l’ultima fase di vera espansione economica? E denunciare il delirio di spese moltiplicate per quarantuno e seguite oggi da una sforbiciata dello «zero virgola qualcosa» per dare uno zuccherino alla plebe furente sarebbe qualunquista, demagogico, populista? Ma per favore!
Ha ragione il politologo Antonio Merlo, della University of Pennsylvania, che in Mediocracy sostiene appunto che «L’Italia è una Repubblica fondata sulla mediocrità, una “mediocracy”. Cioè un sistema che seleziona e promuove scientificamente una classe dirigente di basso profilo che non è funzionale al Paese ma al partito. Al leader. Al segretario». Una classe vecchia, come confermano anche i dati dell’Anci: su oltre 8000 sindaci, solo 70 hanno meno di 30 anni e gli under 35 non sono neppure 500, ovvero il 6% del totale. Una classe di cultura medio-bassa. Che ha interessi personali così diversi da quelli del Paese da diventare conflittuali. È un qualunquista, demagogo e populista il professor Merlo? Ma andiamo!
Era una qualunquista, demagoga e populista Matilde Serao? Eppure un giorno, esasperata dal «cattivo odore di stantio» emanato da una certa politica soprattutto nella sua città, scrisse in Il ventre di Napoli del 1884, parole furibonde. I partiti di allora, ovvio, non ci sono più. Ma l’impasto di incoerenze, malafede, inciuci e opportunismo è rimasto lo stesso: «Vi sono dei cattolici che sono italianissimi; vi sono degli anticlericali che sono credenti; vi sono dei clericali che sono democratici; vi sono dei democratici che sono imperialisti; vi sono dei liberali che restaurerebbero la pena di morte; vi sono dei repubblicani autoritarii e assolutisti; vi sono dei socialisti che adorano il Re; vi sono dei radicali perfettamente monarchici».
Tutti uguali? No, rispondeva quella grande giornalista. Proprio per niente: «A me importa poco che vadano al Consiglio comunale dei clericali, dei borbonici, dei moderati, dei liberali, dei democratici, dei socialisti, o degli anarchici: tutto ciò mi è indifferente. Io voglio degli uomini onesti: io voglio delle coscienze secure: io voglio delle anime austere. Le loro opinioni politiche non mi riguardano: solo i loro sentimenti morali m’interessano. Non voglio ladri, io, al Comune; e per ladri non intendo solo quelli che si mettono in tasca il denaro mio, il mio povero e scarso denaro, ma tutti quelli che aiutano i ladri miei o che permettono, chiudendo gli occhi, che mi si rubi. Non voglio, al Comune, né affaristi, né compari di affaristi, né rappresentanti di affaristi, né amici degli amici degli affaristi».
Era un qualunquista, demagogo e populista Luigi Einaudi, che dopo aver condotto formidabili battaglie di civiltà (come quella per liberare migliaia di bimbi italiani ridotti in schiavitù nelle vetrerie francesi) e dopo essere stato ai margini durante il Ventennio sarebbe diventato nel dopoguerra capo dello Stato e viene oggi venerato, giustamente, come una delle figure più limpide della nostra storia e uno dei padri della patria? Eppure una mattina, dalle pagine del «Corriere della Sera», calò sui politici di allora una scudisciata: «A Roma spadroneggia un piccolo gruppo di padreterni, i quali si sono persuasi, insieme con qualche ministro di avere la sapienza infusa nel vasto cervello».
Era il 1° febbraio 1919, la Grande Guerra era finita da poche settimane, Guglielmo II era fuggito nei Paesi Bassi, a Berlino erano stati appena rapiti e uccisi Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, a Parigi s’era aperta la Conferenza di pace e da noi, dove Luigi Sturzo aveva appena fondato il Partito Popolare, cominciava quel «biennio rosso» che si sarebbe concluso con una dura sconfitta delle sinistre e l’avvento del fascismo.
Alla guida del governo c’era Vittorio Emanuele Orlando, al Tesoro Bonaldo Stringher aveva appena sostituito Francesco Saverio Nitti, alla Giustizia c’era Luigi Facta. Gente che Einaudi considerava, per usare un eufemismo, in larga parte inadeguata. Il futuro capo dello Stato, appoggiando gli industriali «inferociti», accusava l’esecutivo: «Non mantiene le promesse, impedisce con i suoi vincoli il movimento a coloro che avrebbero voglia di agire, fa perdere quei mercati che gli industriali italiani erano riusciti a conquistare, prepara disastri al Paese, accolla sempre nuovi oneri alle industrie». E perché? Per la sua ossessione di mettere le mani su tutto, immaginare «monopoli che non sa poi come amministrare», rivendicare compiti che poi non sa assolvere impedendo insieme che «provvedano i privati».
Basta, scriveva: «Bisogna licenziare questi padreterni orgogliosi [...] persuasi di avere il dono divino di guidare i popoli nel procacciarsi il pane quotidiano. Troppo a lungo li abbiamo sopportati. I professori ritornino ad insegnare, i consiglieri di Stato ai loro pareri, i militari ai reggimenti e, se passano i limiti d’età, si piglino il meritato riposo». Insomma: «Ognuno ritorni al suo mestiere». E «si sciolgano commissioni, si disfino commissariati e Ministeri» così che «un po’ alla volta tutta questa verminaia fastidiosa sia spazzata via. Coloro che lavorano sono stanchi di essere comandati dagli scribacchiatori di carte d’archivio» superiori alla società governata «soltanto per orgoglio e incompetenza».
Parole durissime. Era un qualunquista, Einaudi? Un demagogo? Un populista? Un «istrione della Suburra», come Gerardo Bianco liquidò Beppe Grillo? È ovvio che (come noi oggi, del resto) il grande economista non ce l’aveva con tutti i parlamentari. Poteva mai mettere nel mazzo della sua invettiva senatori come Benedetto Croce o Giustino Fortunato con i quali avrebbe poi firmato il Manifesto degli intellettuali antifascisti o Giovanni Verga o lo stesso Luigi Albertini che era anche il direttore del «Corriere della Sera» sul quale pubblicava l’articolo di cui parliamo?
Da convinto liberale ce l’ha, spiega Alberto Giordano della Statale di Milano, autore del volume Il pensiero politico di Luigi Einaudi, con «quel pezzo di mondo politico, ruotante intorno soprattutto a Nitti ma non solo, che nella scia della Prima guerra mondiale ha costruito un sistema bloccato di potere e di clientele. Una vera e propria casta autoreferenziale che confonde continuamente, a suo avviso, la pubblica amministrazione, l’economia, lo Stato, la finanza, la clientela...». Insomma, un quadro piuttosto simile a quello di oggi. E forse, se i Padreterni di allora l’avessero ascoltato senza fare spallucce, tre anni dopo ci saremmo evitati la Marcia su Roma.
Certo, come ricorda giustamente Eugenio Scalfari, la citazione einaudiana «è un vero boomerang per la tesi di chi pens...
Indice dei contenuti
- Cover
- Frontespizio
- Licenziare i Padreterni
- Appendice