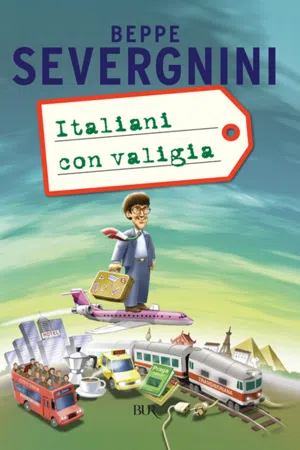![]()
1
ITALIANI ALL’ESTERO
«Cœlum, non animum mutant, qui trans mare currunt.»
Orazio, Epistole
![]()
ITALIANI ALL’ESTERO
È di moda deridere i turisti. Descriverli come bande di giullari involontari che girano il mondo per fornire spunti agli umoristi e tenere allegri i dipendenti delle agenzie di viaggio. L’atteggiamento non è nuovo: tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento, non c’era straniero in visita in Italia che non si lasciasse sfuggire un’imprecazione sarcastica quando si imbatteva in altri stranieri, soprattutto se erano connazionali e gli sedevano accanto in trattorie pittoresche che egli credeva di aver scoperto.
Poi è venuto il nostro turno: negli anni Cinquanta anche l’Italia ha cominciato a produrre una classe media da esportazione, ansiosa di riempire di souvenir mensole sempre più lunghe di case sempre più grandi. Secondo una stima attendibile, oggi gli italiani viaggiano 2,3 volte più di quanto viaggiassero vent’anni fa, e spendono il 15 per cento del proprio reddito per spostarsi, contro il 9 per cento del 1970. Inevitabilmente, anche noi abbiamo preso a dare spettacolo.
Sebbene la derisione sistematica del turista sia ingiusta e ingenerosa, talvolta, bisogna ammettere, è difficile resistere alla tentazione. Chiunque abbia provato ad arrivare a Casablanca su una nave carica di italiani che non riescono a trovare il Marocco su una carta geografica, sa quanto sia difficile evitare un sorriso di sufficienza. Ma il sorriso dovrebbe essere un atteggiamento passeggero, e lasciare il posto a una domanda: perché tanta gente viaggia? Perché gli italiani di ogni condizione sociale, ogni volta che si trovano intorno a un tavolo, parlano di aerei, di isole, di tariffe speciali e di ragazze che vivono sulle isole raggiungibili con aerei a tariffa speciale?
Nessuno ha fornito una spiegazione esauriente di questo fenomeno. La bruciante passione italiana per i viaggi, gli espatri e i soggiorni all’estero non ha ancora i suoi studiosi, i suoi interpreti e i suoi cantori. Recentemente un settimanale ha scritto che fuggono «i giovani, gli imprenditori, i pensionati con qualche lira, i portaborse in odor di mazzette». Non sono i soli: il vizio di viaggiare — che, sosteneva Aldous Huxley, «come ogni altro vizio è imperioso, e pretende dalla vittima tempo, denaro, energia e il sacrificio delle comodità» — conquista nuovi adepti e acquista nuove motivazioni. Oggi si parte per distrarsi, per evadere, per avere qualcosa da raccontare, per il desiderio di porre qualche frontiera tra sé e la spettacolare confusione che regna in Italia.
Il risultato di tutto questo si può sintetizzare con tre parole: siamo arrivati dappertutto. Secondo uno studio recente, il nostro «raggio d’azione» è aumentato di dieci volte in vent’anni. Le cosiddette «mete turistiche» del pianeta non sono più soltanto popolate di tedeschi che puntano la sveglia per occupare i posti migliori sulla spiaggia e intorno alle piscine, di arabi che nell’intimità delle stanze d’albergo passano il tempo con la testa dentro il mini-bar, di giovani scandinavi con lo zaino che nelle periferie dell’Asia sfidano gli indigeni in una gara di cattivi odori. Ora ci siamo anche noi: gli italiani che per generazioni attraversavano il mondo con la valigia di cartone si stanno prendendo una umana, comprensibile, chiassosa rivincita.
Le statistiche, per illustrare questo fenomeno, non bastano. Dicono infatti quanto viaggiamo, ma non perché viaggiamo e soprattutto come viaggiamo. Scrivere che, nel 1991, 605.000 italiani hanno visitato la Grecia è molto meno interessante che ascoltare le conversazioni dei vicini nella tavola calda sul traghetto in partenza da Brindisi. Riportare che nel corso dello stesso anno 5949 connazionali sono entrati in Paraguay non spiega cosa diavolo ci sono andati a fare. Sapere che altri 478.853 italiani hanno visitato gli Stati Uniti non è istruttivo come guardare dentro la valigia del 478.853esimo, dove troveremo tre cucchiaini di plastica con scritto MCDONALD’S, un disco e un paio di scarpe regolarmente in vendita in Italia, due magliette con la scritta HARVARD UNIVERSITY passate di moda nel 1977.
Nelle prossime pagine — prima di illustrare le scoperte e le debolezze di quello strano viaggiatore con taccuino che va sotto il nome di giornalista — tenterò di colmare in parte questa lacuna, descrivendo alcune delle cose che ho visto: da quelle abominevoli a quelle lodevoli, passando per quelle sorprendenti. Questa prima parte del libro non ha intenzione di offrire alcun messaggio — me ne guardo bene — e neppure una grande teoria sull’argomento: non sono un turista professionista, infatti, né un professionista del turismo. Intendo proporre soltanto l’onesta testimonianza di un italiano che di tanto in tanto, negli ascensori del mondo, ha finto di essere greco per non essere risucchiato in discussioni del tipo: «È possibile distinguere di notte un cinese da un giapponese?» (è accaduto: martedì 20 ottobre 1992, ore 21.30, Pechino, hotel Jianguo, ascensore di sinistra).
Possiamo iniziare col dire che gli «italiani con valigia» possiedono straordinarie qualità. Le vedremo in dettaglio. Citiamone soltanto alcune, per ora. Siamo curiosi, e adoriamo i confronti tra la nostra condizione di italiani e quella dei popoli che visitiamo (perché stanno meglio o perché stanno peggio, non importa: quel che conta è avere un argomento di conversazione). Siamo complessivamente onesti, e giustamente cinici: l’italiano che torna da un viaggio sottoscriverebbe, senza conoscerla, la battuta di Arthur Koestler: «Viaggiando, si impara che tutti i popoli hanno torto». Siamo indiscutibilmente generosi: quasi sempre, ad esempio, rinunciamo a controllare i conti dei ristoranti, un’attività che occupa invece circa metà delle ferie di uno svizzero o di un austriaco (la cosa, va da sé, ci rende popolari tra i camerieri di tutto il mondo).
Un’altra qualità dell’italiano in viaggio è questa: non soltanto non si innervosisce incontrando altri italiani, ma festeggia l’avvenimento, manifestando un orgoglio nazionale che in patria tiene ben nascosto. Questa caratteristica contravviene a una delle «leggi di natura del turismo» enunciate alla fine del secolo scorso dalla scrittrice americana Agnes Replier: «Non possiamo imparare ad amare gli altri turisti. Ma, meditando sobriamente sull’impossibilità che essi amino noi, possiamo raggiungere un compromesso basato sulla tolleranza, e accettare l’altrui presenza e l’altrui divertimento».
Un aspetto meno entusiasmante del turismo italiano è la sua rumorosità. È scientificamente provato che una comitiva di cinquanta bergamaschi produce gli stessi decibel di cento francesi, centocinquanta tedeschi e duecento giapponesi. Questa rumorosità spesso non ha nulla a che fare con la scortesia, ed è invece un’espressione del piacere di stare al mondo (soprattutto in un mondo pieno di duty-free shops). Altre volte è più sinistra e aggressiva. Vent’anni fa Giorgio Manganelli, in procinto di imbarcarsi su un volo per la Cina, descrisse con maestria i compagni di viaggio, un gruppo di imprenditori che si recavano a Pechino in occasione di un’esposizione industriale. Questa la partenza dall’aeroporto di Fiumicino: «È la prima esposizione italiana, il viaggio è lungo, misteriosa la meta e poi gli operatori economici hanno idee assai vaghe su quello che può attenderli. Sono vigorosamente eurocentrici e incautamente estroversi. Nella folla si leva una voce milanese, rancorosa, oscuramente offesa, e chiede assicurazioni aggressive: non lo metteranno mica a dormire in una capanna? Un addetto della compagnia aerea accenna alla millenaria civiltà, ma il sanguigno eurocentrico diffida. Qualcuno gli ha insegnato che al di fuori della valle padana prevale l’antropofagia, e gli unici successi nell’opera di decannibalizzazione si debbono ai missionari che hanno imposto il venerdì di magro. La folla degli operatori è chiassosamente mascolina, e si ha l’impressione di una gigantesca gita in campagna da parte di un istituto correzionale dai risultati modesti». Guardatevi intorno, e vedrete che non molto è cambiato.
A un’altra caratteristica di fondo del turismo italiano ho fatto cenno poc’anzi: gli italiani che viaggiano, finora, hanno ispirato pochi esegeti. In altre parole, se ne è scritto sempre poco. Esiste una robusta letteratura, invece, sui «viaggi di gruppo» degli americani, descritti per la prima volta da Mark Twain il quale, l’8 giugno 1867, si imbarcò sul vascello a vapore Quaker City, e raccolse poi le sue osservazioni in un libro dal titolo Innocenti all’estero. Gli inglesi cominciarono a viaggiare per diletto appena la rivoluzione industriale prese a fornire loro i mezzi necessari. Il «Grand Tour», oltre a creare un nuovo gusto in pittura e in architettura, scatenò fantasie romantiche, suggestioni classicistiche e incontrollati impeti verso le antichità riscoperte, il sole, il cibo, il vino. Per tutti questi motivi l’economista Adam Smith considerava il viaggio una «pratica assurda», dalla quale «i giovani ritornano più dissipati, più presuntuosi, più incapaci e con meno princìpi». Nessuno tuttavia gli prestò ascolto, e il numero dei «turisti» continuò ad aumentare. Nel 1841 il signor Thomas Cook raccolse cinquecento persone sopra un treno e le portò in gita da Leicester a Loughborough, distanza undici miglia: era nato il «viaggio di gruppo», destinato a cambiare il mondo.
Il progenitore degli scrittori di viaggio moderni fu proprio un inglese, Laurence Sterne, che nel 1768 scrisse A Sentimental Journey through France and Italy, prototipo del «viaggio in Europa», trasgressivo e liberatorio: il signor Yorick, timorato uomo di chiesa, parte per una vacanza in Francia e in Italia, dove non arriverà mai. Il lettore lo lascia a Lione, impegnato in schermaglie amorose con la cameriera di una locanda. A Sentimental Journey, a differenza dei libri di viaggio che l’avevano preceduto, non contiene dati, informazioni o descrizioni di paesaggi. La vacanza è semplicemente una condizione dello spirito, e il viaggio è una scusa: lo scrittore è all’estero, lontano da casa, con la mente all’erta. Da allora, questa è la ricetta del travel book, e questo è il segreto del travel writer. I mari di Conrad o i tropici di Graham Greene, in altre parole, non c’è bisogno di andarli a cercare tanto lontano. Sono già nella testa di tutti noi.
Questo, in teoria, avrebbe dovuto esser valido anche per gli autori italiani. Ma non è stato così. Dopo essere stata all’avanguardia all’epoca delle grandi scoperte, la nostra «coscienza geografica» si è lentamente addormentata. Nel 1850 Emilio Dandolo, il primo «turista» italiano in Sudan di cui si abbia certezza, si lamentava che pochi viaggiassero e ancora meno scrivessero. E all’inizio del Settecento, in una prefazione al Giro del mondo di Giovan Francesco Gemelli Careri, uno studioso dell’epoca esprime lo stesso concetto. Dopo aver riferito questi episodi, Claudio Cerreti della «Società Geografica Italiana» mette in guardia contro «la tendenza della cultura italiana a sottovalutarsi», ma ammette che «il problemino» — così lo chiama — esiste: nel secolo scorso qualsiasi commerciante francese o naufrago olandese che tornasse a casa da un lungo viaggio, per prima cosa pubblicava il suo libretto. Gli italiani scrivevano poco, e quel poco lo tenevano nei cassetti.
Non è questo il luogo per dibattere nei dettagli l’assenza di una «cultura del viaggio» in Italia. Ogni ipotesi è buona. La piacevolezza della «terra dove fioriscono i limoni» certamente non spingeva a lasciare il Paese; gli inverni del Nordeuropa, per contro, hanno contribuito certamente alla produzione e alla diffusione di «libri di viaggio», come lascia intuire lo scrittore Evelyn Waugh («Gli inglesi» affermò «si sono mezzi uccisi, e qualche volta si sono uccisi del tutto, soltanto allo scopo di scappare dall’Inghilterra»). Un’altra possibilità è che a noi italiani — fin troppo bravi nell’adattarci a nuovi ambienti e nuove circostanze — manchi quel senso di disagio (being un-at-home, «essere non-a-casa») che ancora oggi costituisce la molla della migliore letteratura di viaggio: l’ottimo Eric Newby, lungo il fiume Gange o sulla ferrovia Transiberiana, rimane un gentiluomo britannico, che s’adombra per la qualità del servizio. I viaggiatori italiani, dopo due settimane in Terra Santa, si scambiano inviti a cena con israeliani e palestinesi. Ecco forse perché l’Italia, scomparsi i Piovene e i Moravia, ha smesso di produrre «scrittori di viaggio»: perché noi italiani arriviamo sì in capo al mondo, ma ci stiamo troppo bene.
![]()
VISTO, FOTOGRAFATO, COMPRATO.
OVVERO, IL FALSO VIAGGIO
Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta nacque negli Stati Uniti una curiosa discussione accademica che vedeva protagonisti alcuni antropologhi specializzati in «comportamenti turistici». Alcuni sostenevano che i turisti moderni meritano tutto quanto gli tocca: essi amano infatti la «autenticità costruita» (staged authenticity), gli pseudo-eventi, e in generale le sceneggiate che vengono preparate per loro nel mondo, dalle oasi del Magreb alle riserve indiane degli Stati Uniti, dagli alberghi della Turchia alle trattorie di Trastevere. Secondo un’altra scuola di pensiero, i turisti sono invece vittime di tutto questo. Il desiderio di chi viaggia è infatti avere «esperienze autentiche», conoscere la realtà e «guardare dietro le quinte», per usare l’espressione di un accademico coinvolto nella diatriba.
Il campione di quest’ultima teoria si chiama Dean MacCannell, ed è professore di «scienze del comportamento» presso l’Università di California, nonché autore di The Tourist, A New Theory of the Leisure Class (Il turista, una nuova teoria della classe agiata). A suo giudizio, «desiderio dei turisti è condividere la vita vera dei posti che visitano», e il loro destino è non riuscirci, e venire per questo derisi. Convinto assertore dell’opinione contraria è Daniel J. Boorstin, autore di The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, e creatore di una celebre distinzione tra «il turista» e «il viaggiatore»: «Il viaggiatore (traveller) lavora per ottenere qualcosa; il turista (tourist) cerca il piacere. Il viaggiatore è attivo; va strenuamente in cerca di gente, avventure, esperienze. Il turista è passivo; aspetta che le cose interessanti gli accadano». He goes sight-seeing, «egli va a vedere le curiosità di un luogo», conclude Boorstin disgustato.
Ebbene: se qualcuno mi chiedesse dove collocare il moderno turista italiano — se nell’olimpo dei travellers oppure giù, nella bolgia dei tourists — sarei in difficoltà. La grande maggioranza dei connazionali visti in azione sembra infatti condividere le caratteristiche di entrambi i gruppi. Raramente un dentista ligure in viaggio in Marocco si ribella contro «un pranzo nelle tipiche tende berbere», e quasi mai a una signora di Pavia viene in mente che la giovane cameriera di Bangkok abbia un nome migliore dell’orribile «Jessica» impostole dalla direzione dell’albergo. D’altro canto, è vero che quando accade l’imprevisto — uno dei camerieri berberi si rivela essere un docente universitario disoccupato, Jessica invita la signora e il marito a conoscere la famiglia — gli italiani si entusiasmano. Nelle serate d’inverno, in Liguria e a Pavia, racconteranno la triste storia del docente costretto a fare il cameriere, non lo spettacolo nelle tipiche tende berbere.
Ho rilevato spesso questa apparente contraddizione, ma credo di dover essere severo. Per bontà d’animo, ignoranza delle lingue o semplice pigrizia, i turisti italiani tendono a essere passivi: più turisti, insomma, che viaggiatori; più rassegnati alle rassicuranti ovvietà del falso viaggio che interessati a vedere il mondo com’è. Ho notato, ad esempio, che i partecipanti ai tour organizzati raramente protestano se a Cipro, durante la solita micidiale serata di musica folkloristica, la cantante libanese intona Stranger in the Night. Difficilmente gli italiani insorgono quando le guide locali li consegnano per ore dentro orribili negozi di artigianato e souvenir. Quasi mai si ribellano ai crudeli «animatori» dei villaggi-vacanze (molti dei quali sono convinti che il resto del mondo abbia un’età mentale di nove anni), ricordando loro di avere una laurea, due figli e un ufficio avviato, e rifiutando perciò di esibirsi nel «gioco del tennis con le padelle».
Un’altra circostanza che non depone a favore degli «italiani con valigia», e tende a confinarli tra i turisti piuttosto che innalzarli tra i viaggiatori, è la strepitosa, inguaribile, inspiegabile passione per l’acquisto, la contrattazione, l’occasione, l’affare. Questa attività — per motivi a me ignoti — appassiona profondamente i connazionali in vacanza all’estero, e assorbe molte delle loro en...