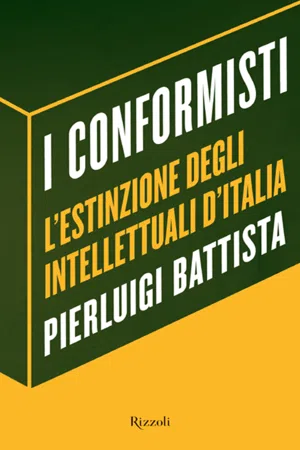![]()
Parte prima
Nostalgie e (mancate) revisioni
![]()
Perché gli intellettuali si innamorano dei tiranni
Ian Buruma ha spiegato come mai molti intellettuali della sinistra occidentale si siano infatuati per l’ultimo dei «dittatori sanguinari che opprimono i Paesi poveri»: il presidente del Venezuela Hugo Chávez, il nuovo caudillo che seduce i cuori fanatizzati dall’antiamericanismo. Ma l’antiamericanismo non basta, e nemmeno la maledizione storica dell’America Latina, luogo di sogno, ma anche terra fertile di despoti populisti e commedianti della rivoluzione descritti con impareggiabile sarcasmo da Mario Vargas Llosa. L’altro ingrediente indispensabile all’incantamento per il despota liberticida è invece la peculiare fatuità degli intellettuali, perennemente ammaliati dalle dittature. Votati a mille cause sbagliate. Culturalmente schiavi di ogni seduzione totalitaria. Impermeabili a ogni principio di realtà.
George Orwell, uno dei più grandi e coraggiosi saggisti politici del XX secolo, si interrogava sull’enigmatico fenomeno di scrittori, poeti, artisti, registi sensibilissimi e geniali artefici di opere immortali, eppure destinati, nel loro approccio alla politica, a vedere ottenebrate le pur smaglianti facoltà mentali di cui erano dotati. Persone generose e delicate, gli intellettuali del Novecento, una volta immersi nel loro onirismo politico, non hanno indietreggiato di fronte alle più stolte nefandezze. Paul Johnson ha ricordato le parole di Bertolt Brecht, grande drammaturgo, di fronte alla mattanza degli anni staliniani: «Più innocenti sono, più meritano una pallottola in testa». Lo stesso Brecht che reagì così alle purghe moscovite in cui venne stritolata la sua ex amante Carola Neher: «Se è stata condannata, devono esserci delle prove contro di lei».
Louis Aragon vergò immortali versi per glorificare gli assassini della Gpu. Martin Heidegger vide nel Führer il compimento di millenni di metafisica. Ingordo di dittature, George Bernard Shaw volle battere ogni record nell’arte del panegirico rivoluzionario, e giunse a elogiare contemporaneamente Stalin e Mussolini: da entrambi ammirati come eroi dell’antidemocrazia e dell’antiliberalismo. E del resto furono frequenti e movimentati i passaggi dall’uno all’altro totalitarismo. Pochi giorni prima di togliersi la vita, uno scrittore finissimo come Pierre Drieu La Rochelle meditava la trasmigrazione intellettuale dal filonazismo antisemita alla purezza bolscevica dell’Armata Rossa trionfante. Delio Cantimori passò dal fascismo al comunismo, e gli storici ancora tentano di capire quanto comunismo già fosse presente nella sua scelta fascista e quanto fascismo sia rimasto nella sua nuova identità comunista.
Politicamente soggiogati dalle sirene totalitarie, gli intellettuali cantori delle dittature sembravano versati persino nell’arte della delazione (come hanno raccontato due vittime del «lirismo rivoluzionario»: Milosz e Kundera) e in quello della denigrazione nei confronti di chi, anziché sottostare alla menzogna politica, pretendeva di guardare la realtà annebbiata dal Dogma. Del linciaggio furono vittime tra gli altri André Gide, di ritorno da un viaggio in Urss, e Arthur Koestler, che per aver denunciato le efferatezze del «dio che è fallito» venne messo alla berlina da Simone de Beauvoir in un romanzo (peraltro magnifico) come I mandarini. Non c’è da stupirsi se, dopo Lenin e Mao, Stalin e Hitler, Mussolini e Fidel Castro, molti intellettuali, orfani del mito rivoluzionario e antiborghese, siano alla ricerca spasmodica di nuove leggende. Magari Chávez non sarà all’altezza della situazione. O forse assisteremo all’ennesima conferma della profezia marxiana sulla tragedia che si ripete come farsa. Anzi, non forse: certamente.
Resta però da chiedersi per quali insondabili misteri dell’animo umano anche un intellettuale di storia libertaria come Gianni Vattimo, per esempio, decida di recitare senza imbarazzi il ruolo dell’apologeta dei tiranni, e debba proclamare la sua preferenza per i metodi dispotico-populisti del venezuelano Chávez a scapito del grigiore senza nerbo dei leader democratici occidentali.
Riemerge una caparbia attitudine a non vedere l’evidenza, a non accorgersi che, se si parlasse di noi anziché di contrade piacevolmente remote ed esotiche, sarebbe arduo accettare anche una minima parte di ciò che effettivamente accade nelle dittature incautamente elogiate. E agiscono ancora inconsciamente, residui non smaltiti di passate stagioni di innamoramento totalitario. Impressione rafforzata da ciò che si è letto su «il manifesto», dove la sdegnata esecrazione delle vergogne che trapelano dalla Guantánamo americana si accompagna allo strabiliante elogio della «dignità» della Corea del Nord, cioè uno dei più mostruosi lager di tutti i tempi. Oppure dalla lettura di chi si mostra giustamente preoccupato per la deriva autoritaria nelle misure repressive antiterrorismo, ma non sembrava granché scosso dalle disgustose minacce con cui Fidel Castro («il popolo, indignato con atti di tradimento così sfacciato, è intervenuto con la sua espressione di fervore patriottico») incitò nel 2005 le squadracce di regime a malmenare i dissidenti cubani prima del loro arresto.
Ma la spiegazione in chiave ideologica appare insufficiente, e persino trita. Resta l’interrogativo: perché agli intellettuali piace tanto suonare il piffero per le tirannie (purché lontane)? Soccorre ancora la «legge di Orwell»: sedotti sino al delirio da totalitarismi rossi e neri, gli intellettuali anche più prestigiosi, pur maestri nel loro specifico campo espressivo, d’improvviso si trasformano in ottusi propagandisti, come se un sortilegio maligno avesse vanificato la loro intelligenza creativa. Tale era ed è la fascinazione fideistica per il mito rivoluzionario da appannare senza rimedio ogni parvenza di lucidità analitica e aderenza ai fatti.
Così al grande germanista Cesare Cases, scomparso nel 2005, la finezza intellettuale non impedì di trascorrere lunghi soggiorni a Berlino Est senza rabbrividire per quella città adibita a carcere e di salutare con mestizia, nel 1989, il crollo del muro berlinese alla stregua di una vittoria del capitalismo occidentale (come Günther Grass, del resto). E così Louis-Ferdinand Céline e Jean-Paul Sartre potevano scambiarsi terribili invettive («lurido spione»; «somaro occhialuto») l’uno senza rammaricarsi di aver sostenuto lo sterminio degli ebrei, l’altro in procinto di teorizzare l’opportuno silenzio sul Gulag comunista.
Chi si lamenta della scomparsa dei grandi maître à penser dovrebbe ricredersi: gli intellettuali sono sempre troppo prodighi propalatori di sciocchezze politiche. Si leggano i loro romanzi, si assista alle loro piéce teatrali degne del Nobel, si guardino i loro film, si ammirino le loro opere d’arte, ma senza farsi impressionare dalle loro roboanti indicazioni politiche. Sempre, immancabilmente, sbagliate.
La solita liturgia: l’anatema contro gli ex
Anche perché gli intellettuali, anziché guardarsi dentro e riconoscere i propri errori, sono piuttosto inclini a una liturgia feroce in cui, assieme all’autoassoluzione collettiva, si inscena la diffamazione conformista e l’isolamento dell’irregolare, del recalcitrante che si permette di spezzare l’unità omertosa dei mandarini abilitati ad amministrare il rigore della «giusta linea».
Uno dei riti più frequentati è per esempio l’anatema contro l’ex, la denigrazione del convertito, il torvo sospetto di tradimento e apostasia. In tempi di ferro e di fuoco, la scomunica dell’ex trascinava con sé il frutto velenoso delle accuse marchiate sul corpo del reprobo bollato per sempre come un bieco «rinnegato» e un intellettuale come Arthur Koestler, dopo aver rotto con il comunismo e averne denunciato gli orrori veniva isolato, diffamato, dileggiato, trattato come un infrequentabile invasato. «Sulla stampa comunista si giunse a pubblicare una cartina con una freccia che indicava la villetta dove abitava in quel periodo e la pressione fu tale che il traduttore francese chiese all’editore di omettere il suo nome nelle ristampe» ha scritto Renzo Foa nel suo In cattiva compagnia. Viaggio tra i ribelli al conformismo.
Oggi è tutto più blando e caricaturale, ma la diffidenza per l’ex denuncia la persistenza di una cultura che privilegia i valori della fedeltà e dell’appartenenza su quelli del libero esame critico, che tratta con disprezzo chi manda in frantumi i vincoli con la sua chiesa (compresa la chiesa laica) e si avventura lungo sentieri eterodossi: «Extra ecclesiam nulla salus».
Purtroppo il pregiudizio verso l’exeità (conio di Giuliano Ferrara) rende ciechi sull’esperienza spesso drammatica di chi con fatica e dolore ha spezzato ogni legame con il suo mondo d’appartenenza.
Ignazio Silone diceva che non c’è niente di più luttuoso della catastrofe di un’illusione. Eppure l’odio per l’ex ha favorito la tentazione di premiare il contrario dell’ex, cioè il «post» che non ha mai messo in discussione se stesso ma ha armonicamente giustapposto personalità diverse in cui il dopo non ha mai rappresentato una sofferta resa dei conti con il prima costellato di errori. Invece degli ex, sono stati premiati i «redenti», come recita il titolo del libro di Mirella Serri in cui si illustrano le strategie di occultamento e autopurificazione degli intellettuali passati indenni dal fascismo trionfante all’antifascismo.
Non stupisce perciò che, mentre viene intonato il coro della riprovazione per chi si è reso colpevole di aver cambiato idea e di averlo persino ammesso, sia stato per esempio accolto con partecipe simpatia e struggente nostalgia il ritorno sulla scena di Joan Baez, capace di ridare slancio e vigore a ricordi ormai appassiti e macchiati dal dubbio. Joan Baez è stata protagonista della stagione generosa della protesta contro la guerra del Vietnam, ma ha anche avuto il torto (solo parzialmente riconosciuto come tale) di aver brindato con i dirigenti «nord-vietnamiti, laotiani e cambogiani che nel frattempo assassinavano e torturavano oppositori politici nonché preti, pastori e bonzi di tutte le religioni», come ha scritto Massimo Introvigne. Se avesse ammesso di aver commesso un torto, sarebbe stata sbeffeggiata come un’«ex». Non lo ha fatto e perciò può di nuovo calcare il palcoscenico contro il bieco imperialismo americano del Duemila, ammirata da tutti come alfiere di un nobile ideale. Ha avuto torto ma non ha pagato dazio.
Per forza, il prezzo dell’impopolarità lo pagano sempre gli altri: gli ex.
George Orwell manipolato e tradito
Non esiste solo l’impopolarità: il prezzo pagato dagli apostati può essere anche un desolante fraintendimento. Come il destino che ha colpito il capolavoro di George Orwell, 1984, il romanzo più equivocato, male interpretato, sottoposto a letture ingiuste e fuorvianti della storia letteraria del Novecento. Se il tempo ha sì decretato La vittoria di Orwell, come recita il titolo di un libro di Christopher Hitchens, tuttavia 1984 attende ancora un risarcimento per le manipolazioni semantiche cui è stato incessantemente sottoposto.
Il misconoscimento di Orwell, come spiega Hitchens, non è il frutto di un accecamento collettivo, ma fa tutt’uno con il fastidio per una corrente anomala e irregolare nella storia ideologica del Novecento. Presuppone la preventiva cancellazione di un pensiero di sinistra, minoritario e messo ai margini, che proprio nel nome dei valori della sinistra seppe essere e dirsi con coraggio tanto antifascista quanto anticomunista. Critico della boria di cui l’imperialismo britannico era permeato, vicino alle traversie dei ceti popolari più colpiti dalla «distruzione creatrice» della modernità e del capitalismo, ciò nonostante Orwell sfidò la sordità degli intellettuali del suo tempo che potevano ma non volevano vedere il Gulag, i massacri degli anarchici e dei trotzkisti per opera degli agenti del comunismo stalinista nella Barcellona della guerra civile spagnola, i meccanismi implacabili del terrore poliziesco che imperversava nella patria del socialismo realizzato. «La colpa di tutte le persone di sinistra dal 1933 in avanti», ha scritto Orwell in Nel ventre della balena e altri saggi, «è di aver voluto essere antifasciste senza essere antitotalitarie.»
Questo è il tema di 1984. E questa è la radice del suo rifiuto: si poteva capire in tempo, riconoscere la natura totalitaria dell’utopia comunista ben prima del crollo del Muro di Berlino. Perciò, per annichilire o anestetizzare questo passato compromettente di indifferenza, si è fatto di Winston Smith una vittima della invadenza tecnologica «occidentale» e non piuttosto di uno Stato di polizia onnipotente. Un burattino nelle mani di un Leviatano mediatico ribattezzato Grande Fratello e non della tirannia del partito unico che uccide l’anima e il pensiero, riscrive impunemente il passato, tiene i sudditi al guinzaglio di una divinità ideologica. La vittima di una mera violazione della privacy, non di un potere politico illimitato e senza argini.
Questo rovesciamento della realtà orwelliana ha prevalso a lungo. Ancora nel 1984 un supplemento dell’«Unità» pubblicava un’intervista a Enrico Berlinguer in cui il segretario del Pci si diceva convinto che Orwell avesse voluto alludere a un capitalismo abnorme e ipertecnologizzato e non alla sua antitesi incarnata nel dispotismo comunista.
Oggi lo stesso Lorin Maazel, che ha fatto di 1984 un’opera lirica presentata alla Scala di Milano, si dice convinto che il romanzo di Orwell «sembrava solo una metafora del totalitarismo sovietico, ma ora è dilagata anche nel libero mondo occidentale».
Ma nel «libero mondo occidentale» il romanzo di Orwell non ha mai subito limitazioni nella sua circolazione, mentre in Urss quel testo è stato vietatissimo fino all’ultimo. A differenza di tanti esegeti occidentali, chi doveva capire aveva infatti perfettamente colto il valore eversivo contenuto nelle pagine di Orwell. Hitchens riprende una testimonianza di Czeslaw Milosz, in cui il poeta polacco, scappato dalla prigione ideologica comunista, ha raccontato: «Perfino coloro che conoscono Orwell per sentito dire si stupiscono che uno scrittore che non ha mai messo piede in Unione Sovietica abbia una visione tanto nitida di come vanno le cose».
Gustaw Herling, autore con Un mondo a parte di uno dei classici della letteratura concentrazionaria in largo anticipo su Arcipelago Gulag, ha descritto a Silvio Perrella quale fosse lo stupore dei suoi connazionali polacchi nel leggere 1984: «Ma questa è la mia vita». Chi doveva capire, aveva perfettamente capito.
Perciò tra i difensori ideologici del «socialismo reale» non si tardò molto a rovesciare su Orwell un torrente di insulti, di invettive, di insinuazioni. Palmiro Togliatti, un po’ di anni prima della rilettura berlingueriana di 1984, ne liquidava l’autore con un epiteto sprezzante: «poliziotto coloniale». Isaac Deutscher, impegnato nella costruzione di una frontiera morale di stampo manicheo che avrebbe dovuto separare per sempre gli «eretici» del comunismo, meritevoli di salvezza, dai «rinnegati» (cioè i famigerati «ex») destinati alla dannazione eterna, apostrofò 1984 come il delirio malato di uno scrittore agli sgoccioli della vita, ossessionato dal «misticismo della crudeltà», che rispecchiava nella sua utopia totalitaria il frutto di una mentalità prigioniera della paranoia. Un incubo personale di Orwell, dunque, non un incubo della storia dolorosamente sperimentato in corpore vili da milioni di vittime.
Persino Italo Calvino descriveva Orwell come «un libellista di second’ordine» e rimproverò aspramente l’amico Geno Pampaloni, colpevole di aver recensito favorevolmente 1984, dimostrando così inappellabilmente di non essersi «premunito dall’infezione di uno dei mali più tristi e triti della nostra epoca: l’anticomunismo». Ancora nel 1971, Raymond Williams, a suo tempo autore con Eric J. Hobsbawm, come ricorda Hitchens, di un pamphlet in cui si «lodava l’invasione della Finlandia da parte dell’Unione Sovietica all’epoca del patto Hitler-Stalin», affermava che con la sua distruttiva visione del «socialismo reale» Orwell aveva «creato le condizioni per la sconfitta e la disperazione».
Ecco perché, sepolta l’utopia realizzata descritta con dettagliata precisione da Orwell, il recupero di 1984 attraverso una lettura ecumenica ed equivoca del Grande Fratello rischia di configurarsi come l’annullamento del senso stesso della battaglia culturale orwelliana: l’idea che il totalitarismo moderno avesse due volti, e non uno soltanto. Due colori, e non uno. L’Unione Sovietica, e non solo la Germania nazista. Un’idea che per decenni non è mai stata accettata dai sacerdoti dell’ortodossia antifascista incapace, come diceva lo stesso Orwell, di essere coerentemente e coraggiosamente antitotalitaria: proprio questo volevano testimoniare, diffamati o disprezzati, George Orwell o Albert Camus.
Jean-Paul Sartre, o dell’arte di avere torto
Perché ammettere di avere avuto torto, se c’è una storia esemplare che dimostra in modo paradigmatico come l’avere avuto torto non produca alcuna conseguenza e l’aver avuto ragione in anticipo addirittura penalizzi chi è stato dalla parte giusta troppo precocemente?
I giovani parigini, che gridavano «meglio avere torto con Sartre che ragione con Aron», credevano forse di enunciare solo un brillante paradosso. Invece descrivevano una legge crudele che nel 2005, celebrandosi contemporaneamente i centenari della nascita di Jean-Paul Sartre e Raymond Aron, è apparsa ancora una volta ineluttabile. Per Aron, che aveva ragione, poche e svogliate commemorazioni. Per Sartre, che aveva torto, il piedistallo della leggenda postuma, che replica e addirittura enfatizza la monumentalizzazione mitica goduta in vita. Chi ha avuto ragione quando era difficile e rischioso avere ragione, non ha visto riconosciuta la sua grandezza. Chi ha avuto torto quando era comodo e gratificante avere torto e ha riconosciuto le ragioni dell’altro solo molto tardivamente, è apparso ancora circonfuso da un alone fascinoso e seducente.
A determinare questo contrapposto destino influisce certamente la radicale diversità di due stili intellettuali. Uno, quello di Aron, per niente ampolloso e retorico, antitetico al profetismo incendiario dei devoti delle «idee generali» sordi al richiamo dei «dati di fatto». L’altro, quello di Sartre, decisamente più emozionale e spettacolare: non è forse più attraente ed elettrizzante l’ideale figura sartriana del maître à penser, l’apologia dell’engagement, il ricordo dell’epopea trasgressiva di Saint Germain-des-Prés, i riti proibiti consumati nelle caves, i maglioni esistenzialisti, i tavolini al Café Flore e al Deux Magots, il teatro, i romanzi, i brividi delle battaglie di strada? Eppure la diversità dei due stili non è sufficiente a spiegare l’abissale distanza dei due destini, anche a partire dal perfetto parallelismo delle vicende intellettuali di Sartre e Aron, segnato dall’implacabile propensione al torto del primo e dalla ripetitiva e sin quasi stucchevole aderenza alla ragione del secondo.
Ebbe ragione Aron ad abbandonare allarmato l’università tedesca alla vigilia dell’avvento di Hitler; ebbe torto il «petit camarade» Sartre, esattamente nello stesso periodo, a recarsi in Germania nella più totale indifferenza per ciò che gli stava accadendo intorno.
Ebbe ragione Aron a seguire Charles de Gaulle nel 1940 e a impegnarsi come redattore capo del giornale «La France Libre»; ebbe torto Sartre a risiedere nella Parigi occupata dai nazisti, dove le sue opere teatrali non trovavano difficoltà nell’aggirare gli ostacoli della censura tedesca.
Ebbe ragione Aron a non indietreggiare di un millimetro nella denuncia del totalitarismo comunista; ebbe torto Sartre a contribuire alla minimizzazione dei crimini sovietici, all’occultamento degli orrori del Gulag per non avvilire il morale degli «operai di Billancourt», al linciaggio di quelli che definiva i «cani» dell’anticomunismo, alla cancellazione nel 1952 della messa in scena della commedia Le mani sporche come atto di sottomissione ai diktat del partito di cui era diventato subalterno compagno di strada.
Ebbe ragione Aron ad analizzare con freddezza lo «psicodramma» parigino del Sessantotto e a coniare il termine «groupuscules» pe...