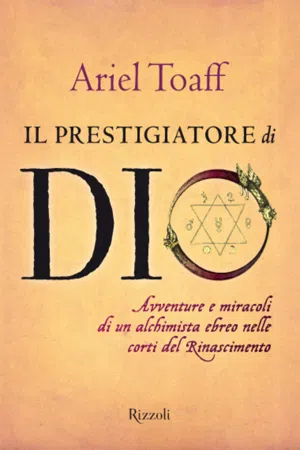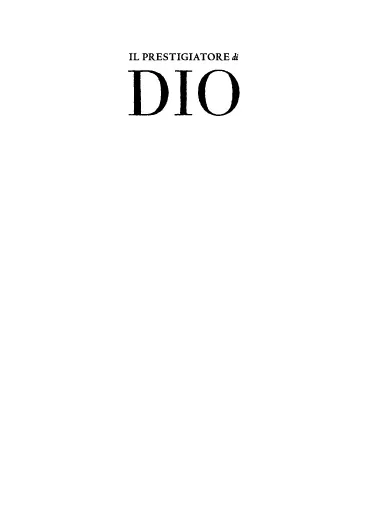«Ho conosciuto Daniel da Pisa, un personaggio autorevole che ha libero accesso alla presenza del papa e i suoi alloggiamenti a palazzo sono contigui a quelli pontifici. È ricco e onorato, colto e benvisto da tutti [...]. Gli ho detto: “Mi rendo conto che godi di grande prestigio presso il pontefice e i cardinali; non c’è quindi persona più adatta di te a fungere da intermediario tra me e gli alti vertici della Chiesa”.» Con accenti di profonda ammirazione l’avventuriero e falso messia David Reuveni così descriveva l’incontro avuto a Roma nel 1524 con il banchiere Daniel da Pisa, potente uomo di corte di Clemente VII, di cui era ascoltato consulente finanziario, oltre che amico personale dell’influente cardinale umanista Egidio da Viterbo.1
Non si trattava di un caso fuori del comune, perché nel Rinascimento e ancor più nel periodo successivo la presenza degli ebrei, medici, spagirici, alchimisti, inventori, letterati e finanzieri, nelle corti dei principi italiani, era frequente e spesso molto ambita. Considerare quindi la storia ebraica ponendo come pressoché unico punto di riferimento quello della triste situazione dei poveri ghetti ebraici, dei quartieri fatiscenti degli emarginati e dei diseredati, dove regnavano la discriminazione e l’isolamento, risulta fortemente riduttivo e in ultima analisi del tutto fuorviante. Non ho difficoltà a consentire che lo splendore e lo sfarzo delle corti non devono abbagliare in misura tale da farci dimenticare che il mondo ebraico era tutt’altro che univoco e in esso convivevano realtà diverse e talvolta contrapposte. Ma privilegiare quella che risultava come il triste esito delle persecuzioni e delle espulsioni a scapito dell’altra, che vedeva l’attiva e illuminata presenza dei cortigiani ebrei a fianco di quei principi che costituivano la forza trainante di un’Europa in continua trasformazione, significa rinunziare a comprendere a fondo il multiforme contributo ebraico alla storia europea di quel periodo e ridursi entro gli angusti limiti dei ghetti, dove c’erano soltanto compassionevoli vittime impegnate nello sforzo di sopravvivere in qualche modo tra timori e incertezze, del resto ampiamente giustificati, e nel continuo tentativo di dilatare gli stretti margini di sussistenza consentiti e tollerati.
Non diversamente sembrava pensarla il valente flebotomo e spagirico David De Pomis, per lunghi anni al servizio degli Orsini e degli Sforza nei loro feudi maremmani, come egli stesso riferiva con evidente compiacimento. «Grazie al Cielo passai al servizio del conte Niccolò Orsini, che mi invitò a professare l’arte medica per cinque anni nelle tre “città rifugio” di Pitigliano, Sovana e Sorano [...]. In seguito mi è stato richiesto di offrire i miei servigi alla nobile famiglia degli Sforza, che ha dato alla Chiesa tre cardinali, e nella contea di Santa Fiora mi sono trattenuto per tre anni».2 Nell’ultimo scorcio del Cinquecento, De Pomis approdava infine a Venezia alla corte dei dogi, divenendo medico personale di Alvise Mocenigo, cui si ispirava, se pur con qualche punta di piaggeria, nello scrivere «un discorsetto [...] dove provo le constitutioni venetiane essere divine, e promesso da Iddio per bocca del profeta di conservare tal santa Republica, regolatrice e maestra veramente di ogni buon ordine».3
Per mostrare ai suoi illustri padroni la sua profonda gratitudine, lo spagirico ebreo li ricompensava presentando loro due strabilianti invenzioni, frutto del suo eclettico ingegno. La prima era un metodo infallibile per verificare l’autenticità e l’efficacia del giacinto, uno zircone di colore rosso violaceo e di asserita provenienza indiana dalle stupende e portentose virtù, tra cui quella di costituire un infallibile antidoto contro la peste per chi lo possedeva «ligato in un anello al dito» o soltanto lo rimirava da vicino. L’esperto flebotomo aveva scoperto che, onde evitare le frequenti contraffazioni, occorreva mettere la pietra sul fuoco finché non fosse divenuta completamente bianca. Poi destramente si doveva farla raffreddare in un luogo non molto ventoso e, «se dopo divenuta fredda ritorna al suo pristino e vago colore, non è dubio alcuno delle sue maravigliose virtù, superando di gran lunga tutte l’altre gioie».4
Anche nella sua seconda invenzione esclusiva, che offriva ai signori di Venezia, De Pomis si preoccupava di alleviare le sofferenze degli ammalati «delle febri pestilentiali». Avendo senz’ombra di dubbio constatato che il rimedio più efficace nella cura degli appestati era la protuberanza ossea del liocorno, grattugiata come il parmigiano e sciolta nel vino, il rinomato secretista manifestava tutta la sua apprensione di fronte alla vendita incontrollata di liocorno falso. «Laonde» aggiungeva «per beneficio del mondo e a fine siano publicati li malfattori, che vendono con gran pregio la cosa qual non è di alcun valore, mi è parso in tal occasione manifestare una vera isperienza che fa conoscere il vero dal falso.» Si trattava di introdurre tre o quattro scorpioni «vivi e grandi» nel vaso che conteneva il magnifico corno medicinale. Se dopo qualche ora quei micidiali aracnidi trovavano morte crudele all’interno del recipiente, non v’era dubbio alcuno che «il lioncorno è ottimo e non è dinaio che pagare il possa, altrimenti è cosa falsa».5 Questa patente particolare, che era perfettamente in grado di por fine alle più ingannevoli e sleali adulterazioni, il brillante spagirico metteva graziosamente a disposizione dei dogi della Serenissima, di cui era con pieno merito «cortegiano illustrissimo». Le sue fortune al loro servizio sarebbero state in tal modo assicurate per lunghi anni.
Il mercantilismo, affermatosi in Europa con nuovo ed efficace assetto dopo il 1570, si esprimeva nella deliberata ricerca dell’utile economico dello Stato, finalmente liberato dalle pastoie giuridiche e religiose che ne avevano tradizionalmente frenato l’ascesa. Lo Stato, dalle tendenze sempre più secolarizzate, decideva di intervenire consapevolmente e senza inibizioni di carattere morale nella sfera economica, regolamentandola ai fini del proprio rafforzamento politico, commerciale e finanziario. In questo contesto si aprivano spazi importanti e nuove opportunità anche per quegli ebrei del mondo occidentale, mercanti internazionali, imprenditori e uomini di scienza, la cui attività era ritenuta da monarchi e principi profittevole e redditizia per il progresso economico e scientifico dei loro Stati.6
Diversamente però da quanto in molti hanno sostenuto anche di recente, non si trattava del massiccio ingresso degli ebrei come gruppo, ma di un’apertura concessa a individui in possesso di quelle caratteristiche compatibili con gli scopi che gli Stati intendevano perseguire e in grado di metterle proficuamente al loro servizio. Talvolta, come nel caso dei mercanti levantini e iberici, la porta precedentemente serrata si spalancava dinanzi a nuclei abbastanza numerosi di individui. Ma nonostante i privilegi ottenuti, talvolta notevoli, le limitazioni permanevano, sia a proposito della loro separazione dalla società cristiana circostante e la precarietà della loro dimora, che della condizione di inferiorità giuridica cui continuavano a essere sottoposti.
Per la massa degli ebrei diseredati, per quelli che non avevano saputo o potuto adattarsi alle nuove realtà economiche e rimanevano legati alle loro professioni tradizionali, come il prestito a interesse, ormai obsoleto, o il commercio al minuto dei generi d’abbigliamento, per lo più di seconda mano, rimanevano i ghetti e le interdizioni precedenti, accompagnate sovente dall’irrisione e dal disprezzo. La Roma pontificia in questo senso insegnava.
Presentare tout court principi, monarchi e imperatori nell’Europa di fine Cinquecento come «tutori delle comunità ebraiche», interessati alla loro presenza nello Stato e punto di riferimento nel conflitto con le autorità ecclesiastiche, mi sembra tuttavia inesatto.7 Quei signori infatti erano solleciti a proteggere e trattare con benevolenza, talvolta esagerata, soltanto quegli ebrei che ritenevano capaci di accrescere la ricchezza dello Stato o di contribuire al suo progresso scientifico. La politica mercantilistica che sostenevano non era ispirata a principi di tolleranza, ma di utilità. Quel che intendevano concedere ai singoli, talvolta con straordinaria larghezza e magnanimità, negavano caparbiamente alla massa degli ebrei, ritenuti inutili o peggio dannosi. C’erano quindi ebrei che, per le loro qualità intellettuali o per le straordinarie competenze mercantili di cui erano in possesso, andavano ammessi a far parte, senza obiezioni di sorta, dei ceti professionali di evidente e accertata eccellenza. Questi ebrei erano tutelati e favoriti a giusta ragione perché si riteneva che contribuissero in maniera tangibile all’utilità dello Stato. Gli altri, considerati sotto l’aspetto economico poco redditizi e sotto quello morale disdicevoli e disonorevoli, erano censurati severamente e giudicati degni d’infamia e di disprezzo.8 Erano infatti accusati di nascondere sotto mentite e ingannevoli spoglie innegabili caratteristiche di pravità e diabolicità, che si esprimevano in una ritualità ridicola e spregevole, dalla quale, da buoni cristiani, bisognava tenersi scrupolosamente alla larga. All’occorrenza era d’obbligo castigarli crudelmente perché si redimessero, raggiungendo con sollecitudine il salvifico fonte battesimale.
Dalla fine del Cinquecento la politica di principi e regnanti era intesa, in maniera indubbiamente lungimirante, a favorire inventori, tecnici, meccanici e ingegneri che, presentando nuovi progetti, richiedevano la concessione di privilegi, patenti e brevetti per le loro scoperte. L’apporto di questi «huomini di scientia», che operavano in una varietà di settori, contribuiva in maniera decisiva al rinnovamento tecnologico dello Stato, offrendo un impulso decisivo al suo sviluppo industriale e scientifico. Nuove sperimentazioni erano incoraggiate nei campi più diversi, spesso con l’introduzione di complessi macchinari, talvolta rivoluzionari, nell’edilizia, nell’agricoltura, nell’industria tessile, nell’arte bellica, nella farmacia, nella profumeria, nelle costruzioni navali e nei lavori idrici. Le scienze matematiche e geometriche, le indagini geografiche e le conoscenze alchemiche erano applicate a nuove tecniche poste al servizio della pubblica utilità. Gli «alchimisti di corte», come bene è stato sottolineato di recente, fungevano nello stesso tempo non solo da inventori e ingegneri, ma anche da consiglieri finanziari e diplomatici. L’alchimista si trovava quindi a ricoprire un ruolo fondamentale per il raggiungimento di quei nuovi traguardi che lo Stato si prefiggeva nel campo della politica, dell’economia, della finanza e della tecnologia.9 All’interno di questo cosmopolita popolo di scopritori, inventori, «secretisti», ingegneri, artisti, costruttori e progettisti, che promuovevano macchine, congegni, strumenti e ordigni ideati per migliorare i campi di produzione più disparati, non mancavano gli ebrei, e in numero non indifferente, benevolmente accolti, protetti, favoriti e integrati, senza che la loro inferiorità religiosa e giuridica lasciasse segni di sorta. L’utilità dello Stato imponeva un ordine di priorità diverso da quello che pretendevano di affermare le autorità ecclesiastiche. E talvolta anch’esse si adattavano volentieri a questa realtà, quando risvegliava il loro interesse o prometteva di portar loro vantaggio. A questi ingegneri ebrei, che svolgevano i lor...