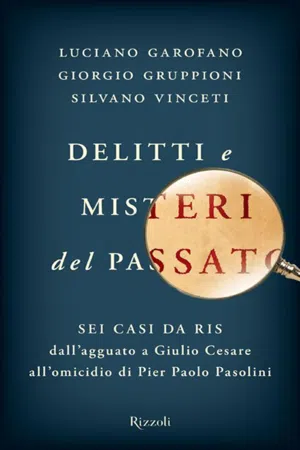![]()
Pico della Mirandola
e l’ombra del servitore
Giovanni Pico, conte di Mirandola e principe di Concordia, uno dei massimi esponenti dell’umanesimo italiano ed europeo, si spense il 17 novembre 1494, proprio nel giorno in cui il re di Francia Carlo VIII entrava con le sue truppe a Firenze. Morì qualche mese dopo il suo grande amico Poliziano, con cui condivise idee e speranze per il futuro, e due anni dopo la dipartita del grande mecenate fiorentino Lorenzo il Magnifico. Ascoltò per l’ultima volta suoni e rumori della Firenze di fine Quattrocento dal letto di un frugale appartamento, non lontano dall’ospedale di Santa Maria Maggiore. I suoi ultimi battiti di palpebre vennero rivolti al priore della chiesa di San Marco Girolamo Savonarola, a un medico e, forse, alla donna tanto amata, moglie di uno stretto parente di Lorenzo: quella Margherita che Pico tentò di rapire ad Arezzo e che, negli istanti conclusivi della sua vita, forse aveva unito il proprio respiro con il suo.
Pico era uno studioso di grande genialità, che, spinto da un’inesauribile sete di conoscenza, spaziò fra le più disparate culture che in quella Firenze trovavano cittadinanza e accoglienza: la filosofia occidentale, quella orientale, araba ed ebraica, misterica e non.
Molto probabilmente il grande umanista emiliano morì per avvelenamento. Tuttavia alcuni storici contemporanei affermano che egli, insieme all’amico Poliziano, fu vittima della sifilide, che in quel 1494 si stava diffondendo in Europa mietendo parecchie vite. La tesi è sostenuta con l’ausilio di documentazioni e testimonianze riportate nelle cronache.
La ricostruzione, anche se condotta con rigore scientifico e precisione chirurgica, deve pertanto procedere inevitabilmente per supposizioni, mettere in conto che vi è, nell’accertamento della verità dei fatti, un rapporto inversamente proporzionale fra il valore di questa verità e la lontananza temporale degli eventi. Lo storico, come un archeologo, deve ordinare le informazioni di cui dispone, cercarne di nuove, interpretare testi oscuri, mostrarsi avveduto nel trarre rapide conclusioni ed esercitare la facoltà del dubbio.
Alla domanda se Pico sia morto avvelenato, per sifilide o per altri accidenti, occorre quindi rispondere dopo essersi rituffati nella Firenze di fine Quattrocento. Entrando nelle sue biblioteche, ma anche nella psicologia dei suoi abitanti.
Il signore di Mirandola aveva una personalità forte ed esplosiva, data da un buon equilibrio fra passione e ragione. La sua nobiltà di sangue non lo ubriacò di quella arroganza, presunzione e consapevolezza di superiorità sociale, tipica delle famiglie feudali. Fin dalla fanciullezza, il suo destino aristocratico si trasfigurò in nobiltà d’animo e di gesti e in amore per la conoscenza.
Se quindi egli venne ucciso, chi poterono mai essere i mandanti e quali le ragioni di tale efferato delitto? E se invece morì di sifilide, o di un’altra malattia o a causa di un incidente, di quali prove possiamo avvalerci per sostenere tale tesi?
Quando i motivi di una morte possono essere diversi, occorre procedere senza escludere alcuna ipotesi, specialmente se si ha a che fare con uomini di grande intelletto, di forti e ferree convinzioni filosofiche e religiose.
* * *
Pico nasce nel 1463 nel castello della Mirandola, da Gian Francesco e da Giulia Boiardo (zia del poeta). All’età di quattordici anni lascia Mirandola per studiare diritto canonico, eloquenza e filosofia, e i suoi studi lo porteranno a Bologna, Ferrara, Padova e Pavia. Giunto a Firenze, nel 1484 stringe rapporti con Lorenzo il Magnifico, Marsilio Ficino e Angelo Poliziano, entrando a far parte dell’Accademia dei platonici. Diventerà ben presto il massimo esponente dell’umanesimo filosofico italiano, grazie alla sua vasta cultura e a una memoria prodigiosa. Filosofo eclettico, si dedica anche allo studio della cultura orientale, e in particolare alla Kabbala, in cui a suo parere sono racchiusi i misteri della religione cristiana e le dottrine della filosofia antica.
Dopo la primavera del 1486, e in seguito al suo fallito tentativo di rapire ad Arezzo Margherita, moglie di Giuliano de’ Medici (che non gli costerà la vita solo grazie a un provvidenziale intervento di Lorenzo il Magnifico), Pico si consacra con maggior impegno alla pratica filosofica e alla vita contemplativa. Si ritira a Perugia e, a seguito del sopraggiungere della peste, a Fratta. In questa amena località, immerso in una feconda solitudine, si dedica alla preparazione di una «disputa sulla pace filosofica», da tenersi a sue spese nella Roma papalina, all’inizio dell’anno successivo. Si tratta di novecento tesi (Proposizioni dialettiche, morali, fisiche, matematiche, teologiche, magiche, cabalistiche, sia proprie che dei sapienti caldei, arabi, ebrei, greci, egizi, e latini) su tutte le questioni di filosofia e teologia, che nascono appena dopo la sua opera più famosa, l’Oratio de hominis dignitate.
Nel gennaio dell’anno seguente la pubblica discussione delle tesi viene sospesa per decreto papale: Innocenzo VIII nomina infatti una commissione per valutarne la legittimità. Nonostante i tentativi di chiarimento da parte del filosofo, che scriverà anche un’Apologia, tredici tesi verranno condannate, costringendo Pico a fuggire a Parigi per evitare l’incarcerazione. Ma nel gennaio del 1488, su richiesta del papa, viene arrestato presso Lione da Filippo di Savoia e imprigionato nella rocca di Vincennes. Sarà liberato ed espulso dalla Francia nel marzo successivo per intercessione di Lorenzo il Magnifico, che lo ospiterà in una sua villa a Fiesole, consentendogli di mantenere stretti contatti con gli amici di Firenze. Solo nel 1493 papa Alessandro VI emanerà una lettera di perdono, scagionando completamente le sue tesi.
Intanto, anche Marsilio Ficino vive una vicenda analoga: nel 1489 sarà costretto a scrivere un’Apologia in risposta alle accuse di negromanzia avanzate da papa Innocenzo VIII, dalle quali si salverà a stento.
Nel 1490 iniziano a Firenze le prediche apocalittiche di Girolamo Savonarola, che vede Pico tra i suoi più accesi sostenitori: i documenti storici suggeriscono che il filosofo si era mosso in prima persona affinché Lorenzo invitasse a Firenze il frate, i cui sanguigni e persuasivi appelli profetici di profondo rinnovamento religioso, morale e dei costumi incontrarono da principio il favore di tutta la famiglia platonica.
Ma ben presto – siamo nel 1492 – Lorenzo il Magnifico muore, dando inizio a un grave momento di crisi che, di fatto, rappresenta l’inizio del declino della cerchia platonica di cui facevano parte anche Pico e Poliziano, che moriranno – come sappiamo – due anni dopo.
Da questo sintetico quadro cronologico emergono alcuni interessanti indizi che, come frammenti di un mosaico, ci permettono di iniziare a orientarci in questo intricato groviglio di avvenimenti. Si può affermare che l’eventuale morte violenta di Pico potrebbe essere collegata a forti e appassionate discussioni filosofiche e teologiche, ad accese e infuocate polemiche sul destino dell’uomo nel mondo, sul ruolo della libertà, sul modo d’intendere le scienze occulte, la magia e la loro influenza sulle persone e i loro problemi. Bisogna ricordare che alla fine del Quattrocento, in Toscana ma in generale in tutta Italia, gli ideali, i valori morali, sociali e politici, la ricerca e la difesa della verità, la coerenza con le proprie credenze, il coraggio di lottare, rischiare, pagare il prezzo per la difesa delle proprie idee erano virtù fortemente radicate nella mente e nel cuore delle persone. Possiamo constatare che Ficino, Poliziano, Pico e altri non si scontravano per bramosia di denaro, per smodate ambizioni di potere e visibilità o per bassi istinti di affermazione. Sicuramente erano mossi da invidie e gelosie, conoscevano il risentimento e la mortificazione, miravano alle attenzioni del magnifico principe Lorenzo, tuttavia tali sentimenti non divennero mai i moventi dominanti ed esclusivi delle loro azioni. Se qualche dubbio si può legittimamente nutrire per Ficino, alla luce dei fatti di cui disponiamo non è lecito avventurarci in supposizioni tanto ardite.
Fra le congetture sulle cause della morte di Pico, l’incidente o una malattia diversa dalla sifilide sono le meno probabili stando ai documenti storici di cui disponiamo. Sia la biografia di Pico scritta con amore, rispetto, ammirazione e tenerezza dal nipote Gianfrancesco (morto avvelenato), sia le diverse cronache compilate nel periodo della sua permanenza a Firenze non lasciano supporre che egli possa aver avuto incidenti o contratto la peste o la tubercolosi.
Morì allora di sifilide l’ideatore dell’opera filosofica De Ente et Uno? Le cronache di quel periodo in effetti riportano una vasta epidemia di sifilide che si abbatté su tutta l’Europa con migliaia di morti.
Negli ultimi anni, alcuni storici molto attenti al tema dell’omosessualità nel passato, e in particolare nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, hanno trovato nella sifilide una convincente spiegazione a molte morti rimaste senza una causa certa, tra cui anche quella di Poliziano. Le ragioni su cui fondano le loro asserzioni sono essenzialmente due: la prima, abbastanza ovvia, concerne l’omosessualità di molti artisti e letterati come Botticelli, Michelangelo, Raffaello e Leonardo. L’altra motivazione è di natura filosofico-religiosa e coinvolge direttamente il circolo neoplatonico di cui il mirandolese era un insigne esponente.
Conformemente ai capisaldi del pensiero platonico, Pico accettava l’ideale dell’«amor socratico» fra uomini reso popolare da Marsilio Ficino. Non si può dimenticare che l’incontro fra i due filosofi, avvenuto a Firenze, segna le vite di entrambi: Ficino è colpito dalla contagiosa curiosità di Pico per la riscoperta di Plotino, e Pico a sua volta è affascinato dalla scoperta del valore di Platone trasmessogli dal più anziano pensatore.
I documenti ci dicono che Pico visse questo tipo «di celestiale amore» con Girolamo Benivieni (1453-1542), poeta, rappresentante dell’Accademia ficiniana e fervente cristiano che ricambiò i suoi sentimenti, mossi – è bene rimarcarlo – da ben precise ragioni filosofico-religiose.
Il filosofo mirandolese possedeva una personalità determinata e coriacea, la sua esplosiva sensibilità era strettamente unita a un sacro rispetto per la fedeltà alle sue idee. Il suo matrimonio culturale con l’indirizzo neoplatonico, imbevuto di pregnanti tratti mistici e di un’elevata dimensione ascetica, era in piena simbiosi con la sua vocazione a un impegno esistenziale che traducesse il suo pensiero in azione. Tale premessa è indispensabile per una serena e distaccata interpretazione del rapporto fra Pico e Benivieni, in modo particolare per comprendere alcune lettere che si scambiarono e per interpretare le ultime volontà del Benivieni di essere sepolto insieme alla persona tanto amata. In loro la parola «amore» acquistava un senso diverso da quello attuale, dipendente dal contesto filosofico-religioso dominante in quel periodo. Se dovessimo utilizzare un linguaggio proprio delle indagini poliziesche, dovremmo dire che i fatti di cui disponiamo vanno letti alla luce di tale sfondo, per evitare, così, facili e gratuite mistificazioni.
* * *
Quando si procedette all’apertura delle tombe di Pico e Poliziano, nel luglio del 2007, il fatto che all’interno della prima furono rinvenuti anche i resti semi-mummificati di Benivieni, suscitò forte emozione tra i presenti. Chi sapeva del forte legame d’amore spirituale fra i due fu commosso nell’accertare la loro vicinanza post mortem.
La vetusta lapide sulla loro tomba, tuttora visibile nel chiostro della chiesa di San Marco a Firenze, scritta in latino, dice:
Qui giace Giovanni Mirandola, il resto lo sanno il Tago,
il Gange e forse perfino gli Antipodi.
Morì nel 1494, visse 32 anni.
Girolamo Benivieni, affinché dopo la morte la separazione di luoghi non disgiunga le ossa di coloro i cui animi in vita congiunse Amore, dispose d’essere sepolto nella terra qui sotto.
Morì nel 1542, visse 89 anni e 6 mesi.
Il sospetto di omosessualità ventilato da alcuni storici si alimenta di alcune cronache del tempo e del contenuto della predica che il Savonarola fece in occasione della morte del filosofo. Il frate domenicano accennò al fatto che l’anima di Pico non era potuta andare subito in Paradiso, ma era assoggettata per un certo periodo alle fiamme del Purgatorio per alcuni peccati che non nominò. Si tratta di espressioni generiche e ambigue. Non stupisce quindi che alcuni fiorentini del tempo avessero potuto pensare all’omosessualità. Sicuramente si sapeva delle vicende giudiziarie di Poliziano per rapporti con giovani adolescenti, si mormorava delle tendenze omosessuali di Ficino e si era a conoscenza delle concezioni socratico-platoniche sull’amore per gli adolescenti come mezzo per raggiungere l’amore di Dio.
Ma in tutte queste congetture forse si dimentica il rapimento di Margherita de’ Medici tentato dal giovane e passionale Pico. Margherita era una bellissima donna e, per averla, il nostro pagò un prezzo altissimo in vite umane. L’evento lasciò una traccia indelebile su di lui. Fu per lei l’unico sconsiderato abbandono all’istinto e alla passione amorosa. Possiamo quindi concludere, pur con prudenza, che la morte per sifilide di Pico, da un punto di vista storico, è da escludere. Le analisi scientifiche potranno smentire o confermare le nostre ipotesi.
Proseguendo la nostra indagine, è ora necessario imboccare un’altra strada, più sinistra e verosimile: quella dell’eliminazione di Pico come risultato di un freddo e cinico piano omicida.
* * *
Ci troviamo di fronte a quattro possibili spiegazioni che esporremo con l’ausilio del criterio della probabilità, partendo da quella più remota. Pico fu ucciso dai cabalisti o su ordine del cardinale Remolines, capo del Sant’Uffizio, e di papa Alessandro VI? Venne eliminato su richiesta della potente corporazione degli astrologi, di cui faceva parte Ficino, o di un mandante regale, Piero, figlio di Lorenzo il Magnifico?
Il percorso culturale che portò Giovanni Pico a conoscere, approfondire e usare la Kabbala fu in parte casuale: l’incontro, a Padova, con il cretese Elia del Medigo che lo iniziò alla conoscenza dell’ebraico e che per lui tradusse i commenti di Aristotele e Averroè. Pico soggiornò in questa città dall’autunno del 1480 alla primavera del 1482. Lo studio e l’approfondimento dell’ebraico, del caldeo e dei testi cabalistici avvenne a Firenze, dopo il soggiorno a Parigi dal luglio 1485 al marzo 1486, dove partecipò e assisté alle dispute della Sorbona e approfondì i propri studi teologici.
La parola Kabbala – letteralmente «tradizione» – ricorre raramente nel nostro linguaggio comune. Il suo significato è avvolto da un alone di mistero. Nel caso specifico, il termine, spesso usato in espressioni associate a riti esoterici, evoca immagini oscillanti fra magia e scienze occulte. Nel periodo storico in cui visse il mirandolese vigeva una moda filosofica e culturale di stampo eclettico. Quel giovane, mosso da ardente curiosità, s’applicò a studiare le discipline che trovava negli ambienti universitari e intellettuali delle numerose città in cui risiedette. A differenza degli altri filosofi, dedicò molte energie alla Kabbala e alla tradizione del Corpus Hermeticus e per un certo periodo della sua formazione filosofica, Pico rimase molto vicino ai cultori di questa tradizione esoterica, tanto più che la Firenze dei Medici aveva una forte presenza di ebrei e di cultori della Kabbala.
In tutta la sua vita di studioso e pensatore, egli tentò di conciliare la sapienza antica (greco-platonica, ebraico-cabalistica, ermetica) con la rivelazione cristiana, utilizzando la Kabbala come un fondamentale strumento critico-interpretativo delle Sacre Scritture, una sorta di antica sapienza per comprendere l’autentico significato della parola rivelata dei Vangeli. A differenza dei cabalisti ebrei, Pico ritenne la Kabbala fondamentale per penetrare le verità cristiane, quindi per rafforzare ulteriormente la figura di Cristo come figlio di Dio o Dio medesimo fatto uomo.
L’originale applicazione di questa disciplina per opera di Pico non solo dovette scatenare diverse proteste da parte della cerchia ebraica più ortodossa e tradizionalista, ma potrebbe essere stata intesa come un tradimento da parte di chi voleva riservarne lo studio a pochi. Si deve poi aggiungere la storica e costante acredine che intercorreva fra i cristiani e gli ebrei, che non conobbe certo sollievo con i papati di Sisto IV, Innocenzo VIII e Alessandro VI.
Alcune testimonianze dell’epoca ci raccontano dunque di un astio montante nei riguardi del nobile umanista. Ligi e fedeli ai nostri canoni investigativi, dobbiamo tuttavia constatare che, al di là di risentimenti pur comprensibili e legittimi, il ristretto nucleo degli ortodossi difensori della Kabbala difficilmente poteva maturare l’intento di ammazzare Pico. Anzitutto essi rispettavano fedelmente i comandamenti del loro Dio e poi il filosofo mostrò sempre un atteggiamento comprensivo nei riguardi dei rabbini, mosso dal suo ideale di pace e conciliazione fra le diverse religioni monoteiste.
Scartata questa ipotesi, riprendiamo il nostro cammino verso Roma, esaminando le figure di papa Alessandro VI e soprattutto del potente cardinale spagnolo Remolines. Questi fu un prelato estremamente influente in un periodo buio e oscuro del papato, un integerrimo difensore dei dogmi cristiani, a capo dell’importante e molto temuta congregazione del Sant’Uffizio, meglio conosciuta come «la Santa Inquisizione». Chi era posto a capo del Sant’Uffizio doveva avere la piena fiducia del papa, disporre di un esteso consenso fra cardinali e vescovi, primeggiare nelle sottili dispute teologiche e dare prova di integerrima moralità e di essere un fedele difensore della casta clericale. Il dotto Remolines possedeva tutti questi requisiti, oltre a essere un prezioso consigliere dei due papi che s’intrecciarono con le disavventure di Pico: Innocenzo VIII e Alessandro VI. Ricordiamo che fu proprio papa Innocenzo VIII a incaricare di esaminare le tesi preparate da Pico, il quale era mosso unicamente dall’intento di aprire una feconda discussione interreligiosa.
Remolines ebbe un ruolo fondamentale nell’istituzione di una commissione appositamente nominata dal Pontefice che condannava sette fra le novecento tesi pichiane come eretiche od offensive e ne giudicava altre sei come infondate. Come sappiamo, a nulla valse la difesa delle tesi da parte di Pico e anche la sua condanna e l’internamento nella rocca di Vincennes furono molto probabilmente orchestrati dal prelato spagnolo.
Mentre a Firenze la voce del Savonarola cominciò a tuonare contro la degradata e corrotta Roma papale e i suoi apocalittici sermoni infiammavano i fedeli di ogni condizione sociale, l’ineffabile cardinale si muoveva per scomunicare il domenicano e assicurarlo alle grinfie della Santa Inquisizione. Remolines tentò varie volte con il successore di Innocenzo VIII, Alessandro VI, di assicurare alla pace eterna il ribelle e pericoloso frate domenicano della chiesa di San Marco, ma trovò sulla sua strada un insigne rappresentante della casta degli astrologi, il quale aveva profetizzato al Borgia che il giorno in cui fosse stato messo al rogo Savonarola, anche lo stesso papa sarebbe morto.
L’inizio del pontificato di Alessandro VI, l’8 giugno 1493, vide un periodo di grande ascesa per l’autorevolezza del Savonarola, legata all’accentuarsi, nelle sue infuocate prediche, dell’attacco morale alla Chiesa romana. E proprio nello stesso periodo Pico consolidò e rafforzò i suoi rapporti con il frate, condividendone l’ansia di profondo e radicale rinnovamento del papato. Non bisogna in questo quadro dimenticare che, essendo morto l’anno precedente Lorenzo il Magnifico, Pico, senza il suo protettore, si trovava politicamente indebolito e non certo sostenuto da Piero de’ Medici. Vi era inoltre un altro particolare molto importante: il segretario di Pico, l’oscuro Cristoforo da Casalmaggiore, indicato come il probabile killer del suo signore, dopo la sua morte si recò a Roma al servizio del cardinale Remolines svolgendo funzioni ben poco religiose. Voci indiscrete sostenevano che il solerte segretario venisse impiegato in attività alquanto violente; si trattava soltanto di deboli voci, è vero, ma non vanno trascurate quando si tratta di mettere insieme le eventuali ragioni che possono avere spinto il cardinale romano a ordinare l’eliminazione di Pico.
Remolines aveva poi un altro motivo per non dolersi della fine prematura di Pico. Inizialmente aveva compreso che se avesse condannato in toto le novecento tesi ...