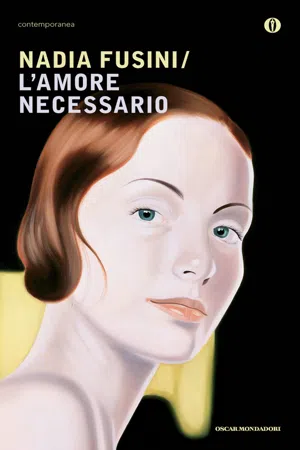![]()
La casa
Ritornammo un poco stanchi, straniti, alla casa che ci aspettava. David aveva acceso il fuoco, Petrus in cucina preparava una zuppa. Cenammo, giocammo a carte, ridemmo. Fu una serata calma, pacata, appena appena alterata da quel contatto sotto la quercia, uno scontro vitale, ma doloroso. Parlammo di quadri, che da ogni parte, come presenze inquiete e incompiute, ci sorvegliavano.
David viveva circondato dalle sue tele, molte delle quali non finite, che mai avrebbe compiuto, perché c’era nella sua esistenza un’insicurezza riguardo al proprio valore, una crepa che lo affacciava su spaventosi abissi di delusione anticipata.
Quella sera, mentre giocavamo a carte, mentre parlavamo, osservai più volte i quadri di David, alcuni attaccati alle pareti, altri ammassati a terra contro le pareti screpolate della casa.
Li sbirciavo, li spiavo, fingevo di pensare ad altro, mentre invece pensavo a loro. Li volevo sorprendere senza farmene accorgere, di soppiatto. Mi ci volle un po’ di tempo, poi li vidi: prima uno a uno, e dopo tutti insieme. Per la prima volta (avevo visto altre opere di David nel passato) mi apparvero come delle creature ansiose, turbate, chiassose. I colori soprattutto mi colpirono, così crudi e violenti. Vidi ciò che stava alla superficie e ciò che stava dietro alla pittura, la vera essenza, lo spirito che aveva fatto nascere quelle opere. Ebbi la percezione dell’indescrivibile potenza del destino. La vita muta che urlava in quelle tele mi si scagliava contro, mi investiva. Era come se avessero braccia e mi afferrassero, quasi volessero piegarmi a sé, quasi volessero trattenermi nella loro inspiegabile voracità di forme e di figure, in realtà vuote di senso evidente. Sì, potevo riconoscere in alcune l’incerta apparizione di un tronco, o la chioma di un albero, o forse addirittura un volto; ma prima che cose concrete quei segni e colori imitavano, o riproducevano, l’anima del loro autore.
David intanto parlava e la sua voce da tenore, calda, corposa, venata di inflessioni aspre e gutturali, mi cullava in un dormiveglia fantastico. Tra i quadri e la voce ero come sdoppiata: padrona della mia mente e dei miei sensi, ma anche vittima della visione che stavo avendo e che mi travolgeva, mi spossessava di me stessa, come se mi avesse invaso un essere più forte, feroce.
page_no="17"
I colori hanno in genere uno straordinario potere su di me, ma quella volta in particolare l’effetto fu sinistro. Un effetto inspiegabile, a meno di non usare un nome che in fondo preferirei non usare in questo caso, ma è forse l’unico in grado di spiegare ciò che successe – Amore. Sì, la verità è che io provai Amore per quelle forme che non erano affatto belle, non erano vere e proprie forme concluse, ma rimanevano spalancate; e proprio da ciò derivava l’effetto di attrazione e di angoscia che provavo. Perché io in genere amo il bello, ciò che è risolto, concluso, compiuto nell’armonia del volto, che niente e nessuno potrà cambiare, ciò che dunque è perfetto. Qui invece le figure presentavano il nulla spalancato; e cioè, lo strappo, la crepa, la voragine aperta e pulsante di vita, da cui sorgevano, incerte perfino della loro stessa esistenza, sicuramente perplesse riguardo alla loro legittimità; incapaci di nascondere il dubbio estremo che le possedeva e le svuotava di senso e d’identità – il dubbio di essere nate davvero, di essere vive. Perché ci sono opere che nascono morte.
Le amavo, quelle creature, e insieme rabbrividivo al solo pensiero di quanto mi stava accadendo, perché il trasporto che provavo significava qualcosa per me difficile da accettare; e cioè, che non potevo reggere altra bellezza. Che amavo creature forse mai nate. O nate a metà. Aborti. Non potevo stare di fronte a forme troppo luminose: quando m’era accaduto, ero rimasta abbacinata. Il bello m’aveva abbagliata, e m’ero ritrovata cieca, stordita, e una specie di sonno interno, invadendomi, aveva chiuso a me stessa la via della conoscenza.
David continuava a parlare e, come in trance, io lo ascoltavo. Solo che alle parole si mescolavano memorie acustiche di altri mondi, quello americano, la sua California amata, dove lo avevo incontrato anni prima, quando era un giovane artista della West Coast e viveva tra hippy e vari generi di artisti e sognatori e poeti. Poi, un giorno, aveva preso le sue tele, le aveva portate in strada e regalate a chi le voleva, e le altre le aveva abbandonate. Povero come solo a trent’anni si può essere, se si è artisti, era partito per l’Europa. Prima per Amsterdam, e poi da lì, con Petrus, per l’Italia.
In Italia aveva ripreso a dipingere – non sapeva fare altro, ognuno ha il suo gesto. E proprio quel gesto lo aveva portato in questa cascina, isolato da tutti, con pochi, pochissimi amici, che non troppo spesso si ricordavano di lui; mentre Petrus, che mai lo dimenticava, lavorava per tutti e due, e portava a casa quel poco di cui entrambi vivevano.
Conoscevo la sua vita, ma tu no e ascoltavi in silenzio una storia che chissà fino a quando avrebbe trattenuto la tua attenzione. Conoscevo anche le tue impazienze e temevo. Invece, quella sera, tu ascoltavi paziente come Giobbe le sventure di un altro. Evidentemente, quella vicenda ti interessava più di altri, costruttivi, destini. Ma tra me e me io pensavo: che ne puoi sapere tu, così giovane, di cosa significa oltrepassare la linea d’ombra, dove ciò che desideriamo diventa sbiadito, sfuggente, tanto che non lo ricordiamo neppure più? Perché, che altro significa avanzare negli anni, se non dimenticare ciò da cui un tempo ci siamo sentiti chiamati?
Io invece capivo David, e come lui mi sentivo in pericolo: non di perdermi, ma di essermi già perduta, tanto da non sapere neppure più quale fosse la mia strada, se mai avevo pensato di averne una tracciata per me.
Eppure, quello avevo sempre voluto – un destino. Avevo sempre sognato di scoprire da sola, come in una specie di caccia al tesoro, la mia strada, ma che un altro la volesse per me, questo desideravo più di ogni altra cosa. Non vogliamo forse che un altro ci crei? Vogliamo forse nascere dal caso? Dal nulla? Da un buco nero? No, è infinitamente più dolce immaginare un padre, possibilmente eterno. Questo è avere un destino.
Come David, anch’io avevo desiderato per me un certo tipo di vita, e poi una decisione presa d’impulso, senza riflettere, mi aveva strappata da dov’ero, e il sogno s’era dissolto, e pian piano aveva preso corpo un’altra finzione, diversa. Con atti separati l’uno dall’altro, nessuno davvero deciso, s’era delineato un nuovo percorso. Per questo amavo David, lui non aveva tradito.
«È così anche quando dipingo» diceva, «non so esattamente cosa accadrà sulla tela, attendo che qualcosa si manifesti. Qualcosa di cui, all’inizio, non ho una visione precisa. Se la figura non appare, distruggo quel che dipingo. Se non proprio il senso, vorrei che apparisse almeno la direzione, seguendo la quale le cose della vita potrebbero comporsi in un disegno, e se non mi succede, tutto si fa vago, incomprensibile e io oscillo. Se mi sono fermato in questa campagna, in fondo, è perché ho pensato che un posto valesse l’altro, e il problema fosse stare, consistere. Per me, del resto, non c’era la possibilità del ritorno; dove sono nato, non è la mia patria. Anche per tanti altri è così. In America ci sono arrivato da altrove, i miei erano nati in un paese che non esiste più sulla carta geografica. O se esiste, ha cambiato nome.»
Chi ha avuto una casa, ha forse più ragioni di volerci tornare? Io non lo desideravo.
«L’origine non è un bene di cui interessarsi troppo, è pur sempre un caso che io sia nata dove sono nata» proclamai. Del resto, se mai avevo sentito quel vincolo, era stato soltanto per volerlo spezzare.
La notte, intanto, avanzava. La fiamma del camino spandeva una luce ambrata sul volto di David. Non lo avevo mai visto così bello, le ossa del viso ben disegnate, la bocca grande, e le mani enormi, ossute, agili – mani che dev’essere ancora bello sentirsi addosso, la cui carezza deve essere ancora forte e morbida. Non perché lo desiderassi, pensai, ma perché David era un uomo che poteva dare a una donna la sensazione di crearla, toccandola. Quelle mani bastavano a convincermi che fosse un artista. Le avevo avute, le sue carezze, e ne conoscevo la lusinga. Tra i corpi che occhieggiavano dalle pareti, c’era anche il mio. Erano stati i giorni dell’amore carnale e non solo, e alla fine si era dipinto sui nudi, che ora ci osservavano da sopra al camino.
Petrus quieto ascoltava. Si dondolava piano sulla sedia a dondolo di castagno che lampeggiava di riflessi rossastri, per via della fiamma. Cullava così il suo amore per David, sicuro, costante, che aveva trionfato sul nostro furtivo, effimero contatto.
Petrus sapeva di noi, ma non era turbato. Per David avevo rappresentato un’occasionale sortita nel mondo femminile. Non durò, ma fu per entrambi una prova dura, a dimostrazione della passione feroce, dell’attaccamento ostinato, e tutto negativo, che ci travolse. Non poteva funzionare e non funzionò; il mio corpo lo deludeva. E io mi sentivo insieme desiderata e respinta, una sensazione amara, al fondo. Umiliante.
page_no="22"
Ma era stato amore. Se è amore l’intensità visionaria di un intreccio di anime che si toccano parlando, parlando...
Ci scrivevamo lettere appassionate, in lontananza. Da vicino, ricadevamo nella miseria di una passione fredda, astratta. Scherzando, gli dicevo: «Il nostro è un amore mistico». «Sì, ha quel sapore» rispondeva. «Ha il sapore della follia. Ma un amore senza follia, che amore è?»
Lo trovò con Petrus l’amore senza follia, che gli permetteva di vivere. Anche quello era un sentimento a suo modo spirituale, che contemplava il sacrificio totale dell’amante. David imparò ad amarsi come oggetto della dedizione di Petrus; amava sé, grazie a lui. Nel sentimento che li univa, una mescolanza di sensualità e castità sbocciava in forme di tenerezza, in gesti che mi commuovevano profondamente. Non so perché, ma ho sempre trovato struggente la tenerezza omosessuale.
Ecco, loro sono la prova che esiste l’amore eterno, mi dissi. E sapevo, dicendo così, che d’ora in avanti non avrei voluto niente di meno, se non l’amore per sempre. Non l’avventura, né l’ebbrezza di un istante. E ti guardai. Per caso, ti trovavi lì; ma eri lì, in quel momento. E quel pensiero bastò a fissarti nel mio cielo, da dove, come una stella fissa, non potrai tramontare, se non con la mia stessa fine.
page_no="23"
Non è giusto, forse. Tu non l’avevi scelto. Eri lì per caso. Ma la vita è così, si passa in un certo luogo, un certo giorno, e per il resto del tempo si rimane prigionieri di quella particolare congiunzione astrale, o tutta umana, in cui ci si è trovati presi. Fu così anche per me, del resto. Per caso eri entrato nella mia orbita, e io ti assorbivo, dovevo farlo, non lo sceglievo, accadeva. Tutti gli altri vincoli avrebbero ceduto prima o poi, si sarebbero col tempo dissolti, e ci saresti stato soltanto tu. Ti amavo, cominciavo ad amarti, perché eri lì. Perché stavi diventando il mio destino.
Come in quel gioco che si giocava da bambini, a mosca cieca si chiamava; quando a tentoni, bendati, si toccava qualcuno e dovevamo scoprire chi fosse... Io toccai te, e tu eri Amore.
page_no="24"
![]()
La nebbia
La mattina dopo il cielo era ancora grigio, trasudava non più pioggia, ma vapore, nebbia. Nebbia spessa come una coltre.
«In autunno è così, da queste parti» commentò David.
Io e te eravamo allegri, non sapevamo perché, forse perché la notte ci aveva nutrito di sogni buoni, anche se non ricordavo i miei, e tu non facesti parola dei tuoi. Ma era chiaro che avevamo riposato bene nelle braccia della cascina vecchia di secoli, adagiata all’orlo del bosco, tra le visioni incompiute delle tele di David e le cure quiete, discrete di Petrus; il quale, forte e silenzioso, aveva preparato sul tavolo enorme della cucina una colazione generosa, capace di rincuorare una pattuglia di soldati ben più affamati di noi.
Abbracciai più volte David, come se potessi non rivederlo più. Non perché sentissi che sarebbe stato così. Né lo temevo. Volevo piuttosto sentirlo ancora vicino, come l’avevo sentito la sera prima – quasi una parte di me. Come se parlasse al posto mio, come se vivesse per me, come se avesse creato per me le sue creature, che respiravano della sua anima e parlavano alla mia. Mai l’avevo sentito tanto vicino, neanche nei nostri amplessi più esuberanti. Il contatto dei corpi davvero avvicina?, mi chiesi. O è un’illusione? E, al contrario, soltanto quando non c’è più quella bramosia, si arriva a un’altra carezza, più profonda, più intima?
Quella mattina gli ero grata, come è giusto essere grati con chi ci dimostra l’esistenza della lealtà e del coraggio, doti che David aveva profuso a piene mani nelle sue tele, per tutti noi. Lo baciai con calore, come fosse il testimone di un’esperienza preziosa, e lui riconobbe la gratitudine.
Non so se ricordi il viaggio di ritorno. Scendevamo piano nella nebbia, tu guidavi, io ti sedevo accanto. Non parlavi, concentrato nell’attraversamento muto di un paesaggio intermittente, che emergeva a tratti e subito spariva. Più che viaggiare, scivolavamo nello spazio, bucavamo una massa ovattata di grigio, ci sembrava di volare, piuttosto. Quel silenzio ci trasportava a un’intimità quasi sepolcrale, come fossimo nella stessa bara.
Sentivo battere il tuo cuore appena un poco accelerato, perché, ne sono certa, anche tu avevi paura di quel che ci capitava, di quella specie di morte-insieme che stavamo attraversando e si imponeva a noi come un possibile volto dell’amore. Da allora non ho più conosciuto cieli così grigi, così immoti. La macchina era come un pianeta che scivolasse lungo il corso stabilito, in ...