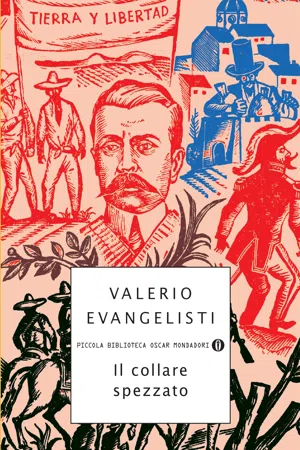Álvaro Obregón nutriva una forte nostalgia per la campagna, e in particolare per la tenuta La Quinta Chilla, nello Stato di Sonora, dove aveva lasciato la bella moglie María e i figli avuti dal precedente matrimonio. Da quasi un anno era presidente della Repubblica, e da allora aveva potuto visitare solo occasionalmente le sue piantagioni di ceci: i migliori al mondo, esportati ovunque. Suonava ridicolo a dirsi, ma i ceci gli mancavano quanto la sposa, che lui adorava, e i figli, che lo rispettavano.
Si lasciò aiutare dal cameriere a indossare l’uniforme bianca da cui non si separava mai. Da solo non ce l’avrebbe mai fatta.
«Lo sai, Pablo, che hanno ancora avvistato il mio braccio perduto?»
Abituato agli scherzi del padrone, il cameriere fece una smorfia divertita. «Ah, sì, signor presidente? E cosa faceva questa volta?»
«Cercava di rubare dalle tasche dei miei concittadini. Solo che, separato dal corpo, non sapeva dove mettere il denaro. Ha dovuto restituire il maltolto. Ecco perché i messicani hanno eletto un presidente senza un braccio. Sono sicuri che ruberà la metà dei predecessori.»
Pablo scoppiò a ridere. «Siete impagabile!»
«Ne sei sicuro? Forse non mi hai ancora offerto una somma adeguata!»
Soddisfatto per aver divertito il cameriere, Obregón uscì dal suo appartamento, diretto alla sala da pranzo per la colazione. Non riusciva ancora a considerare il Palazzo Nazionale come casa propria. Forse predecessori come Juárez, Díaz, Madero o Carranza avevano avuto meno problemi. Lui stentava a capirli. Comprendeva meglio che il tetro Huerta si fosse trovato a suo agio fra quei corridoi solenni, tappezzati di dipinti.
Quella mattina Obregón si sentiva allegro, però già presentiva che la sua leggerezza d’animo sarebbe svanita nell’incontrare il segretario di Governo, Plutarco Elías Calles, detto El Turco. Calles (chiamato col nome della madre, anche perché figlio illegittimo) aveva un carattere completamente diverso dal suo. Obregón aveva i suoi momenti di malinconia. Riusciva a mascherarli con raffiche di battute, e con una vivacità che, a forza di essere simulata, diventava reale.
Al contrario Calles, ex governatore di Sonora, creatore di un sistema scolastico modello, convinto socialista, non sorrideva mai, né lasciava trapelare traccia di ironia o di autoironia. In questo senso poteva ricordare Benito Juárez. Non era però un indio, e la sua tetraggine non discendeva da comportamenti atavici. Forse derivava da un’infanzia difficile, destinata a rimanere avvolta nel mistero. Certo, lui non ne avrebbe mai parlato.
Obregón trovò il collaboratore intento ad assaggiare, in punta di forchetta, huevos estrellados, crema di fagioli con peperoncino verde e chorizos: salsicce che, secondo l’uso messicano, venivano prima cotte ai ferri e poi sminuzzate nel piatto. Una colazione tra le più diffuse.
«Plutarco, è come se stessi mangiando la bandiera nazionale!» rise Obregón, mentre prendeva posto. «Credo che ordinerò la stessa roba. Per dovere patriottico.»
Calles posò la forchetta e fece per alzarsi. «Buongiorno, signor presidente! Mi sono permesso di ordinare perché…»
«Comodo, comodo!» replicò Obregón. «Sono io a essere in ritardo, Plutarco. Ma dov’è el pinche camarero? Ah, eccolo! Ragazzo, lo stesso piatto del mio amico! E magari un tamal fumante, se lo avete!»
Il giovane fece un cenno d’assenso, e sparì in cucina.
Obregón toccò la tazza che Calles aveva davanti. La fece tintinnare con l’unghia. «Che cos’è? Non alcol, spero.»
Scherzava. Era ben nota l’avversione dell’ex governatore di Sonora per le bevande alcoliche, e per il fumo. Anni prima, nello Stato che reggeva con severità dittatoriale, aveva fatto fucilare un anziano bevitore che, in una taverna, infastidiva i clienti. Un’imitazione involontaria della giustizia approssimativa esercitata da Eufemio Zapata. Solo che questi, ubriacone a sua volta, era stato giustiziato dal figlio della vittima. Pochi avrebbero osato tentare vendette su Plutarco Elías Calles, giacobino feroce e pedagogo, indifferente alla vita propria e altrui, impegnato a spingere a forza lo Stato che controllava nell’area della modernità.
Obregón detestava quanto Calles gli eccessi nel bere, e preferiva che non si fumasse in sua presenza. Peraltro il suo approccio era molto meno violento. Lo si notava nella questione religiosa. Da governatore di Sonora, Calles aveva espulso dallo Stato i preti cattolici, e di fatto impedito ogni forma di culto. Intendeva tornare a un’applicazione letterale della Ley de Reforma di Juárez.
Obregón, massone come Calles e simpatizzante per la Chiesa spiritista di Alain Kardek, era molto più pragmatico. Lui, che aveva preso in ostaggio tutti i religiosi di Città del Messico, e che li aveva fatti espatriare su carrozze blindate, minacciando di morte i preti che lamentavano l’affollamento eccessivo, stava scendendo a compromessi. Discuteva con l’arcivescovo della capitale. Inviava in Vaticano missioni pacificatrici. Pareva orientarsi sul concetto inviso ai liberali della libertà di culto, ferma restando l’autonomia dello Stato dalle religioni praticate sul suo territorio. Questo asseriva la Costituzione messicana del 1917, e Obregón vi si atteneva con scrupolo.
Calles guardò le ante dorate della porta d’accesso alla mensa, su cui sostava un maggiordomo. «So che avete invitato a questa colazione anche qualche ministro. Il loro ritardo è inconcepibile.»
«Ma no, Plutarco, tieni presente che abitano lontano.» Obregón rimirò incantato i piattini fumanti che il cameriere posava di fronte a lui. «Intanto possiamo mangiare con comodo. Sai chi stiamo aspettando?»
«No, signor presidente.»
«Finiscila di chiamarmi “signor presidente” e di darmi del voi. Sono amici comuni, Plutarco. José Vasconcelos e Antonio Villareal. Cultura e Agricoltura: fanno anche rima. Inoltre, ho convocato anche un deputato del partito agrarista, Antonio Díaz Soto y Gama. Già capisci che stamattina voglio trattare temi sociali.»
Calles, malgrado la sua leggendaria impassibilità, parve rasserenato. «Quello che conosco meno è Vasconcelos: l’ho incontrato solo quando era rettore dell’università di Città del Messico. In qualche misura lo stimo. Gli altri due erano magonistas di primo piano. Gente intelligente. Soto y Gama è però stato consigliere di Zapata fino alla sua morte.»
«Già. Trovo bellissimo che abbia finito per accettare il nuovo sistema, e si sia candidato. Abbiamo un bisogno disperato di personaggi di quel calibro, in questa terra di latifondisti e di preti venduti ai latifondisti.» Obregón brandì la forchetta. «Insomma, Plutarco, mi lasci mangiare o no? Non siamo ancora in riunione!»
Calles si richiuse nel consueto mutismo. Obregón ebbe appena il tempo di iniziare a masticare il tamal. La porta della sala si riaprì. Il maggiordomo si mise sulla soglia e annunciò: «Signor presidente, sono arrivati i ministri Vasconcelos e Villareal, e l’onorevole Soto y Gama».
Obregón lasciò la forchetta che reggeva con la sinistra. Con la stessa mano si pulì le labbra in un tovagliolo. «Falli entrare, perbacco!»
Sebbene un’etichetta dimenticata non lo prevedesse, si alzò in piedi, imitato da Calles. Mostrò il suo segretario di Governo. «Credo che conosciate il mio braccio destro!» disse, strizzando l’occhio.
Villareal rise. «Dunque lo avete trovato, il vostro braccio!»
«Sì, ma non lo credevo così rigido!»
Tutti scoppiarono in una risata, salvo Calles, che si limitò a increspare le labbra.
Obregón non tornò a sedersi. Portò alle labbra la tazza del caffè e la vuotò in un sorso. Quando la posò, spinse via i piatti con il cibo. «Non ho appetito, in fondo, e mia moglie non fa che ripetermi che dovrei dimagrire… Tu hai finito, Plutarco?»
«Sì» rispose Calles. «Anzi, ho mangiato più di voi… più di te.»
«Bene. Allora andiamo subito nel mio studio.»
Lungo il corridoio, Obregón si accostò a Soto y Gama. «Avete avuto risposta dai fratelli Flores Magón?»
«Sì. Ricardo mi ha scritto subito. Vi ringrazia molto. Dirò di più: si mostra toccato dalla vostra offerta di una pensione a carico del governo messicano. Non si attendeva, signor presidente, che accettaste la mia proposta. Tuttavia aggiunge che non è in grado di accettarla. Sarebbe incoerente con la sua ostilità verso Stato e istituzioni, che mantiene intatta. Chi ha avuto fiducia in lui non potrebbe perdonarglielo, né Ricardo potrebbe perdonarlo a se stesso.»
«Ricardo è sempre stato così, signor presidente» commentò Villareal, che, a un passo di distanza, aveva udito. «Sovrappone dall’estero schemi ideologici alla realtà, pensa di conoscere un Messico in cui non torna da un ventennio.»
«Come sta, adesso?» chiese Obregón.
«Molto male» rispose Soto y Gama. «Enrique resiste abbastanza bene all’ennesima prigionia, ma Ricardo no. La prigione di Leavenworth, nel Kansas, è meno dura delle precedenti, ma di poco. Ricardo soffre di diabete e di disturbi respiratori. Una cataratta non curata lo ha reso quasi cieco. Si fa leggere lettere e libri dal compagno di cella, Robert Little, degli IWW. Tossisce senza posa. La sua donna, María Brousse Talavera, vive nella miseria più squallida e cerca di stargli vicina.»
Obregón aggrottò le sopracciglia. «Cercherò di fare intervenire la nostra ambasciata a Washington.»
«Temo che non servirà a molto.» Soto y Gama allargò le braccia. «L’amministrazione americana sta liquidando gli Industrial Workers of the World, i socialisti, gli anarchici. Abbiamo visto come ha abbattuto con la forza, nel 1919, la cosiddetta Comune di Seattle. Prende di mira gli stranieri, li considera agenti della rivoluzione bolscevica. La mia impressione è che i fratelli Flores Magón siano adesso vittime di un meccanismo repressivo che prescinde dalle loro persone.»
Obregón alzò le spalle. «Be’, da un anno in qua sono presidente. Tenterò di usare la mia influenza. Wilson non mi è troppo ostile, da qualche mese. Sembra aver capito che, se vuole parlare con qualcuno, in Messico, deve farlo con me.»
L’ufficio presidenziale era al secondo piano, sorvegliato da soldati armati di fucile. All’arrivo del capo dello Stato i militari scattarono sull’attenti. Uno di essi, un sergente, spalancò la porta, ornata dallo stemma con l’aquila e il serpente. I finestroni davano sullo zócalo, e mostravano l’enorme bandiera tricolore dispiegata al centro. Ogni mattina era issata da contingenti dell’esercito, che portavano sul luogo il vessillo arrotolato sulle spalle, tanto era grande.
Obregón condusse gli ospiti alla sua scrivania massiccia, carica di dorature. Sedette su un divano sovrastato da un ritratto di Benito Juárez, e invitò gli ospiti ad accomodarsi sulle poltrone attorno.
«Vi ho convocato per chiedervi consiglio, e per informarvi su un accordo segreto, risalente al 1919, di cui non avete ancora avuto conoscenza… Suvvia, non fate quelle facce! Non parlo di un patto criminale! Alludo a qualcosa che non ostacolava la democrazia, anzi, la favoriva!»
I tre ospiti non replicarono. I loro sguardi furono severi. Quello di Calles perché lo era sempre. Quelli di Villareal e di Soto y Gama perché i due si aspettavano chissà quale sordida rivelazione, conforme ai meandri della politica messicana.
Obregón scoppiò a ridere. «Amici miei, non sto per parlarvi di vendite o di tradimenti. Semplicemente due anni fa, il 6 agosto 1919, io ho sottoscritto un patto con la CROM, la Centrale Regionale degli Operai Messicani. In pratica, la filiazione diretta della ex Casa del Obrero Mundial. Mi impegnavo a creare un ministero del Lavoro, a riconoscere i diritti sindacali, a varare leggi favorevoli ai lavoratori, a consultare settimanalmente le loro rappresentanze…»
Vasconcellos inarcò un sopracciglio. «Era necessario sottoscrivere un documento tanto impegnativo?»
«Sì, lo era, don José» rispose Obregón, senza esitare. «Quei tempi li sto dimenticando anch’io, ma è bene non cancellarli dalla memoria. Quando Carranza seppe che mi candidavo alla presidenza, contro il candidato che cercava di imporre, ricorse a ogni trucco per togliermi di scena. Mi screditò, mise in dubbio le mie vittorie militari, cercò di implicarmi in faccende criminali minori perché scattasse il desafuero, l’esclusione dai diritti civili. Ci fu di peggio, come Plutarco può testimoniare.»
Calles annuì. «L’ordine era di ucciderti. Naturalmente rifiutai di obbedire.»
«La mia risposta fu di non scostarmi dal terreno della legalità, e di rifiutare la guerra civile a cui mi si invitava» riprese Obregón. «I sindacati vennero in mio soccorso. Mi si impediva di tenere i miei comizi negli Stati del paese. I ferrovieri, malgrado gli ordini ricevuti, fecero viaggiare le locomotive per portarmi dove desideravo. Le cucitrici mi ricamarono bandiere. Gli...