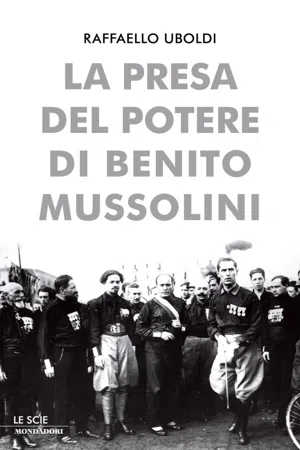![]()
Parte terza
SCUSATE MAESTÀ
(SE MI PRESENTO IN CAMICIA NERA)
![]()
22 OTTOBRE, DOMENICA
Si rappresenta a Roma, al Palatino, la Fedra di Gabriele d’Annunzio, con enorme concorso di spettatori, e tutte, o quasi, le personalità di spicco della politica – il primo ministro Facta, il ministro della Guerra, Soleri, Amendola e altri ancora –, degli affari e della cultura, un’occasione da non perdere, per farsi vedere, per rendere omaggio al Vate, e per le signore dell’alta società per sfoggiare le toilette più ricche, più vistose, più audaci, quelle come scriverà l’indomani un cronista mondano «che sono capaci di spronare gli uomini alla ricerca del frutto proibito». La buona società capitolina ci tiene a far bella mostra di sé prima del diluvio, del resto sono in pochi a credere, a rendersi conto che un sovvertimento è alle porte, che qualcosa di straordinario sta per accadere. Fatti, vicende, storie che potrebbero cambiare tutto uno stile di vita, seppure ciascuno nel suo intimo sa, o spera, che questa Roma corruttibile saprà corrompere, digerire, fare proprio ogni avvenimento, finanche quello più fuori del consueto, persino una marcia su Roma che, come da qualche parte si dice, porterà al potere sulle ceneri della vecchia democrazia liberale un uomo nuovo di nome Benito Mussolini. Nel caso basterà dirozzarlo un poco, e tutto riprenderà a scorrere su dei binari consueti, dove chi ha continuerà a viaggiare sui sedili di cuoio della prima classe, e chi non ha sulle panche di legno della terza.
Per dare a questa rappresentazione della Fedra tutto il lustro necessario il ministero della Guerra ha messo a disposizione ventun cavalli bianchi, scelti fra i purosangue dei reparti di cavalleria dell’esercito. Nemmeno casuale è la scelta di una giornata domenicale, per principio una giornata di festa, in questo caso di festa grande. Del resto è più che giusto che si faccia di tutto per compiacere il Vate. Non è questo il poeta, l’uomo, il personaggio, l’eroe, per qualcuno un semidio, che dovrebbe venire a Roma il 4 novembre a fare da scudo, con la sua presenza, e per quello che dirà, all’avventura mussoliniana? L’inno nazionale, l’inno del vecchio regno di Sardegna, quando i Savoia non erano ancora sovrani d’Italia, l’inno rimasto in vigore: «Viva il re / l’armi in parata / le bandiere al vento sciolte / sian le fronti / a lui rivolte / legga in esse fedeltà …», viene ascoltato in piedi, in religioso silenzio, prima dell’aprirsi del sipario. Infine il più caloroso degli applausi accoglie l’ingresso di d’Annunzio seguito da un «Per d’Annunzio, eia, eia, eia, alalà!» gridato a voce spiegata da un fedelissimo del Vate, a cui gli spettatori rispondono in coro con un altro «alalà!», dove le robuste voci maschili si mescolano a quelle femminili, più sottili. Chiunque ringrazierebbe commosso per l’omaggio che gli viene attribuito. D’Annunzio, personaggio per principio in controtendenza, nel parlarne con un giornalista dichiara: «Di Roma non vedo che la cloaca». A gelare del resto le speranze del governo c’è stata stamane la pubblicazione sul «Popolo d’Italia» del verbale dell’accordo fra Mussolini e d’Annunzio circa il futuro della Federazione dei Lavoratori del Mare. E ancora un comunicato consegnato ai giornali dal solito capitano Coselschi.
«Il comando di Fiume, essendo venuti meno i motivi che avevano determinato la mobilitazione, da questo momento i legionari (fiumani) devono considerarsi smobilitati.»
È poi vero che la speranza non muore mai. In tanti continuano ad augurarsi che il Vate non si rifiuti di rendere al paese il servizio di una sua presenza all’Altare della Patria nella fatidica data del 4 novembre. Tant’è che ha appena fatto sapere che al motto che lo riguarda: «Sine strage vici», intende aggiungere una formula augurale: «Insperata floret», il destino della patria.
A Milano in queste stesse ore Mussolini sta pesando una volta di più in compagnia dei fedelissimi Michele Bianchi e Cesare Rossi i pro e i contro di questa marcia su Roma che egli ha voluto, ma che presenta non poche incognite. Nell’iconografia a venire lo descriveranno nella veste di un condottiero audace, frammezzo ai quadrumviri, lui in camicia nera e una fascia tricolore a cingergli il petto (seppure con le ghette ai piedi, che in assoluto contrastano con ogni e qualsiasi vestimenta militare), come lo si vede in un quadro famoso di Giacomo Balla – che per altro verso non ha rinunciato sul retro a dipingervi una splendida composizione futurista – o addirittura a cavallo, alla testa delle legioni in marcia su Roma. Niente di più inesatto. Mussolini la marcia la vive e la vivrà fino all’ultimo a Milano, come sempre il suo retroterra naturale, lasciando ai quadrumviri il compito di operare sul terreno. Non lo troviamo a Perugia, né a Santa Marinella, a Tivoli, a Monterotondo, al punto da far scrivere un giorno a Gaetano Salvemini che forse non ha creduto fino in fondo allo sbocco vittorioso del movimento, altrimenti «si sarebbe sicuramente recato a Perugia per attribuirsi tutta la gloria del “combattimento” e della vittoria nel centro dell’insurrezione». Preferisce restare a Milano, a 600 chilometri da Roma, «ma a due ore dalla frontiera svizzera conservandosi così non solo delle posizioni politiche di ripiego, ma la possibilità stessa di una fuga, se la situazione volgesse al peggio».
Un ritratto del Mussolini che rimane a Milano che contrasta con le vicende di colui che verrà chiamato per antonomasia «il Duce». L’uomo è tutto fuorché vile, ha determinazione e coraggio personale, l’ha dimostrato alla testa della corrente massimalista dei socialisti italiani, nella sua campagna per l’intervento in guerra, al fronte dov’è stato ferito, seppure nel corso di una esercitazione, quando ha dovuto fronteggiare il dileggio dei suoi vecchi compagni, lo dimostrerà in avvenire allorché subirà degli attentati, e secondo le ultime rivelazioni – quelle di Aldo Lampredi – davanti al mitra di Walter Audisio che pone termine alla sua esistenza. Se rimane a Milano non è per imboscarsi – niente di certo è impossibile, ma è difficile crederlo – quanto piuttosto per guardare agli avvenimenti di questi giorni con la necessaria freddezza, cosa impensabile nel bailamme di una marcia, a Perugia, a Santa Marinella, a Tivoli, a Monterotondo o altrove; per avere una maggiore libertà di muovere i fili, di intessere contatti e trattative, da un lato per una soluzione incruenta del colpo di Stato, e inoltre, questo sì, per mantenere aperta, egli pure, una via di ritirata politica qualora le cose non si mettessero al meglio. Un atteggiamento da «o la va o la spacca», ma con qualche valvola di sicurezza, per lui e per il fascismo, che non li mandi al macero d’un colpo. Restare a Milano vuol dire oltretutto mostrare sicurezza, non farsi invischiare nelle diatribe che agitano anche i suoi luogotenenti, che Cesare Rossi racconterà con queste parole: «… pensava [mussolini restando a milano] alle insidie di Grandi, alle manovre di Federzoni a Roma, alla sorniona opposizione di De Vecchi e De Bono i quali non volevano davvero una soluzione totalitaria e mussoliniana alla marcia su Roma. Pensava … a tenere a bada un po’ tutti».
Alcuni – Grandi e Federzoni, Ciano e Acerbo – che puntano su una soluzione Salandra della crisi, altri troppo preoccupati che non si tocchi l’istituzione monarchica, a riprova una frase del De Vecchi di questi giorni: «Se il re proclama lo stato d’assedio, se i fascisti dovessero investire il Quirinale, io passerò coi miei uomini dalla parte del sovrano». Laddove Mussolini è più sbrigativo, sa che Vittorio Emanuele è persona da conquistare, ma nemmeno crede alla sacralità della monarchia. Come dirà un giorno per chiarire come la pensi: «In ottobre abbiamo commesso un piccolo errore, anziché marciare davanti al Quirinale avremmo dovuto penetrarvi dentro». Da aggiungere quest’altra considerazione circa il carisma dell’uomo, il fatto che pure restando a Milano, non per questo gli mancherà, per quanti siano stati, la fedeltà delle squadre fasciste per un’azione fino all’ultimo di incerta riuscita. Come dirà di questi uomini a cose fatte: «Non erano folle amorfe di dimostranti che una scarica di fucile disperde, ma legioni inquadrate, armate, guidate da gente di fegato, disposte al sacrificio».
Delle affermazioni che di sicuro contengono una dose di esagerazione, anche perché la prova del fuoco non ci sarà. Ma è certo che non tutti sarebbero riusciti a muovere per una impresa altrettanto dubbiosa, non i trecentomila uomini della leggenda, ma nemmeno i trentamila partecipanti effettivi.
page-no="194" È una volta di più al fedelissimo Bianchi che Mussolini dà queste altre disposizioni per la marcia: la data, subito dopo il convegno di Napoli. Tre, come ripete, le colonne in marcia verso la Capitale. Un atteggiamento di simpatia verso l’esercito «col quale eviterete lo scontro senza tuttavia cedere, poiché la meta è Roma a tutti i costi». Le armi? «Individuare i depositi dell’esercito, e nel frattempo disarmare i Barabba dei piccoli distaccamenti». Il lavoro dovrà essere sospeso in tutta Italia. Delle squadre di arditi a Roma «per seminare panico in caso di resistenza». Inoltre continua l’operazione di mascheramento. È in questo giorno che Mussolini lancia ai suoi avversari reali o potenziali una proposta di cui finora non aveva parlato: l’immediata convocazione della Camera – senza aspettare la data del 7 novembre – e poi nuove elezioni.
Perché questa mossa improvvisa? Come racconta Balbo nel suo Diario: «Si gioca a rimpiattino. Questo spettro delle elezioni è più che sufficiente per accecare gli occhi dei vecchi parlamentari che sono tutti in moto per invocare la nostra alleanza. Con questa lusinga faremo di loro quel che vogliamo. Siamo nati ieri, ma siamo più intelligenti di loro». E anche qui non mancano le carte in mano a Mussolini. Le elezioni di questi giorni a Reggio Emilia e a Rovigo hanno visto un grande successo delle liste del fascio. A Milano popolari e liberal-democratici, dopo la dissoluzione della Giunta municipale a maggioranza socialista, si dicono disposti, quali che siano le pressioni di don Sturzo sugli esponenti del suo partito, a entrare coi fascisti in una lista di Blocco nazionale. Insomma, non c’è solamente la marcia a garantire il successo.
Semmai le preoccupazioni sono altre, gli vengono, per dirne una, dal fronte del vecchio nazionalismo italiano. In Liguria, a Riomaggiore, ci sono stati degli scontri fra nazionalisti e fascisti, con la morte di due nazionalisti. A Roma è incominciata la mobilitazione delle camicie azzurre comandate da Raffaele Paolucci, personaggio non da poco, chirurgo in origine, ufficiale di marina in guerra, l’uomo che con Raffaele Rossetti è penetrato alla guida di un mas nel porto di Pola affondando con un siluro la corazzata austriaca Viribus Unitis, e per questa impresa meritando, eroe giovanissimo – è nato nel 1892 – una medaglia d’oro. E i legionari di Paolucci sono una forza di tutto rispetto, si dice diecimila uomini, in larga parte provenienti dalla campagna romana, decisi a battersi in difesa del sovrano regnante.
In tutta Italia continua nel frattempo il conto alla rovescia, il concentramento degli squadristi per la marcia su Roma, con tutte le cerimonie rituali che un tale avvenimento comporta. In gran parte della Valle Padana, in Toscana e Umbria si giudica che la polizia sia favorevole al colpo di Stato, Milano, Torino e Genova non sono ostili, ma nemmeno troppo compromesse, a Milano per esempio è a favore il generale Giovanni Cattaneo, comandante della divisione militare di stanza in città, contrario il questore Giovanni Guasti, un piemontese ligio al dovere. Incerta Firenze malgrado la presa di Perrone Compagni, qui il prefetto Vincenzo Pericoli si è asserragliato a palazzo Riccardi, e le truppe raggruppate nelle caserme in attesa di ordini. Nella stessa Perugia la prefettura è difesa dai carabinieri e dalle guardie regie. È comunque a Perugia che Balbo raduna le squadre umbre per un giuramento solenne di fedeltà a Mussolini. Cerimonie di genere analogo hanno luogo in Garfagnana, a Carrara, dove le squadre vengono messe al comando di Renato Ricci, ad Alessandria dove impera Eduardo Torre, a Piacenza, a Cremona feudo dell’inquieto Farinacci, a Trieste per la regia di Francesco Giunta, a Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, a Pisa sotto il controllo di Carlo Scorza.
È sempre a Perugia che si materializza stamane un personaggio inatteso, il duca Emanuele Filiberto di Savoia Aosta in compagnia del figlio maggiore Amedeo. Una visita brevissima, forse soltanto di passaggio, ma sufficiente a destare i sospetti di chi ha sempre visto nel «duca invitto» un rivale di Vittorio Emanuele III. Tanto più che Emanuele Filiberto nel pieno della marcia su Roma penserà bene di stabilirsi in una cittadina dell’Umbria, nei pressi di Foligno, dove si ammassano le riserve fasciste, a soli 56 chilometri da Perugia.
Il re, Vittorio Emanuele, dal canto suo non ha lasciato San Rossore, pure mantenendo contatti quasi quotidiani col suo primo ministro, Luigi Facta. Aspetta e ascolta, legge e giudica per quel dialogo a distanza con Mussolini che in tanti modi viene portato avanti. Ci sono stati a rassicurarlo il discorso di Udine, l’incontro di De Vecchi e di De Bono con la regina Margherita, le tante dichiarazioni di fedeltà alla Corona che gli portano alcuni dei personaggi più vicini a Mussolini. Fra poco ci sarà, a ribadire le promesse fatte, un discorso a Napoli dove il fascismo militante si è dato convegno, e dove verranno prese le ultime disposizioni per la conquista del potere. «Di quel Mussolini c’è da fidarsi?», ha chiesto, come si sa, il sovrano a Facta. Ed è pensabile che il presidente del Consiglio gli abbia dato le garanzie opportune, ovviamente nella chiave di un governo a venire, Giolitti più Mussolini.
Giovanni Giolitti sta per compiere ottant’anni, per l’epoca una età che non tutti riescono a raggiungere. E il Piemonte intero si prepara a dei solenni festeggiamenti per un uomo che ha segnato di sé una bella parte della storia del paese. C’è tuttavia almeno una presenza che potrebbe esserci, e invece non è previsto che ci sia, non il sovrano che fosse solo per ragioni di protocollo non va alla festa di compleanno seppure di un vecchio primo ministro di tale peso e prestigio. Chi potrebbe esserci e non ci sarà è il primo ministro Facta, così preso dai maneggi romani da non poter correre a rendere omaggio al suo idolo politico.
Arrivano invece a Cavour, per incontrarvi Giolitti, il ministro delle Finanze, Giovanni Battista Bertone, del partito popolare, Corradini, il prefetto Lusignoli, e con quest’ultimo Armando Zanetti, direttore del «Sera» di Milano. Oggetto dell’incontro i contatti, seppure indiretti, fra Giolitti e Mussolini, e la crisi di rapporti che si è determinata, dopo che quello ha cominciato a tirare in lungo, a prendere tempo, a evitare una risposta diretta all’offerta di Giolitti di assegnare ai fascisti tre portafogli ministeriali importanti, e di lasciargli scegliere per il dicastero degli Esteri «una personalità che risponda ai suoi desideri», con la sola condizione di avere nel governo il capo del fascismo come ministro senza portafogli. Giolitti si è stancato a tal punto di questo braccio di ferro da far capire d’essere disposto a formare un governo «anche senza i fascisti».
page-no="197" Lusignoli in questo ultimo incontro sembra voler convincere Giolitti che non tutto è perduto: «I fascisti hanno stima di lei. Me ne ha parlato in persona l’onorevole Mussolini».
E Bertone: «Il presidente Facta è pronto ad abbandonare le redini».
Al che Giolitti con un briciolo di ironia: «Che faccia allora il suo dovere, che si dimetta».
Corradini è il più deciso nello spronare Giolitti a tener fede all’idea di un governo senza i fascisti: «Tutte le forze nazionali vi appoggerebbero».
Ma Giolitti non sembra più altrettanto convinto dell’opportunità di rimettersi a capo di un governo. Come dice con una nota di stanchezza nella voce: «Aspettiamo il convegno di Napoli. Poi… si vedrà».
In Liguria in quel di Savona c’è un giovane avvocato smobilitato da poco, che non voleva la guerra, ma ha fatto egualmente il proprio dovere al fronte, meritandosi una medaglia d’argento che non gli è stata consegnata perché giudicato di idee «sovversive». Un socialista di nome Sandro Pertini, con alle spalle una famiglia, come dirà, che «ha pagato alti prezzi». Una madre religiosissima alla quale verranno negati i funerali in chiesa per punirla di quel figlio ribelle. Un fratello, Eugenio, il «fratello più amato» che finisce nel lager di Flossenburg dove verrà fucilato alla vigilia del 25 aprile 1945. E un altro fratello, Pippo, ufficiale di carriera col grado di capitano, che dopo essere stato insultato e sputacchiato sul molo di Savona per la divisa che portava addosso ha deciso di aderire al fascio. Sandro Pertini in questi giorni non sa troppo bene cosa si possa fare, è tuttavia convinto che si debba prendere posizione, battersi se occorre per strada, e intanto incomincia a redigere e a distribuire dei manifestini di propaganda antifascista. Un cammino tutto in salita il suo, che lo porta all’esilio in Francia, e al suo rientro in Italia davanti al Tribunale Speciale che lo condanna all’ergastolo di Santo Stefano, più avanti a Roma nella Resistenza, catturato e rinchiuso a Regina Coeli nel braccio dei condannati a morte, da dove evade per raggiungere al Nord le forze che si oppongono ai tedeschi e al fascismo di Salò.
page-no="198" Il fratello Pippo nel saperlo all’ergastolo di Santo Stefano muore, come si dirà, di crepacuore, di certo se aveva un cuore malandato quella condanna non l’ha aiutato. Sandro Pertini diventerà un giorno presidente della Repubblica, promettendo nel suo discorso di investitura di voler essere «il presidente di tutti gli italiani», anche di quelli che gli sono stati nemici sull’altro versante della barricata.
page-no="199" ![]()
23 OTTOBRE, LUNEDÌ
Quando si porta il nome di Giovanni Giolitti, ci si può arrendere, ma con l’onore delle armi, non la resa senza condizioni di Francesco Saverio Nitti a Lauria, non il piatto di lenticchie, pardon di denaro, per cui si è venduto Gabriele d’Annunzio.
Per gli ottant’anni di questa gloria nazionale, Cavour si è imbandierata a festa, le strade decorate di fiori e di manifesti, una esplosione di lampadine colorate la sera, un coro di bimbi davanti a casa che l’ha svegliato di mattina, e bigliettini d’auguri a centinaia. Non sono mancati dei cesti ripieni di vino e di cibarie, in uno di questi degli splendidi tartufi d’Alba. E fra i gesti di omaggio che più gli hanno fatto piacere una medaglia con le sue fattezze, opera dello scultore Leonardo Bistolfi, e la scritta: «Gli italiani riconoscenti».
È previsto che egli tenga un discorso al Consiglio provinciale di Cuneo, di cui fa parte. Ovviamente un discorso sui problemi del momento. E Giolitti non delude gli ascoltatori. Come dice fra l’altro, pesando ogni parola: «Il fascismo deve prendere quel posto a cui gli dà diritto il numero dei suoi aderenti, ma …», e qui una pausa affinché si comprenda meglio quello che sta per aggiungere, «ma nelle vie legali, le sole per le quali si può rialzare l’autorità dello Stato, ristabilire la pace sociale, contribuire alla salvezza della patria». E ancora: «Occorre uno sforzo eroico per evitare il fallimento, spendere meno, risanare i servizi pubblici, fare una politica interna ed estera che riconduca il paese sulla strada del rispetto che si merita da parte delle altre nazioni, e di uno sviluppo interno che non possiamo mancare di riprendere».
page-no="200" Sempre diritto nella persona, la voce robusta venata di inflessioni piemontesi, come agli ascoltatori piace che sia. L’immagine per dirne una dell’uomo di Stato allenato ad affrontare ogni evento, positivo o negativo che sia. Un uragano di applausi accoglie il suo intervento, si fa a gara per avvicinarsi a lui, per stringergli la mano, e naturalmente per augurargli un rapido ritorno alla testa del governo, con Mussolini, certo, ma alle condizioni che ha dettato, cioè «nelle vie legali». Un commesso si fa strada tra la folla per comunicare al grand’uomo che lo vogliono al telefono: «Da Roma, dalla presidenza del Consiglio. Venga, Eccellenza, per di qua…», e lo guida verso una saletta riservata. Al telefono c’è Facta, con un certo imbarazzo nella voce: «Intanto infinite scuse per non essere con te in questo fausto giorno. Ma sai, le incombenze di governo…».
E di fronte al silenzio di Giolitti: «I fascisti stanno avviandosi a frotte verso Napoli. Ritieni che si debba vietare il convegno?».
E Giolitti, secco: «Non è un po’ tardi per un provvedimento del genere?». Poi, senza attendere la reazione di Facta: «No, non vedo perché si debba vietare il convegno». E riabbassa la cornetta dopo un primo «grazie» dell’altro.
Ha posto le sue condizioni per un governo con Mussolini, e sembra ancora sperare che vengano accettate. Il problema è di vedere se Mussolini non abbia scelto definitivamente tutt’altra strada.
Anche Facta è relativamente ottimista. Da Roma si è appena messo in contatto con Milano, e il prefetto Lusigno...