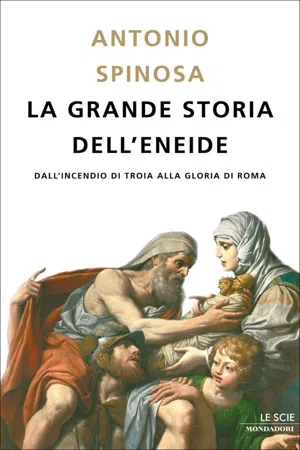![]()
Parte terza
QUANDO SORGE ALBA LONGA
Roma all’orizzonte
![]()
I
Le coste cartaginesi erano già scomparse all’orizzonte, e più non si scorgeva l’alto pennacchio di fumo che scaturiva dalla pira funeraria di Didone. La flotta troiana era nel pieno del canale di Sicilia, sospesa fra le profondità dei flutti marini e le alte vette delle atmosfere celesti. D’improvviso una fitta nebbia avvolgeva le navi, e i raggi del sole erano oscurati da plumbei e piovosi nembi.
Palinuro, ritto sulla legnosa poppa della nave, teneva stretto il timone; i rematori, grondando sudore, si inarcavano sui banchi tirando i ruvidi remi percossi dalle dure onde del mare. Enea accorreva sul ponte e diceva parole che infondevano fiducia. Palinuro, che non riusciva più a tenere la rotta, gli si rivolgeva gridando: «Mio signore! La procella è troppo forte, e io più non governo la nave. Anche gli altri timonieri sono in difficoltà e, agitando le lucerne, mi dicono di cambiare direzione. Ora perciò ripiego verso il porto di Erice».
Erice! Sulle sue vette s’innalzava un famoso tempio dedicato alla dea Venere, ma alle orecchie del prode Enea il nome del monte tristemente risuonava nel rammentargli la morte del padre e il triste destino del fratellastro Erice. L’eroe dava ordine a Palinuro di seguire la rotta da lui ritenuta più sicura per l’incolumità delle navi. Stringeva a sé il figlio, mentre gli diceva: «Il porto verso cui Palinuro si dirige reca il nome di un nostro consanguineo, Erice, figlio di Afrodite e di un re del popolo siculo, Bute. Il mio fratellastro onorò la tua cara nonna dedicandole un sacro recinto, ma un giorno si rivelò assai incauto nell’affrontare il possente Ercole». E proseguiva: «Il figlio di Giove attraversava la Sicilia con i buoi sottratti al mostruoso Gerione, quando Erice tentò di metterli in gioco tra loro due proponendo una gara di pugilato. Impari tenzone! Difatti Ercole, con pochi colpi, sopprimeva Erice, e ne gettava il cadavere nei più profondi abissi marini».
La flotta, che già era in vista delle coste occidentali dell’isola trinacria, subito cominciava a risalire le acque per raggiungere il porto ericino. Enea si rincuorava scorgendo quei luoghi a lui familiari per averli già percorsi in un primo viaggio con Anchise. Il sacro genitore ora riposava sotto un alto cumulo nella terra degli elimi governata dal re Aceste il quale, avvistate le navi iliache, si precipitava sulla spiaggia con alcuni sudditi per accogliere i profughi e ristorarli dalle fatiche del viaggio.
Virgilio dipinge Aceste pari a un selvaggio «irto di dardi e con una pelle di orsa libica». Ma, al di là delle severe parole del poeta, chi era davvero costui? Le leggende si rincorrono l’un l’altra, ed è arduo indicare quella che più si avvicina alla verità. Ma ecco in proposito, per la gioia del lettore e in breve, la storia narrata da Servio, un antico commentatore dell’Eneide: «Aceste o Egeste: il mito riferisce che il re troiano Laomedonte non volle pagare ad Apollo e a Poseidone la costruzione delle mura della città dardania. Quei numi si adirarono aspramente e, per cercare di placarli, si pensò di sacrificare sui loro altari alcuni fra i più giovani rampolli dell’aristocrazia cittadina. Ma un tale di nome Ippostrato, nel tentativo di evitare che anche la sua figlioletta, Egesta, fosse fra le vittime, l’affidò nascostamente ad alcuni mercanti affinché la conducessero altrove. I commercianti nascosero la ragazza in Sicilia, ma qui il dio-fiume Crimiso – oggi torrente Freddo – la fece sua». Da quel connubio nacque Aceste, il fondatore della città di Segesta.
Enea lasciava la nave, e il re siculo, nell’abbracciarlo, gli porgeva doni ospitali: carni, vino e magnifiche pelli. Entrambi poi si avviavano verso un villaggio di capanne con al centro una vasta costruzione ellittica dal tetto di paglia e i muri di fango. Era la dimora di Aceste. Le pareti della saletta centrale apparivano rivestite di pelli e adorne di armi primitive. Al centro ardeva un fuoco il cui fumo saliva al cielo attraverso un’apertura del tetto. A terra vi erano stuoie di paglia e di canne intrecciate.
Alcuni servitori offrivano calorosamente agli ospiti succulenti cosciotti di capra e di agnello. Enea e Aceste erano seduti l’uno accanto all’altro, mentre l’eroe troiano raccontava di come i venti lo avessero sospinto sui lidi africani; ricordava il soggiorno nella città di Didone, e il mare tempestoso che egli aveva dovuto percorrere per porre piede in Sicilia. Il vino scorreva sulle mense a fiumi, e i profughi di Ilio si ristoravano con gustose vivande.
Il giorno successivo all’arrivo, Enea, chiamati a sé Ascanio e i compagni, esclamava, in presenza anche di Aceste: «Gloriosa stirpe di Dardano! Gli dei ci hanno sospinto nuovamente sui lidi di Sicilia bella, e ci hanno concesso la sacra ospitalità del saggio Aceste. Tuttavia non posso non ricordare come in questa terra sia sepolto mio padre Anchise. A lui il sommo Giove non volle concedere la gioia di approdare all’agognato Lazio». Con commozione soggiungeva: «Prima di partire alla volta del Tevere desidero onorare il nume del genitore con giochi funebri: corsa, pugilato, tiro con l’arco, regate. Non soltanto i troiani, ma anche i nostri ospiti, i sudditi di Aceste, parteciperanno alle gare. Preparatevi affinché tra nove giorni si possa dare il via ai ludi».
Alla testa di una processione Enea e Aceste si recavano sul tumulo di Anchise per compiervi i sacrifici rituali: versavano a terra due tazze di vino, due di latte e due di sangue. Le donne intonavano canti funebri e gli anziani elevavano preghiere agli dei inferi.
Inatteso fu un prodigio: un serpente sbucava dal tumulo e, avvolgendolo con sette spire, bevve le offerte tributate dai due sovrani. Tutti sbalorditi! Si interrogarono gli indovini per cogliere il significato dell’evento, che poté essere considerato di buon auspicio. Enea fu quindi incoraggiato a compiere nuovi sacrifici, per cui, su un rozzo altare di terra e di ciottoli, immolava bianche pecore, grossi maiali e neri torelli. Poi, con quelle carni rituali, si allestiva un banchetto nei pressi dell’avello per consumare tutti insieme i cibi in onore del defunto. Ognuno attendeva ansioso l’inizio dei giochi funebri.
Arrivava il nono giorno. Una moltitudine di spettatori si era radunata nei pressi del villaggio di Aceste, e avevano inizio le gare indette in onore di Anchise. In una grande regata trionfava il troiano Cloanto con la barca Scilla; seguiva la corsa a piedi, cui partecipavano i giovanissimi iliaci Eurialo e Niso, gli arcadi Salio e Patrone, i siculi Elimo e Panope. In essa vinceva Eurialo.
La gara più eccitante era quella di pugilato. Vi si affrontavano il dardanio Darete, giovane, possente, baldanzoso, e l’elimo Entello, un po’ più avanti negli anni, saggio, allievo del grande Erice. Entello non avrebbe voluto partecipare all’agone, ma a sospingerlo nell’arena era stato il re Aceste, ben conoscendone la possanza. Eccitante era lo spettacolo, assordante il tifo degli spettatori. I pugilatori si colpivano duramente. Alle mani avevano guantoni rafforzati da sottili vimini intrecciati a fili di ferro. Entello, anche se meno giovane e meno atletico di Darete, schivava i ganci a lui diretti. Inesorabile era la sua rimonta: con violenza si gettava sull’avversario tempestandolo di colpi magistrali.
Enea si affrettava a dichiarare Entello vincitore dello scontro e a far trasportare Darete sulla nave. La spavalderia del giovane troiano era stata punita dall’esperienza del più fiero e canuto Entello che, per mostrare ulteriormente la sua forza, aveva colpito a morte persino il toro che gli era stato assegnato per la vittoria. Infatti Entello, con quel sacrificio, decideva di chiudere la carriera di pugile.
A lui si ispirerà Umberto Saba: «Per una donna lontana e un ragazzo / che mi ascolta, celeste, / ho scritte, io vecchio, queste / poesie. Ricordo, / come in me lieto le ripenso, antico / pugile. Entello era il suo nome. Vinse / l’ultima volta ai fortunosi giochi / d’Enea, lungo le amene / spiagge della Sicilia, ospite Aceste. / Bianche si rincorrevano sull’onde / schiume che in alto mare eran Sirene. / Era un cuore gagliardo ed era saggio. / “Qui – disse – i cesti, e qui l’arte depongo.”».
Partecipava alla gara con l’arco anche il re Aceste. Il bersaglio era una colomba legata con una fune all’albero maestro di una nave troiana. Il vincitore fu Mnesteo, ma Aceste ugualmente scoccava un dardo che si librava alto nel cielo. Evento straordinario: quella freccia s’incendiava provocando spavento fra gli spettatori. Enea interpretava come fausto il segno, e attribuiva la palma della vittoria al re siculo. Ma il prodigio fu davvero ferale!
Giunone, furibonda per la sorte toccata a Didone, meditava sulla punizione da infliggere ai troiani, e aveva ormai delineato un piano. Chiamata a sé Iride, così le diceva: «Dea dell’arcobaleno, guarda, guarda, come gli stolti troiani ridono e giocano in terra sicula senza darsi pensiero di essere stati con i cartaginesi ospiti fedifraghi». Con più livore proseguiva: «Volgi lo sguardo all’infiacchito Enea. Egli ha già dimenticato l’affronto recato alla mia amata Didone. Non si è minimamente curato di averla sospinta al suicidio. Ma questo è il momento che la paghi cara per i suoi misfatti. Io farò di tutto perché non approdi mai sui lidi d’Italia».
Spaventata, Iride fissava con occhi fiammeggianti la regina deorum. E sussurrava: «Oh mia signora! Che cosa vuoi che io faccia? Dimmelo!». E Giunone: «Scendi sul campo troiano e confonditi fra le donne cui, per le sciocche usanze degli uomini, non è consentito di assistere ai giochi. Assumi le forme della vecchia Beroe, la sposa dell’epirota Doriclo, che si è unita agli eneadi in Epiro. E in quelle sembianze incita le donne teucre a compiere follie per impedire a Enea di muovere alla volta del Lazio!».
Iride accorreva sulla terra e, assunte le sembianze di Beroe, si affrettava a compiere il funesto inganno così freddamente ordito della consorte di Zeus.
![]()
II
I guerrieri troiani e siculi festeggiavano i vincitori delle gare che si erano svolte in onore di Anchise. Per l’occasione Enea aveva segretamente indetto una spettacolare esibizione equestre e ne aveva affidato la preparazione alle abili arti del precettore di Ascanio, Epitide, il figlio dell’araldo di Anchise.
Nell’improvvisata arena dei giochi si schieravano tre gruppi di giovanissimi cavalieri che però erano suddivisi in doppia fila, avendo ciascuna di esse un proprio comandante. La prima squadra era guidata da Priamo, il figlio di Polite e nipote del defunto re troiano; la seconda era capeggiata da Atys, e da lui sarebbe discesa Azia, la madre di Augusto; la terza presentava Ascanio superbamente in groppa a un cavallo libico, dono di Didone. Enea aveva denominato lo spettacolo Ludus Troiae in onore delle battaglie che i teucri avevano sostenuto contro i greci sotto le mura di Ilio.
Ludus Troiae! Questa era una gara celebre nella Roma virgiliana e particolarmente cara ad Augusto che vi aveva anche preso parte durante i festeggiamenti del 46 a.C. svoltisi in occasione del triplice trionfo tributato allo zio Giulio Cesare. Era opinione comune che Ottaviano, asceso al potere, avesse restituito rilevanza a quelle gare equestri proprio perché erano state per la prima volta guidate da Iulo, il capostipite della gens Iulia, da cui egli orgogliosamente affermava di discendere.
Gli uomini erano rapiti nel seguire le corse dei cavalli, e la dea Iride, sotto le mentite spoglie della troiana Beroe, attuava il diabolico inganno che per lei aveva escogitato Giunone. Confusa fra le donne teucre, così le arringava: «Oh noi sventurate, quale infausto destino ci attende una volta che sia conclusa questa sosta nella pacifica terra di Aceste? Quante di noi non saranno più in vita durante il lungo viaggio? Quanto ancora durerà questa terribile peregrinazione che già si prolunga da ben sette estati?». Quindi, con maggior lena, diceva: «Gli dei ci risparmiarono dalle razzie dei guerrieri di Agamennone e di Menelao, ma ora la follia di Enea non ci eviterà di cadere vittime dei numi inferi. Ricordate il bel Simoenta e la fertile pianura di Troia? Potremo mai rivedere l’uno e l’altra?». Concludeva: «Nella notte mi è apparsa in sogno la profetessa Cassandra con nelle mani due fiaccole. E mi ha rivelato che qui – in Sicilia, non certo nel Lazio – fonderemo la nuova Ilio. Mi ha quindi consegnato alcuni tizzoni ardenti affinché io possa dar fuoco alla malefica flotta ancorata nel porto ericino».
Enorme fu l’effetto suscitato dalle parole di Beroe-Iride sulle donne troiane. Ancor più stupefacente fu il prodigio per cui la dea, nel riprendere le naturali sembianze, si involava in cielo lasciandosi alle spalle una scia multicolore. Le matrone dardanie, sopraffatte dallo stupore, pensavano che realmente gli dei vedessero la Sicilia come la terra promessa. Infiammate dall’ira, simili a menadi, correvano agli altari fumanti attorno all’avello di Anchise: impugnavano grossi rami infuocati, si lanciavano contro le navi attraccate nel porto e vi appiccavano il fuoco. In pochi istanti le fiamme avvolgevano quei legni di abete, mentre un aspro odore di resina si propagava nell’accampamento teucro.
Giunone osservava la scena dall’alto dell’Olimpo, godendone. Il rogo attirava l’attenzione del vecchio Eumelo che, pur malfermo sulle gambe, correva da Enea per dare l’allarme con alte grida: «Correte, oh guerrieri! La follia ha sconvolto le nostre donne, e ora alte fiamme distruggono le navi».
Ascanio arrivava per primo in groppa a un superbo destriero, e con dure parole apostrofava le donne. Sopraggiungevano altri teucri e con loro i siculi. Vani erano però i loro sforzi volti a spegnere l’incendio, e le fiamme ancor più rapidamente divoravano le chiglie delle navi. Enea, strappandosi le vesti e con gli occhi rivolti al cielo, pregava Zeus. Lo implorava: «Oh padre divino! Se non ci odii al punto di desiderare la nostra morte, e se davvero vuoi che noi si raggiunga la terra natia dell’antenato Dardano, ferma con il tuo possente braccio le fiamme che avvolgono la flotta. Oppure annientaci con una folgore, e ci risparmierai altre sofferenze».
Ai tuoni e ai fulmini seguì un insperato scroscio di pioggia che alfine domò le fiamme. Quattro navi erano perdute, ma salvo era il resto della flotta. A quel nuovo nero segno del cielo le donne si erano disperse spaventate: chi nei boschi, chi nelle spelonche. Urla e pianti regnavano sovrani. Che cosa fare? L’insana fuga delle iliache manifestava insofferenza e una gran voglia di non proseguire il duro viaggio.
Appariva Naute, il canuto sacerdote di Atena. Si avvicinava a Enea per spingerlo a compiere una grande impresa: quella di fondare una città nella terra degli elimi e di condurvi coloro che per l’età avanzata, per malattie o per altre tristi ragioni non fossero più in grado di partire per Il Lazio. Alta era la responsabilità che gravava sul figlio di Venere!
Scendeva la notte, le donne tornavano dai mariti. Enea aveva ordinato di non punirle poiché esse soltanto per l’inganno di un dio avevano dato fuoco alle navi. L’eroe, con accanto il figlio, era confortato da Aceste che lo ospitava. E mentre si coricava su una morbida pelle di bue per riposare le stanche membra, gli appariva l’ombra di Anchise che gli consigliava di seguire quanto gli aveva detto Naute e di tracciare il perimetro di una città nei luoghi del suo sepolcro. Quindi aggiungeva: «Figlio mio! Parti alla volta del Lazio e, durante il viaggio, fermati nell’antro oracolare della sibilla, a Cuma. Costei ti rivelerà come discendere nei bui sentieri dell’Ade e come trovare la via che conduce ai luminosi Campi Elisi. Io ti attendo per svelarti le peripezie che dovrai affrontare in terra enotria e per mostrarti i gloriosi uomini che sorgeranno dalla tua stirpe!».
Erano trascorse alcune settimane dall’incendio delle navi quando Enea celebrava un nuovo rito propiziatorio. Con l’ausilio di un aratro tirato da un pingue bue tracciava il sulcus primigenius della città Acesta, che in seguito sarà la bella Segesta. Estraeva a sorte i lotti di terreno da affidare a quanti sarebbero rimasti in terra sicula, e affidava al re Aceste il governo del nuovo insediamento.
Imbarcate numerose provviste e compiuti i sacrifici agli dei marini, gli eneadi partivano alla volta dell’Italia. Lungo era il viaggio e temibili i lidi della ferace Calabria, come quelli della solare Campania. Ma Venere aveva pur garantito al figlio una felice navigazione dopo aver vezzeggiato il possente Poseidone perché placasse le onde e favorisse lo spirare di favorevoli brezze. Il dio marino aveva chiesto in cambio un orribile compenso: il sacrificio di un uomo, sicché Thanatos, la Morte, si sarebbe abbattuta su Palinuro.
Nel pieno della notte il Sonno, l’ammaliatore dei mortali, calava sul fido timoniere di Enea e lo faceva precipitare nei gorghi del mare senza che qualcuno se ne avvedesse; e il figlio di Venere dormiva profondamente per il languore che lo stesso dio Ipnos gli aveva gettato addosso. Le onde trascinarono le spoglie di Palinuro sulla spiaggia di un roccioso promontorio che da quel giorno ne prendeva il nome.
Secoli e secoli più tardi Giuseppe Ungaretti, ripercorrendo la rotta seguita da Enea, descriverà in questa memorabile pagina il mitico paesaggio di capo Palinuro e altro:
«La costa si fa rocciosa, sovrastata da monti ricoperti da ciuffi di ulivi. In quel mentre appare, penetrato nel mare, Palinuro, come uno squalo smisurato, caricato d’oro. E ora gli ulivi hanno un alone di luce intorno alle foglie, come i santi. Ora i monti che fiancheggio vanno avanti e indietro, e alcuni arrivano ritti sull’acqua, e altri, prostrati, appiattiti, si prolungano in orazione.
«Di colpo, il mare in punto ha un forte fremito: è un branco di anatre marzaiole che si rimettono in viaggio. Sono arrivate sull’alba, e ora che principia l’imbrunire, volano via. Così fuggì quel dio Sonno sceso a tradire Palinuro mandandolo in malora con il timone spezzato. E le onde, ora repentinamente infuriate, le muove forse il nuoto disperato del fedele nocchiere d’Enea?». E oggi? «Il porto di Palinuro ha casette bianche, e l’ultima è rosa: sembrano sulle prime biancheria stesa ad asciugare, e poi blocchetti di gesso.»
![]()
III
La morte di Palinuro, pur avendo gettato nel più profondo dolore Enea e i guerrieri troiani, non aveva influito su una navigazione che da sette lunghi anni si protraeva ardua e pericolosa. Così i profughi erano arrivati sani e salvi sui lidi della solare Italia.
La flotta iliaca costeggiava la boscosa Campania, attraversava l’ampio golfo partenopeo costellato dalle fascinose isole di Ischia, Capri e Procida. Il mare era dominato dall’ombra del Vesuvio che, pur apparendo come un alto monte verdeggiante, era in realtà un vulcano temibile: nel 79 d.C. avrebbe distrutto e ricoperto di lava Pompei ed Ercolano.
I troiani, superato il golfo, arrivavano alfine ai piedi del promontorio tufaceo di Cuma. In alto, sulla rupe, troneggiava nello splendore dell’oro il tempio di Apollo e, più in basso, si apriva l’immenso antro della sibilla. Enea ricordava i vaticini del padre Anchise e del cugino Eleno, i quali gli avevano consigliato di fermarsi a interrogare la profetessa di Febo per conoscere il suo futuro e scoprire quali peripezie avrebbe dovuto affrontare in terra enotria. Il figlio di Venere ardeva altresì dal desiderio di scendere nei Campi Elisi per incontrare l’anima del defunto genitore, che gli avrebbe mostrato la gloriosa stirpe dei condottieri di Roma.
Le navi dardanie approdavano in un ampio porto naturale contornato da una fitta boscaglia e con scroscianti torrenti che si riversavano nel Tirreno. Per primi e armati balzavano a terra i più giovani, con Ascanio in testa. Montavano sui cavalli scalpitanti e si lanciavano nel folto del bosco a caccia di selvaggina e per attingere acqua potabile, mentre altri allestivano un vasto accampamento in un angolo riparato del lido.
La gioventù teucra si dava ad attività venatorie, ed Enea, cinte le tempie con candide bende e con nelle mani i ricchi doni sacrificali, saliva al santuario apollineo. Era timoroso, ma anche impaziente di ascoltare l’oracolo.
Anacronismi virgiliani! Cuma o Kyme, la più antica colonia greca d’Occidente, ancora non esisteva all’epoca di Enea. Difatti, nel 1200 a.C. il promontorio cumano non era popolato nei suoi boschi incolti che da animali selvatici. Certo, i mercanti micenei...