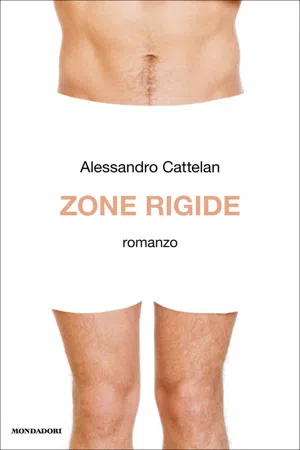![]()
Nat Nat
Prolungare certi incontri anche solo cinque minuti più del dovuto può portare a conseguenze devastanti. Sono passato in ufficio nel tardo pomeriggio, solo per farmi vedere un po’ in giro, dato che l’ultimo show da terza serata è stato accettato e prodotto, pur se con qualche ritocco, e ho quindi guadagnato una piccola scorta di stima extra da parte dei piani alti, convertibile in quel tanto di ossigeno sufficiente a non dover emergere a tutti i costi in superficie. Devo fare giusto un paio di telefonate di lavoro, scroccarne altre private, controllare qualche mail e buttare un occhio alla tabella delle nuove consegne, così, giusto in caso venga colpito da un’illuminazione improvvisa come davanti alla Pietà di Michelangelo.
Sono anche tornato in possesso di un posto fisso nell’ufficio al quarto piano, un piano piuttosto ambito da tutti gli altri assunti. Il motivo principale è la presenza di grandi finestroni affacciati su piazza del Duomo che fanno sembrare la Madunina talmente vicina da poterle dare un cinque col palmo della mano ben aperto e permettono al sole di illuminare le scrivanie con una luce quasi newyorkese. Piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Niente a che vedere comunque con il secondo e terzo piano e quei lunghi corridoi blu che ti fanno salire l’ansia da ospedale ogni volta che strisci il badge ai cancelli d’ingresso. Divido l’ufficio, ironia della sorte, con un nuovo affiliato, tale Giovanni Robotto. Giovanni, oltre a essere il ragazzo che mi ha fregato la scrivania al mio rientro dopo l’ospedale, è un giovane fresco di università, laureato a pieni voti con lode, che è entrato in azienda come stagista ma si è prontamente guadagnato la stima dei capi al punto di essere promosso da addetto alle fotocopie a vice-responsabile dei contenuti editoriali nel giro di qualche mese, in seguito a un paio di produzioni azzeccate in cui, pur essendo un novellino, si è dimostrato all’altezza dei veterani. Questo curriculum invidiabile non lo aiuta certo a farsi degli amici nel settore. Se fino al suo ultimo giorno da porta-caffè era considerato da tutti un giovane e innocuo ragazzo di campagna giunto in città per imparare umilmente il nostro esclusivo mestiere e all’occorrenza mandare qualche fax, dal suo primo giorno da responsabile è diventato un lecchino, strafottente, presuntuoso, senza scrupoli, arrampicatore sociale, gay, pedofilo, comunista o fascista a seconda dei casi, merda, schifo e infettivo.
Ad aggravare la sua posizione, poi, c’è il suo aspetto fisico. Giovanni è bello. Ma non di quelle bellezze scontate e un po’ frocette. Ha una bellezza carica di personalità e se lo si guarda da una certa angolatura è uguale spiccicato a Robbie Williams. Le donne del nostro studio sbrodolano quando lo incrociano per i corridoi, e se qualcuna si ferma a parlare con lui per più di cinque minuti, dopo può lanciare le mutande sul soffitto e queste resterebbero appiccicate lassù all’infinito.
Noi uomini lo odiavamo. Tutti. Ovviamente nessuno glielo ha mai detto apertamente, ma il ragazzo è sveglio abbastanza da capirlo da solo. In più, a causa del suo cognome, una frangia di estremisti di cui faccio ovviamente parte ha smesso di parlargli normalmente, e quando Robotto ci rivolge una domanda diretta ci limitiamo a ripetere a pappagallo la domanda in questione ma con la voce dei robottini dei cartoni animati, muovendoci come i ballerini di breakdance.
page_no="156" «Sapete a che ora è la riunione col direttore?» ci chiede, per esempio.
«Sa-pe-te-a-che-ora-è-la-riu-nio-ne?» rispondiamo muovendoci a scatti. E giù risate.
«Dài ragazzi, sono serio. Sapete a che ora è?» prova a stare al gioco.
«Dài-ra-gaz-zi-so-no-Ro-bot-to-e-so-no-se-ri-o. Sa-pe-te-a-che-ora-è?» e giù risate.
«Ok, molto divertente, ma ho veramente del lavoro da fare, quindi...» tenta di smuovere le nostre coscienze.
«La-vo-ro.» E giù risate.
«Certo che siete proprio stronzi eh? Ma andate affanculo va...» lasciava perdere disgustato.
«Sie-te-pro-prio-stron-zi-eh! Vaf-fan-cu-lo! So-no-Ro-bot-to» e giù risate mentre lo guardiamo allontanarsi. Molto divertente, no?
Oggi pensavo di non correre il rischio di incontrarlo vista l’ora. Anzi, per dirla tutta non pensavo di incontrare proprio nessuno, ma, come dicevo prima, pochi secondi avanti o indietro possono essere determinanti. Entro nell’ufficio cantando in falsetto Beautiful di Christina Aguilera. Ho gli occhi chiusi per esigenze di interpretazione e mi accorgo del mio collega solo dopo aver abbondantemente superato il ritornello e aver lanciato a memoria le chiavi della macchina sulla mia scrivania.
«Buonasera signorina!» mi accoglie a sorpresa il Robotto. Dovevo avere la faccia di un tredicenne che viene sorpreso dalla madre a farsi le seghe davanti alla tv.
«Mhpf» grugnisco alzando appena il mento per accennare un saluto.
«Come mai in ufficio? Non vorrai mica guadagnarti lo stipendio, questo mese?» mi domanda sarcastico senza staccare gli occhi dalla tastiera del suo Mac.
«Co-me-mai-in-uffi-cio-gua-da-gni-sti-pen-dio?» gli rispondo quasi in automatico. Robotto questa volta mi fissa, e il suo sguardo è carico di commiserazione. La cosa mi mette a disagio. Anche perché, essendo solo io e lui, mi rendo conto di quanto poco faccia ridere la nostra gag in assenza di un pubblico di parte. Non aggiungo altro e lui fa lo stesso mentre si alza, chiude lo schermo del suo portatile facendolo schioccare verso il basso e se ne va a casa afferrando la giacca senza nemmeno infilarsela. Non siamo certo quello che si può definire un esempio di cortesia tra colleghi ma poco mi importa, e in più finalmente sono solo. Accendo il computer e come prima cosa cerco di connettermi a Facebook. La linea dell’ufficio è piuttosto lenta e per caricare la pagina devo riprovare più volte l’accesso. Sbrigo la posta velocemente e cancello un paio di foto nelle quali ero stato taggato nonostante avessi una faccia da coglione, quando vengo sorpreso dal rumore severo di nocche che sbattono violentemente contro il legno lucido della porta e che mi provoca la reazione istintiva di abbassare la pagina su cui stavo navigando per sostituirla con la home page del sito del “Corriere della Sera”.
«Quindi è vero, figa!» squilla carica di sorpresa la voce di Damiano, il mio capo.
«Ciao Damiano. Che cosa?» chiedo cercando di tenere il tono della voce più calmo e neutro possibile, nonostante sappia benissimo che tutto ciò che riesco a trasmettere è principalmente il mio terrore. È una sensazione naturale. Quasi pavloviana. Ogni volta che il capo entra nel mio ufficio con la voce che i padri dei telefilm usano con i loro adorati figliuoli, sotto sotto si nasconde insidiosa una bella inculata.
«Che cosa, è vero?» ripeto, non troppo convinto di voler ottenere una risposta.
«Che sei in ufficio, figa... devo ammettere che quando me l’ha detto non ci credevo!»
«Chi gliel’ha detto? Cioè, certo che sono in ufficio, dove dovrei essere? Ma, chi gliel’ha detto?»
«È appena passato Robotto... ha fatto un salto di là da me, prima di andare a casa, figa, e mi ha detto che avevi un po’ di lavoro arretrato e pensavi comunque di fermarti qua fino a tardi e che quindi hai dato la tua disponibilità, già che c’eri, per dare un’occhiata alla bozza di scaletta per la serata di beneficenza per i terremotati.»
«Ci sarà una serata per i terremotati?» chiedo senza aver ancora ben centrato il problema.
«Sì figa... la conduce Carlo Conti. Pure i terremotati adesso devono romperci i coglioni... come se non avessimo abbastanza lavoro con Telethon e 30 ore per la vita e manda un messaggino e l’8 per mille e tutte quelle altre minchiate lì da comunisti... sempre beneficenza per gli altri, figa... a noi non ci pensa mai nessuno eh, dico bene?» Era il discorso più cinico, ignorante e sgradevole che avessi mai sentito, ma lì per lì non avevo colpevolmente forza per lottare.
«Certo, certo... dici bene...»
«Be’ comunque, mi fai veramente un grande favore, devo ammettere. Mi hai proprio levato da un casino. Grazie, figa.»
Rabbia, distruzione, violenza, birra, dolore, fastidio, rabbia, legno, denti, sangue, rabbia, ossa, morte, rabbia, birra, fine, apocalisse, rabbia, rabbia, rabbia. Resto imbambolato per un attimo cercando di bloccare l’istinto. Tanto ormai era troppo tardi. Cosa potevo fare? Balzare al di là della scrivania e lanciarmi dritto alla gola di Damiano per spezzargli il collo e poi lanciarmi all’inseguimento di quella merda di Robotto in giro per la città? La città è grande, non sarei mai riuscito a trovarlo... Troppo poche probabilità di riuscita per questa missione, e poi quel grazie, buttato lì con finta ingenuità e candore alla fine della frase, seguito da quel figa, eccessivamente caricato di disperazione, erano la firma sulla mia condanna a morte. Una volta che il capo ti dice grazie, vuol dire che ha preso la sua decisione segnando ineluttabilmente il tuo destino. Vuol dire che ti hanno legato i polsi con il fil di ferro e più cerchi di liberarti più rischi di farti male. Vuol dire che le tue spalle sono al muro e il tuo culo è già diventato un salotto in cui i problemi si sono messi belli comodi e si stanno scolando un Martini alla faccia tua. Cin cin.
«Be’... sì... sì, certo... nessun problema, ci penso io ai terremotati, sono contento di poter firmare l’evento... Anzi, mi ricordi che devo un favore a Robotto...» sospiro mentre scivolo lungo lo schienale della sedia come se il palloncino di me stesso si stesse lentamente sgonfiando.
«Lo farò Alessandro, lo farò figa. Mi fa piacere che almeno voi due abbiate legato. Mi sembra che gli altri siano un po’ ostili nei suoi confronti, non vorrei che...» probabilmente stava aggiungendo altre frasi al suo discorso, ma in quel momento ho smesso di ascoltarlo e mi sono concentrato soltanto sul fischio isterico nelle mie orecchie. Non c’erano molte vie di uscita. Avrei dovuto restare in ufficio altre quattro ore almeno. Quando riemergo dall’apnea dovuta allo shock, Damiano non è più sulla soglia e spero che almeno il mio subconscio lo abbia salutato educatamente.
Butto un occhio all’orologio digitale da tavolo che segna le 7:46 p.m. Lo riguardo dopo quelli che mi erano sembrati non più di cinque minuti, ma ora i numerini rossi che lampeggiano sul display nero dicono 8:59 p.m. In quel lasso dilatato di tempo avevo visto un paio di video su YouTube, avevo scoperto con somma delusione che la policy del nostro ufficio pubblicitario aveva bloccato l’ingresso a qualunque sito contenente allusioni alla pornografia, ero rimasto intrappolato in uno scambio epistolare con Dery e il suo ormai inseparabile BlackBerry, avevo dilaniato una rivista di motori che avevo trovato sulla scrivania di Robotto appallottolandone le pagine una dopo l’altra per lanciarle, cercando di fare canestro nel cestino dell’immondizia che avevo posizionato nel lato più lontano della stanza. Avevo, insomma, sprecato un’ora del mio tempo. Dovevo darmi una mossa se volevo uscire di lì in tempo almeno per una birretta della buonanotte, solitaria ma meritata, e sentivo il bisogno di riprendere in pugno la situazione. Come prima decisione della serata, stabilisco che è il momento di un pacchetto di taralli e di un caffè della macchinetta automatica. Frugo nella tasca della giacca in cerca di qualche monetina e mi incammino lungo il corridoio bianco fissando la mia ombra, che mi segue fedele, riflessa sul parquet.
Conoscevo una barzelletta, o meglio, un indovinello sulle ombre e su come non ci si riesca mai a liberare di loro, ma non riuscivo a ricordare esattamente come facesse. Qual è quella cosa che ci sta sempre appiccicata... no, no. Di cosa ha paura chi... No, non faceva nemmeno così... Forse aveva a che fare con gli orari. Qual è quella cosa che al mattino ci sta sempre davanti, a mezzogiorno sparisce, e alla sera ci sta sempre dietro? Ecco, era qualcosa di simile. Non proprio così, forse, ma sentivo di essere sulla strada giusta quando la mia ombra artificiale prodotta dai neon sul pavimento lucidato sparisce all’improvviso. Mi ci stavo concentrando con così tanto impegno, che ci rimango quasi male e mi sento abbandonato. Ero piombato in un’oscurità mitigata solo dalla luce della luna che filtrava attraverso le imponenti finestre. Nel giro di pochi secondi, lungo i muri, iniziano a lampeggiare le luci di emergenza balbettando per qualche attimo prima di accendersi completamente. Ora non ero più al buio, ma nemmeno alla luce. Ero avvolto da un’aura talmente strana, tra il verde e il bluastro, che mi sembrava di stare dentro a un film di Tim Burton. Visto il momentaneo calo di corrente elettrica, come prevedibile, l’ascensore non risponde e scendo al piano di sotto utilizzando le scale dietro la porta nera con il maniglione antipanico, dove solitamente i nicotinomani s’incontrano di nascosto per fumarsi furtivamente la loro dose quotidiana di cancro ai polmoni, e raggiungo a memoria la macchinetta automatica. Ovviamente non funziona nemmeno quella. Mi guardo intorno e non riesco a vedere una sola fonte di energia attiva, una spia rossa, un led illuminato, una lucina colorata, niente di niente. Solo il rumore del telefono che mi trilla improvvisamente dalla tasca testimonia che stavo vivendo nel Ventunesimo secolo.
«Hai visto che roba?» mi sento chiedere dalla voce di Dery.
«In realtà in questo momento non vedo proprio un cazzo!» rispondo con uno stupefacente tempo comico.
«Fico, eh?» mi fa lui.
Io non ci trovavo proprio niente di fico, a dir la verità, ma non era questo il punto.
«Ma perché, manca la luce anche da te?» domando incuriosito.
page_no="161" «Da me, nel palazzo di fronte, a casa di Giulia, a casa dei miei... praticamente dappertutto!»
«Cioè un blackout totale?» sbotto con fin troppa enfasi. Devo ammetterlo. Effettivamente, a pensarci bene, è piuttosto fico. Quantomeno è qualcosa da raccontare il giorno dopo.
«Essì! Tutti al buio! Niente energia, niente luci, niente allarmi. Ho idea che svaligeranno un bel po’ di locali stasera... Pensa come se la sta facendo sotto chi ha un negozio... magari di videoregistratori o cose simili...» fa Dery con voce quasi sognante.
«Nessuno usa più il videoregistratore!» considero ad alta voce.
«Non ha importanza, l’occasione fa l’uomo ladro!» mi risponde dimostrando di non aver centrato il punto della mia obiezione. «La gente si ruberebbe pure i vespasiani dagli autogrill se solo ne avesse la possibilità!» Avrei voluto fargli notare che negli autogrill non ci sono più nemmeno i vespasiani, ma a questo punto sarei stato io a non centrare il punto della questione. Chissà, forse Dery pensa di vivere ancora negli anni Ottanta.
«Non immagini nemmeno quante persone non aspettino altro che una tragedia per trarne vantaggio!» tuona con voce severa.
«Oh la Madonna! Non stai un po’ over-reagendo? Una tragedia... è mancata la corrente, niente di grave...» minimizzo.
«Tu o sei scemo, o fai proprio finta di non capire...» mi accusa sconsolato. Non riesco a non scoppiargli a ridere in faccia.
«Ah già... che tu sei quello cospirazionista no? Come con la storia dell’11 Settembre!» gli ricordo ridacchiando. Dery aveva ovviamente una sua teoria anche riguardo l’11 Settembre. Qualche giorno dopo l’attentato voleva convincermi che, approfittando della “confusione”, migliaia e migliaia di persone che quel giorno avrebbero dovuto morire nel crollo delle torri gemelle ma che invece si salvarono perché in ritardo al lavoro, o perché avevano bucato una ruota della macchina nel tragitto verso l’ufficio, o perché erano con l’amante, ne approfittarono per far perdere le loro tracce. Sospettava che molti di quei corpi mai recuperati sotto le macerie in realtà, sotto le macerie, non ci siano mai realmente finiti ma abbiano solo colto la palla al balzo per fuggire da una vita che non li soddisfaceva, dai debiti,
o da una moglie gelosa. Secondo lui, oggi, questi fuggitivi passeggiano tranquillamente tra di noi sotto falsa identità. Tra tutte le sue teorie, probabilmente una delle più affascinanti. Ma resta comunque una minchiata.
«Vedrai, vedrai al telegiornale domani!» mi dice e mi chiude il telefono in faccia proprio quando la luce bianca di una torcia elettrica prima mi illumina e poi mi acceca, puntandomi dritto negli occhi. Le mie pupille si devono essere accartocciate su se stesse come delle palline di carta stagnola per lo sbalzo di luce.
«Ehi, ehi... Cazzo spegnila!» impreco senza sapere contro chi. «Non ci vedo più cazzo!»
«Ops, scusami, scusami...» mi risponde una voce femminile mentre il fascio accecante si abbassa verso il pavimento. Provo a mettere a fuoco la sagoma che mi trovo davanti ma vedo soltanto qualche ombra e una miriade di pallini rossi e neri danzare in un indefinito bagliore giallastro. Mi premo gli indici contro i bulbi degli occhi così forte da sentire dolore, e appena li riapro i pallini rossi e neri hanno un’impennata di vitalità improvvisa ma per fortuna breve, prima di iniziare a scemare del tutto.
«Scusa... è che pensavo di essere rimasta sola a quest’ora, e...» si giustifica la donna davanti a me avanzando di qualche passo. Le terminazioni nervose dei miei occhi sono ancora sotto shock quando il mio cervello assume il controllo della situazione e mi sbalza improvvisamente indietro di vent’anni con la memoria, quando ero piccolo e frugavo in cerca di qualche spicciolo nelle borsette che mia nonna lasciava incustodite a casa dentro l’armadio della sua camera da letto. La chiave di questo ricordo, lo stargate olfattivo che mi ha riportato a quei giorni di vent’anni fa, è senza dubbio l’odore che mi invadeva le narici ogni volta che spalancavo le maestose ante a specchio di quell’armadio e che stavo inalando nuovamente oggi, davanti alla macchinetta automatica del caffè. È l’odore di quei piccoli sacchetti che mia nonna nascondeva tra i vestiti per evitare che le tarme se li divorassero. Il naso aveva decifrato la presenza misteriosa ancora prima che le orecchie ne avessero riconosciuto la voce e che gli occhi fossero tornati a funzionare correttamente. L’odore di naftalina non lasciava spazio a dubbi.
«Natalina?»
«... e comunque, tra tutti quelli che mi aspettavo di trovare in ufficio fuori orario, tu sei una sorpresa!» mi fa notare, confermando l’intuizione.
«Già, sì be’... è una storia lunga... ma cos’è successo? Dicono che la luce sia sparita dappertutto...»
«Sì, è quello che ho sentito anche io...» conferma Nat Nat. «Ero già in ritardo e ci mancava solo questa...» farfuglia tra sé e sé.
«Avevi un appuntamento con qualcuno?» le domando sperando che il tono non sia eccessivamente sarcastico, mentre zompo con un balzo su un tavolino contro cui sono appena andato a sbattere.
«No, nessun appuntamento...» risponde infastidita facendo crollare le mie speranze, «ma devo finire di controllare dei documenti per Damiano...» aggiunge cercando di farmi pesare la sua professionalità. Il suo zelo, effettivamente, mi mette sempre a disagio. Anzi, tutto di lei mi mette a disagio. Nonostante avessimo più o meno la stessa età, Nat era una di quelle persone che non riuscivo a guardare senza chiedermi come sarei stato io da vecchio, e il profilo che riuscivo a immaginare di me stesso non era mai particolarmente confortante. Probabilmente il sarcasmo ostinato con cui mi sono rivolto a lei in anni e anni di conoscenza è sempre stato un riflesso di questo strano senso di inadeguatezza che provavo quando si trovava nei paraggi. Il suo giudizio mi metteva angoscia. A me, che non me ne frega niente di niente e di nessuno.
page_no="164" «E in più dovrei inviarglieli via fax entro mezzanotte, che voleva dargli un’occhiata...» mi informa lasciando la frase in sospeso per qualche secondo prima di continuare «pensa un po’, per dargli un’occhiata... Domani ha una conferenza amministrativa con tutti i capi reparto, e invece di prepararsi a dovere sarà a cena con la moglie ad aspettare...