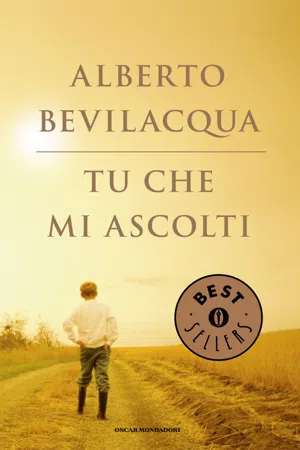![]() PARTE PRIMA
PARTE PRIMA![]()
I
Quando fuggiva da casa, eclissandosi dalla nostra presenza con un’abilità da illusionista, mia madre lasciava sulla propria poltrona uno dei suoi fazzoletti colorati o gli occhiali, un segno della sua intimità, spesso un fiore preso dai mazzi che le portavamo per rallegrarla. Sapevo cosa significava quel fiore, conoscevo il drammatico sarcasmo di quel fiore, messo di traverso e spezzato nel gambo per farci capire che non era colpa sua, ma del male ancora sconosciuto che la possedeva; che perciò dovevamo capirla e perdonarla.
La fuga era dettata da una spinta irrefrenabile: verso la periferia della città, che per lei rappresentava tutte le vite emarginate, negate, e insieme la notte delle “delicate stelle”, come mi canticchiava quando le riusciva di essere madre amorosa accanto a me, con il racconto dei suoi pensieri.
A mio padre era come se cadessero le forze. Restava interdetto, a fissare il vuoto, a fissare il fiore; lo sollevava con due dita, delicatamente, senza capirne il significato; lo annusava, a volte, quasi il suo profumo potesse illuminarlo sulle ragioni che rendevano irragionevole il comportamento di mia madre. Ma il fiore non mandava profumo. Un alito freddo, invece. Lo stesso che avrebbe percepito dalle labbra di lei, se a quelle labbra, nei momenti di crisi, avesse avvicinato le sue.
Toccava a me andarla a cercare.
Mi addentravo fra le sabbie delle discariche, che si stendevano a perdita d’occhio, irte di montagnole, sconfinando nei nuvoloni, dove cielo e terra si confondevano se il vento alzava spirali alte come torri. Mi avventuravo cercando ansiosamente mia madre perché me lo sentivo che soltanto quella distesa desolata poteva aver attratto la stessa desolazione che turbinava dentro di lei, trasformando i suoi miraggi in una terra senza ritorno.
Salivo e scendevo per le piramidi sabbiose, gridando dentro di me, con la sensazione di avere una gola strozzata al posto dello stomaco:
“Fatti trovare!... Fatti trovare!”
Mi ricordavo della sua gioventù, di cui ero stato testimone (mi aveva avuto a diciotto anni). Del suo corpo giovane che sollecitava, nei maschi d’Oltretorrente, cordiali desideri. E di quando le forme di quel corpo avevano preso a manifestare una sorta di pietà verso se stesse: la pietà che si fa autodistruzione, coscienza che la mente, a tratti, può non avere più valore. La sua testa mi appariva da sovrana, lineamenti perfetti, la bocca carnosa. Mi eccitava, fin da bambino, quel rosso di labbra carnose in cui affondavo il dito mentre lei rideva, e lo spingevo fra i denti bianchi, anch’essi perfetti, fino a farlo scivolare lungo la lingua; lei lo lasciava scivolare, tutto fino alla gola, poi stringeva le labbra intorno al dito, e io per istinto lo ritraevo adagio, e lei adagio lo assaporava, socchiudendo gli occhi mentre lo ritraevo, e poi lo affondavo di nuovo, e lei di nuovo lo accoglieva. Come un’amante col sesso di un amante figlio, un amante bambino creato da lei.
Dentro la sua testa, la mente, a tratti, già svaniva in “maturla”. Dalle mie parti, maturla è il vento impetuoso da settentrione, la bora, a cui resistere non è facile, perché soffia pazzie di terra e capricci di cielo.
Come spinta da quel vento, mia madre ballava. Le piaceva molto ballare. Mi avvolgeva tutt’intorno con le spirali del suo ballo-maturla e io, seduto sul pavimento, ero ancora così piccolo da vedere, nel cerchio della sua veste che si alzava volando e mi sfiorava i capelli, il buio da cui ero da poco venuto: due gambe perfette in fondo alle quali, prima della vita, ero stato, per qualche tempo, un presentimento contrastato fino alle lacrime ed esaltato fino al delirio della felicità. Io ero la realtà in cui si era tradotto quel presentimento. E sensazioni assai più grandi di me, mi spingevano a sollevare gli occhi al buio fra le gambe di mia madre, mentre mi arrivava il primo odore di femmina, e lo respiravo. Lei lo capiva.
Per distogliermi, attaccava a canticchiarmi canzoncine o i nomi buffi dei paesi lungo le rive del Po. Mi portava spesso a vederli sfilare da una barca a motore e quando via via me li annunciava mi suonavano da favola, erano una festa per me che li immaginavo come piccoli regni di una magica allegria. Ca’ dei Sogni, Viola del Sorriso, Fraterna Mea, Levante Tripoli, Finale Beltà... Anche nell’inganno del mondo, c’è qualcosa del canto delle sirene, mi avrebbero spiegato più tardi.
... Fra le discariche, mia madre finalmente la ritrovavo. Come il mio sesto senso mi aveva suggerito. In mezzo ai rottami: un mobiletto sfasciato, sedie rotte, un mazzo di fiori finti che spuntava dai sacchetti gonfi di immondizia.
«Perché?» le chiedevo ogni volta.
Restava muta, con un peso di vergogna. Ripetevo la domanda. Lei scrollava la testa. Le costava uno sforzo evidente bisbigliarmi appena:
«Non so. È un qualcosa.»
Si stringeva la fronte, poi lo stomaco con l’altra mano:
«Un qualcosa qui... E qui.»
Soltanto una volta, rincasando, cercò confusamente di spiegarmi che l’amore, quando è il solo che abbiamo, e tanto profondo che sembra sfuggirci, fa brutti scherzi, crea l’angoscia di perderlo, e questa angoscia muta persino la felicità in dolore. Scoppiò a ridere. Un riso come quando si è afferrati per la gola da colpi cattivi di tosse:
«Fa scambiare pero per pomo.»
E già allora avrei dovuto capire che può spingere una madre, che adora i suoi figli e non ha altra ragione per vivere, al terrore assurdo di ucciderli.
Mutamenti si alternavano. Il mondo di mia madre poteva cambiare da un giorno all’altro. Sparivano le ombre, gli allarmi. Per brevi periodi, la casa retrocedeva a una normalità in cui ci si muoveva col fiato sospeso, per timore di spezzarne la fragile trama. Allora i momenti di bellezza, insieme a lei, erano impagabili.
La scoprivo davanti allo specchio. Lei che, nei giorni difficili, ripeteva: «Non riesco nemmeno più a guardarmi allo specchio, che è sempre stato il mio confidente migliore. Mi bastava ballare da sola davanti allo specchio per sentirmi capita, appagata».
Entravo nella sua camera. Mi arrestavo sorpreso. Era là che si sfiorava i tratti del volto come se le fosse riapparsa una persona cara dopo una lunga assenza, e la salutava in silenzio, toccandola per sincerarsi che fosse proprio la persona attesa. Infine la riconosceva, come un cieco legge coi polpastrelli un sentimento comune nelle linee di una fisionomia. Mi diceva, senza girarsi:
«Sto bene. Mai stata meglio.»
Prendeva a truccarsi. Quei piccoli artifici erano le parole di un dialogo che riprendeva, la spingeva a sorridere a se stessa, a ringraziare con gli occhi se stessa per l’avvenuto ritorno. L’emozione di ritrovarsi le faceva tremare le mani. Subito una scintilla fra noi. Provavo di nuovo l’attrazione carnale che ci legava, fatta di immedesimazioni e di fantasie comuni. Tornavo a vivere, in me, il suo corpo che riprendeva colore e forme e i miei sensi lo percepivano come le vibrazioni di un violino che un esecutore invisibile ricominciasse a suonare con maestrìa.
Mia madre era la donna più intelligente che io abbia conosciuto. Eppure, alla parola “intelligenza”, agitava la mano come per cacciare una mosca molesta. Mio padre, anche per rincuorarla, si complimentava per la sua prontezza nel capire le cose del mondo:
«Lo vedi? Lo vedi che la tua testa funziona a meraviglia? E il resto sono ombre, solo ombre ridicole di cui la tua mente può sbarazzarsi come e quando vuole.»
Lei reagiva:
«Chi crede di capire non capisce niente... Io non capisco. Io sento.»
Sentiva subito anche lo stato d’animo con cui l’avevo scoperta seduta allo specchio. Allora finiva di truccarsi in fretta, mi portava via allegramente, non più con risate come colpi di tosse cattiva, ma con le risatine che lei chiamava del “cirlìnn”: la ridarella che ci prende per niente, tanto più se ci va male, quando si è in combriccola...
Me la spiegava trascinandomi sul tram della prima mattina, che dalle parti mie veniva chiamato l’”Allegria”, perché, è vero, ci salivano i disgraziati che andavano al lavoro duro, ammucchiandosi appiccati alle maniglie, ancora intontiti dal sonno, già col peso delle ansie e delle umiliazioni quotidiane. Ma proprio alla faccia di queste inquietudini, c’era sempre uno che veniva afferrato dal cirlìnn, più forte di lui, da questa specie di preghiera mattutina dello spirito beffardo. Subito accadeva come con le ciliegie: il cirlìnn del primo diventava, via via, il cirlìnn degli altri. Così il tram si trascinava per le periferie quella nube di riso, diventando contenitore di un’allegria per disperazione.
Più o meno in questi termini mi spiegava le cose che dovevo imparare a sentire, più che capire.
«Vieni con me, garibaldino. Dobbiamo approfittare di giornate come questa. Per confidarci un po’ fra di noi.»
Quel giorno, oggi, mi sembra un sogno. Confidandosi, lei non mi ha mai trattato da ragazzino. Mi parlava schietto. Senza mezzi termini o imbarazzi per la mia età. Parlava persino con crudezza, quando era il caso, e con complicità, se ne valeva la pena. Forse che un ragazzino che scruta l’universo, le prime volte, non è cosciente di un’emozione? Lo scruta con un’innocenza che un adulto non avrà mai. Così pensava. E a quella forma particolare di innocenza in me si rivolgeva:
«Mi fido di te, garibaldino. Seguimi.»
Le andai dietro, come sempre, senza fare domande, lasciandomi guidare dalla sua cordialità ritrovata. Ci inoltrammo in un lato della casa dove non avevo mai messo piede. Mi faceva strada raccontandomi con un tono da favola, ma calcolato con ironia:
«In questa casa c’è una stanzetta che chiamavamo “della neve”, perché le piane, quando si colmavano di neve, dalla sua piccola finestra apparivano più belle che da qualsiasi altro punto, e il sole veniva su con tinte sul giallo dorato, e le piane bianche si trasformavano in laghi d’oro, e durante le nevicate più grandi c’era sempre un poco di neve che finiva per cadere da una crepa in un angolo, una crepa che mai nessuno si era curato di murare, perché era bello anche questo: veder crollare un po’ di neve, spinta dal vento, nella stanza segreta... Insomma è stato lì che è successo, capisci?»
Si girò a fissarmi e mi strinse il polso, come faceva quando voleva che le sue allusioni si facessero chiare nella mia testa e io rapidamente ne traducessi il senso:
«Hai capito o devo aggiungere pane al pane?»
«Sì, ho capito» le risposi. Ed era vero. Poi la sorpresi precisando:
«Come sempre ripeti tu, diciamo che ho sentito ciò che dovrei capire.»
Ci trovammo nella camera. Scrutandola, dopo tanto tempo, lei si stranì un attimo, presa dal pudore. Notai che persino il sole sembrava filtrare, dalla crepa in alto, con raggi pieni di pudore.
«... Tuo padre, allora, le prime volte che cercava di portarmi a letto, mi chiamava Lisa, Lisetta, col mio secondo nome, e così mi chiamavano in tanti, forse Giuseppina non gli appariva degno di come apparivo, bella, sì, ma anche un po’ misteriosa e coi lineamenti fini, aggraziati, e tuo padre ci aggiungeva una nenia tutta sua, Lisetta, Lisetta, come si fa coi bambini, sai, chissà perché, forse perché voleva farmi sentire più bambina, una preda più facile, ma io avevo già una testa di mille anni per certe faccende, la Lisetta ingenua se n’era scappata via da me, portandosi i suoi candori, e a volte tornava, sì, ma subito qualcosa o qualcuno la faceva scappare di nuovo, io cercavo di trattenerla, inutile, volava via coi suoi bei sogni, le favole, un po’ d’inferno già le scottava sotto i piedi, chi poteva darle torto?
Così tuo padre mi porta in questa stanzetta della neve, ma senza un minimo di poesia per la stanzetta, per la neve, figuriamoci, gli sarebbe andato bene qualunque posto lecito o illecito, borbottò soltanto “tò, ci nevica davvero”, perché crollava giù un po’ di neve da quella crepa, e la nenia di Lisa, Lisetta poteva risparmiarsela: che gli serviva fare come gli altri uomini che ti recitano le mille e una notte per poi godersi una donna una notte e via, amen? E tu ricordati, garibaldino, che sono cose che non si fanno, se tu da grande vorrai una donna diglielo chiaro, che almeno salvi la faccia... Ma lui piagnucolava: “Perché non ci scaldiamo insieme in questo posto che ti piace tanto, e lo so che ti rintani qui quando le tue fantasie ti cascano in testa come questa neve dalle crepe? Dài, scaldiamoci dove nessuno ci vede”.
In realtà, era lui che non voleva farsi vedere, lui che passava per fascista, e queste parti erano più rosse di una cocomera spaccata. Storia lunga, garibaldino, cercherò di spiegartela un pezzo alla volta... Scaldarsi, insisteva. Allora perché era già lì che si toglieva in fretta la giubba da ufficiale aviatore, e buttava il cappello sul mucchietto di neve, quel berretto azzurro che mi piaceva, e un po’ lo confesso mi aveva fatto sognare, che se lo tenesse, messo di traverso sul ciuffo nero lo rendeva anche più bello, uno dei ganzi più ricercati della Parma ricca e boriosa...
Lo lasciavo dire e fare, fissando il cappello dove la neve sfarinava come da una clessidra, e poi fu la volta della rivoltella, via anche quella, non si può fare l’amore con un revolver piantato sulla pancia, non ti pare? Spogliati pure, mi dicevo, bell’ufficiale, però mi piacerebbe di più che ciò che ti furla in testa lo facessi in uniforme, uno sfizio magari, ma mi sorrideva l’idea, e quando una cosa mi piaceva, mi piaceva e basta, ero fatta così da ragazza, e così sono rimasta...
Per farmi intendere, mi chiede se conosco la canzoncina del Rabagliati, e che fa? Si mette a canticchiarla, la canzoncina, “Ba-ba-baciami piccina con la bo-bo-bocca piccolina, dammi tanti tanti baci in quantità”... Ma baci dove, dove vuoi che te li dia i baci, eh, bel Mario aviatore? Per di più ci stonava col ritmo sincopato, aveva piuttosto la voce da baritono da parata, col gagliardetto nero, armi e bagagli, e l’avrei trovato più spiritoso se mi avesse canticchiato, con sincerità, “Giovinezza, giovinezza” aggiungendo, mentre mi metteva le mani dappertutto, che ero “una primavera di bellezza”, perché lo ero, sai, lo ero davvero. Insomma, stavo per andarmene, ma i suoi occhi erano di una dolcezza che non puoi immaginare, per quelle occhiate sono rimasta...
Io, le idee sue, le sapevo maligne, però sapevo anche che erano vanterie di tanti che credevano così di mettere in maschera le loro debolezze, poveri idioti davvero, tant’è che erano proprio le debolezze di tuo padre a farmi innamorare, i suoi vezzi da ragazzino, e certe tenerezze che gli sfuggivano anche quando s’infilava stivaloni e rivoltella, credendo di impressionarmi, e sotto il nero del gagliardetto aveva un candore nel cuore, era buono tuo padre, com’era un gran bel ragazzo che non volava solo con gli aeroplani ma, come si dice, di fiore in fiore, e tutte, ganze o no, gli andavano bene, e ci stavano, e ringraziavano dio di starci, perché la femmina è fatta così...
Stavo lì a guardarmelo che si preparava al corpo a corpo e lo sentivo, lo sentivo una volta di più che, se era fascista, lo era in certe leggerezze dei maschi, per esempio nel non capire che una donna è come un popolo, se vuole starci ci sta, specie se prende una sbandata e io l’avevo presa, non c’è bisogno di canzoncine e di inganni, una donna se vuole starci ci sta anche col nemico, quando capisce che lui è una vittima della vanagloria, e se non vuole starci invece non ci sta, e più uno usa il ricatto delle maniere traverse, più rischia, a cose fatte, di finire impiccato per i piedi...
La sto facendo lunga, garibaldino, perché quel giorno fu il giorno tuo, della tua sorte, come si dice di chi viene a questo mondo, e perché anche a te sia chiaro cosa può essere un uomo sul punto di dare la vita, mentre una donna lo guarda e lo giudica nel sentimento che lui non sa di avere, e quando saprà di averlo sarà troppo tardi.
La sbandata che m’ero presa era di quelle che non perdonano, e tuo padre lo sapeva bene cos’è una sbandata, lo sapeva da aviatore, quando l’aeroplano va giù d’ala, e hai voglia a tirar su la leva, perciò se ne approfittava, e io lo lasciai fare, in questa stanzetta dai muri bianchi che diventò d’oro quando il sole cominciò a calare, e fu tanta meraviglia negli occhi a tradirci, perché anche lui si distrasse a guardarla in quella piccola finestra, è come se li rivedessi ora i suoi occhi che, per un momento, si girarono via da me a fissare il tramonto, stupito come un bambino, e quel momento fu traditore...
Subito dopo io ero qui, esattamente in questo punto, rannic...