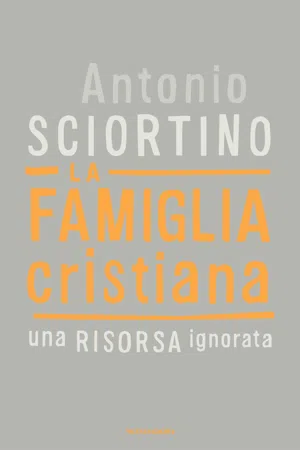![]()
II
Il fantasma della povertà
La Finanziaria e la «parabola dei talenti»
Quel che resta del tesoretto
«Una famiglia deve avere una casa dove abitare, una fabbrica dove lavorare, una scuola dove crescere i figli, un ospedale dove curarsi e una chiesa dove pregare il proprio Dio.» Le parole fulminanti del grande sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, hanno indicato, molti anni fa, quale doveva essere un percorso virtuoso delle politiche familiari. Uno sguardo alla situazione attuale ci dice quanto siamo in ritardo e lontani dall’obiettivo.
Ci sono responsabilità che si possono attribuire alla crisi della cosiddetta «società salariale» e alla crescita abnorme del debito pubblico, uno dei più alti al mondo. Ma le due questioni sono legate a doppio filo. Le scelte per contrastare la crisi hanno aperto, finora, solo qualche piccolo spiraglio. Poca cosa se consideriamo i contributi alle famiglie sotto forma di bonus. Nulla, o quasi, se pensiamo a decisioni strutturali e benefici di lunga durata. Che non ci sono.
La povertà è sempre stata aggirata, mai affrontata direttamente, con vigore. Si sa che la riduzione del debito pubblico è anche un modo per dare soldi alle famiglie. Ma i tempi sono lunghissimi. La povertà delle famiglie, invece, va affrontata subito. Prima che si allarghi a macchia d’olio. Bisogna mettere in fila servizi, asili nido, scuola, part-time, congedi, affitti, case popolari, assegni di sostegno per chi ha più figli, assegni familiari per tutti, reddito minimo di inserimento per i disoccupati, tariffe dei servizi più flessibili (soprattutto, a favore delle famiglie più numerose), fondo per la non autosufficienza dotato di più denaro... E, infine, una discussione, che sia seria e decisiva, sul quoziente familiare.
Il bello è che su questi temi c’è un accordo all’unanimità. Poi, però, arrivano i «mastini» dell’economia, cioè i ministri delle Finanze, e tirano una riga nera su tutto. L’ha fatto Padoa Schioppa col governo Prodi, lo fa adesso, con un certo cinismo, anche Tremonti. E quando nelle pieghe di bilancio si scova qualche «tesoretto», la priorità va sempre al debito pubblico. Alle famiglie solo poche briciole. I «tesoretti» vengono dispersi in mille rivoli, per ingraziarsi tutti. Alla fine, non si accontenta nessuno.
La prima vittima è la stessa Costituzione italiana, che riconosce alla famiglia un «plusvalore». Ma la politica non sa tradurlo in termini di risorse e di riconoscimento giuridico e fiscale. Né vale appellarsi all’Unione europea. Che, in questo ambito, non può far pressione sugli Stati membri. Non ha una competenza specifica sulla protezione della famiglia.
Questioni ideologiche e polemiche varie hanno impedito di valorizzare la famiglia come «cellula fondamentale» della società. L’Unione europea legifera a dismisura su tutto, impone agli Stati membri di armonizzarsi alle direttive: dai trasporti alla proprietà intellettuale, dai brevetti sui carciofi e i broccoli alle politiche sanitarie (per non parlare dell’imposizione della pillola abortiva). È strano che sulla famiglia abbia alzato bandiera bianca. Ogni Stato si arrangi da sé.
Il Comitato economico e sociale europeo aveva adottato un tentativo di piano comune per gli Stati membri, con misure concrete a favore della famiglia. E mettendo a disposizione le risorse adeguate. Era stata siglata anche un’«Alleanza per la famiglia europea», ma poi tutto venne affidato alla buona volontà dei singoli Paesi, nonostante l’indicazione dei cosiddetti «obiettivi di Lisbona», una sorta di «carta di protezione sociale» da spalmare sull’Unione.
L’idea che stava alla base era semplice ed efficace: «È meglio prevenire che poi curare con grande dispendio di risorse». In realtà, la maggior parte dei sistemi di protezione europei (e sicuramente quello italiano, tra i più arretrati) non sono costituiti per prevenire i disastri, ma per compensare le conseguenze. Così si sottovaluta l’importanza del capitale umano. Alla famiglia non viene riconosciuto un ruolo in sé, contano solo gli individui che la compongono. E le politiche fiscali italiane si adattano a questo principio, ignorando il quoziente familiare (o formule simili, tipo la «no tax area familiare»), che sarebbe una rivoluzione salutare per le famiglie.
Se si analizzano i trasferimenti monetari e le misure fiscali a favore delle famiglie, l’Italia si piazza al quartultimo posto tra i Paesi dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Molto indietro rispetto a Germania, Francia e Regno Unito. Se entriamo nel dettaglio, i Paesi scandinavi dedicano lo 0,6 per cento del pil solo ai congedi parentali, percentuale che in Italia è talmente bassa da essere irrilevante nella relativa classifica.
Il bluff della fantasia creativa
Dieci anni fa il «Rapporto sulla povertà» della commissione Onofri (l’ultimo grande studio pubblico effettuato in Italia) segnalava una forte differenza tra il nostro Paese e il resto d’Europa riguardo alla spesa sociale per combattere la povertà. Oggi, siamo peggiorati. Abbiamo a che fare con nuovi fenomeni, allora impensabili.
Il primo (il più tragico) è che il lavoro non protegge più dalla povertà. Dalla precarietà si scivola, facilmente, verso la povertà. Il 27 per cento dei lavoratori dipendenti al Sud è sulla soglia della povertà. Si arrabatta con quei 1000 euro al mese, che l’Istat giudica insufficienti per evitare la fila alle mense della Caritas. Eppure, dieci anni fa, la commissione Onofri questi rischi li aveva previsti. Ma la politica è rimasta sorda, come al solito. La povertà non ha colore, non è di destra né di sinistra, semplicemente è la «grande questione» del Paese, riguarda milioni di cittadini e di famiglie.
La distanza tra chi sta bene e chi sta male si sta allargando sempre di più. A differenza del dopoguerra, si guarda al futuro con minore speranza di poter migliorare la propria condizione di vita, il reddito e lo status sociale. Speranza che è andata via via assottigliandosi, fino quasi a sparire in questi ultimi vent’anni. Il cosiddetto «lavoro flessibile» s’è trasformato in «precariato senza futuro», facendo schizzare in alto il rischio di finire, inesorabilmente, in povertà.
Una situazione che non si può affrontare con la fantasia creativa tipica del ministro Giulio Tremonti, con colpi di genio e a effetto, come la social card. Certo, per i poveri è sempre meglio che niente, ma non è una soluzione, abbiamo fatto la «carità di Stato», e basta. Mai, però, che si metta seriamente mano a un piano strutturale e permanente. Non c’è mai stata in Italia una vera lotta alla povertà. Con Grecia e Ungheria siamo tra i pochi Paesi in Europa a non avere misure basilari di intervento, come il reddito minimo di inserimento.
Altri Paesi europei hanno reagito meglio, garantendo, appunto, un reddito minimo. La Francia lo fa da vent’anni, con un provvedimento che lo Stato finanzia con un prelievo addizionale dell’1,1 per cento sui redditi da capitale. In Gran Bretagna e nei Paesi Bassi si è provveduto a proteggere il reddito delle classi più a rischio coniugando la flessibilità del lavoro con la sicurezza sociale dei lavoratori. Da noi, politici e industriali hanno dimenticato questa protezione per il lavoro flessibile, che pur era prevista nella «legge Biagi».
Si è deciso che la legge deve badare al massimo dell’efficienza economica, dimenticando ogni protezione sociale del lavoro e dei lavoratori. Il criterio di efficacia ha il sopravvento sulla giustizia.
Rispetto alla spesa sociale, è sbagliato il dilemma che i politici si pongono ogni anno. Se, cioè, la Legge finanziaria debba assegnare più soldi alle famiglie, agli anziani o all’infanzia, oppure a una maggior offerta di servizi. Sarebbe più importante chiedersi prima quali risultati si vogliono ottenere. E come far fruttare al meglio la spesa, proprio come si legge nel Vangelo nella «parabola dei talenti». Il talento deve essere restituito al suo valore nominale o va fatto fruttare perché renda dieci o cento volte tanto, a favore del bene comune? Finora, la spesa sociale non ha portato miglioramenti. Ci siamo comportati come il servo malvagio della parabola, rimproverato dal padrone perché non aveva trafficato e fatto fruttare il suo talento.
Verso il tunnel della povertà
I dati dell’Istat sulla povertà sono preoccupanti. Negli ultimi due anni, l’11,1 per cento delle famiglie italiane che vivevano in condizioni di «povertà relativa», cioè con meno di 1000 euro al mese, è rimasto nella stessa situazione di indigenza. Ma l’Italia ha una delle percentuali più alte di popolazione «a rischio povertà», dato che questa perdura da dieci anni, senza alcun miglioramento. È la dimostrazione più evidente che la spesa sociale non ha portato alcun cambiamento, e che quei soldi sono stati spesi male, non sono stati fatti fruttare.
Rispetto al resto dell’Europa, c’è un altro paradosso, tutto italiano. Le famiglie con più figli si infilano, direttamente, nel tunnel della povertà, da cui difficilmente si tireranno fuori. L’Italia sembra volere fargliela pagare cara a quei genitori che fanno più figli. Oltre a punire questi loro ragazzi che, nella vita, nel lavoro e nella società, avranno meno opportunità dei loro coetanei figli unici.
30 famiglie su 100 con 3 figli sono povere (al Sud l’incidenza sfiora il 49 per cento). È facile l’equazione: più figli si fanno, più poveri si diventa. Esattamente l’opposto di quanto avviene in Norvegia, dove avere più bambini corrisponde a un tasso di povertà più basso.
Per definire la «soglia di povertà», le ultime indagini si rifanno al criterio della «capacità di spesa». Metodo di analisi senz’altro migliore che rifarsi al «livello di reddito», che permette di smentire qualche luogo comune.
Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per distribuire una manciata d’ottimismo agli italiani, ma soprattutto per smentire i soliti giornali catastrofistici, ci ha dato la fotografia esatta della povertà delle famiglie italiane. Ci ha spiegato che lui, tutte queste famiglie così povere, proprio non riusciva a vederle. Tale convinzione gli veniva da ciò che osservava dal suo salone affacciato sul mare di Porto Rotondo. Da lì, ha assistito all’aumento, anno dopo anno, di barche alla fonda. Barche e non gozzi da pescatori. Da quella visione, forse, si è convinto che la povertà era solo una favola, perché le famiglie avevano soldi da spendere, stipendi da capogiro e ricchezze senza uguali in Europa. Tanto da permettersi tutto quel ben di Dio sul mare.
Il presidente può avere ragione, ma il ragionamento va fatto fino in fondo, guardando anche oltre l’orizzonte della baia. Può accadere (in Italia, purtroppo è stato così) che l’aumento della «povertà relativa» dipenda dal miglioramento delle condizioni di vita medie. Se i benestanti incrementano sensibilmente ricchezza e tenore di vita, chi resta indietro diventa più povero di prima. Il divario tra ricchi e poveri si allarga, più che restringersi.
In Italia 7,5 milioni di persone hanno vite troppo fragili, che facilmente si spezzano. Nella stessa condizione ci sono 2,6 milioni di famiglie. Si attestano su un livello di spesa appena sotto i 1000 euro. Ma un altro 3,6 per cento delle famiglie è lì vicino, sta sopra quella cifra per pochissimi euro, basta un nulla per affogare. Più della metà delle famiglie povere è concentrata al Sud, dove vive tuttavia solo il 32 per cento della popolazione italiana. Sempre al Sud, un lavoro fisso non basta per evitare di finire tra i poveri.
La «povertà relativa» aumenta dappertutto. La protezione sociale non ha seriamente salvaguardato i poveri, né c’è equità nella distribuzione del reddito: troppo concentrato al vertice, troppo diluito alla base. In Italia l’irrilevanza della spesa sociale si nota subito se consideriamo il tasso di povertà dopo l’intervento pubblico: in media in Europa si riduce di 10 punti, in Norvegia scende di 19 punti, in Svezia di 17, in Germania di 14 punti, in Francia di 12 e in Olanda di 11. In Italia abbatte di soli 4 punti la quantità di popolazione povera. Segno che la nostra spesa sociale è inefficiente e inefficace, oltre a non essere alta. Rimane sotto la media europea sia in termini di percentuale sul pil, sia in termini di spesa pro capite.
Anche se, in realtà, la spesa sociale è cresciuta negli ultimi anni. Ma solo perché è aumentata quella previdenziale. E visto che siamo un Paese che invecchia a ritmi sostenuti, è destinata a salire ancora. La spesa per le pensioni incide per il 15,8 per cento, mentre la spesa sanitaria per il 6,2 e quella per l’assistenza sociale appena per l’1,9 per cento. Nel 2007 i primi due valori sono aumentati, l’ultimo è rimasto uguale.
Obolo di Stato: la montagna ha partorito il topolino
I «Rapporti sulla povertà in Italia», pubblicati ogni anno dalla Caritas con la Fondazione Zancan, ci raccontano un Paese sempre più in ginocchio e politiche economiche sempre meno efficaci. Già nell’ottobre 2007 il rapporto spiegava che è arrivato il tempo di mettere mano all’efficacia della spesa, passando dai trasferimenti monetari ai servizi e alla gestione decentrata della spesa. Con Finanziarie approvate in nove minuti e mezzo, il governo ha fatto esattamente l’opposto. Riserva pochi spiccioli alle famiglie. I soldi non si buttano mai via, ci sono però «modi meno disgustosi di darli», come ha detto Pier Luigi Bersani, ex ministro ombra del Partito democratico.
Dopo i solenni proclami, la montagna ha partorito un topolino. Siamo all’obolo di Stato. «Misura debole» l’ha definita Pier Ferdinando Casini. «Vuole accontentare tutti, senza riuscirci.» Demagogia, più che l’inizio di una politica familiare seria. Servirà a poco, non farà ripartire i consumi, né ridurrà quella fascia di famiglie che non arriva a metà mese. La borsa si è allargata, invece, per le banche e i loro affari. Per la difesa dei risparmiatori, s’è detto. Ma è solo un alibi. Le famiglie, oggi, non hanno più nulla da risparmiare. Per vivere si indebitano. E c’è chi la spesa la fa tra gli avanzi dei mercati o rovistando nei cassonetti dell’immondizia.
L’elemosina di Stato non modifica d’una virgola la distribuzione del reddito, non lo sostiene, non crea nuovi posti di lavoro. Ancora una volta, il governo s’è indirizzato sulla linea del bonus e dell’«una tantum», cioè semplici trasferimenti monetari, che non modificheranno di un millimetro la «povertà relativa». Ci voleva più coraggio a sostegno delle famiglie, sempre più le «cenerentole d’Italia».
Il bonus fiscale di Tremonti e Sacconi finisce, per l’82 per cento, nella tasche dei single (unica categoria protetta del Paese) e di coppie senza figli. Alla fine del 2009, più di tutti, saranno i nuclei familiari con figli che rischieranno di subire i pesanti contraccolpi della recessione, con perdite rilevanti di posti di lavoro. E anche di molto lavoro precario e flessibile.
È una scelta che va contro la famiglia, di cui anche l’attuale governo ignora il grido d’aiuto. Il denaro finisce a chi potrebbe cavarsela meglio non avendo carichi familiari da sostenere, mentre non arriva a chi, nonostante tutto, continua ad aiutare la comunità allevando figli. Non si può definire «bonus famiglia» un provvedimento che porta soldi (pochi per la verità) nelle tasche solo del 18 per cento di chi ha figli a carico. Rischiamo di aprire una guerra tra poveri. Ma così va il Paese.
Oltre alla stortura del bonus dato «una tantum», vi è anche quella dei «parametri di accesso». Il governo ha fatto calcoli del tutto sbagliati, che finiscono per punire sempre le famiglie, soprattutto quelle con più figli. Il Forum delle associazioni familiari ha proposto, senza successo, suggerimenti e modifiche. Purtroppo, la politica del bonus non cambia. Una vera beffa, nonostante un emendamento proposto dal Forum fosse sostenuto da un folto e trasversale gruppo di parlamentari. «Un provvedimento nato per aiutare le famiglie» denuncia Paola Soave, vicepresidente del Forum, «che aiuta, invece, più i single e le coppie senza figli. Chiedevamo soltanto di modulare i tetti dei redditi per superare questa evidente stortura, senza alcuna maggiore spesa per lo Stato. In cambio solo l’ennesima, vaga promessa di aumentare gli assegni familiari usando il fondo di garanzia per i mutui che, probabilmente, non sarà utilizzato. Una doppia beffa che, ancora una volta, richiede alle famiglie italiane un esercizio di pazienza.» Ancora una volta, si nota l’assenza di un approccio strutturale, siamo sempre alla politica dell’emergenza, e in modo pasticciato. Le famiglie, per poter accedere ai benefici, devono essere in miseria. Mentre non viene considerata, in alcun modo, la «povertà relativa».
Nel caso dei bonus «una tantum», poi, l’obiettivo è del tutto oscuro. Denota carenza di innovazione nel campo delle politiche efficaci a favore delle famiglie, che non risultano incisive. Un indicatore per capire come si dovrebbe fare è quello che misura l’incidenza del costo dell’assistenza domiciliare sul totale della spesa sanitaria regionale. In altre parole, bisognerebbe trovare il modo di dare attuazione pratica all’idea di una vicinanza maggiore ai problemi delle famiglie, sviluppando una collaborazione crescente tra l’uso di risorse pubbliche e il cosiddetto «terzo settore» (quel volontariato sociale che è ormai diventato impresa), sviluppando una capacità di spesa maggiore e di efficacia della stessa.
Anche sui tentativi di eliminare la povertà infantile siamo molto indietro. Eppure, si tratta di una priorità indicata dall’Europa. Ma in Italia non abbiamo nemmeno cifre certe sull’entità del fenomeno. Si deve lavorare per riflesso, prendendo il dato della disoccupazione femminile di lunga durata, e ritenendo che, come dice l’Unicef, un’ampia disoccupazione femminile sia indice di mancanza di servizi di supporto alla famiglia.
Un altro dato è l’indice di mortalità infantile. Potrebbero sembrare ragionamenti da Terzo Mondo, ma l’Italia, Paese tra i più industrializzati al mondo, nel 2007 all’ottavo posto per spesa militare e al sesto per le esportazioni di armi, con una spesa per queste ultime di 568 dollari pro capite (più della Germania), sconta nelle regioni del Sud la più alta mortalità infantile dell’Unione europea. Anche rispetto a Paesi di recente ingresso come Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, che pure hanno livelli socioeconomici peggiori dei nostri. Nel Sud Italia la mortalità infantile arriva al 5,6 per mille, con una disparità vergognosa rispetto al Nord, dove il dato si f...