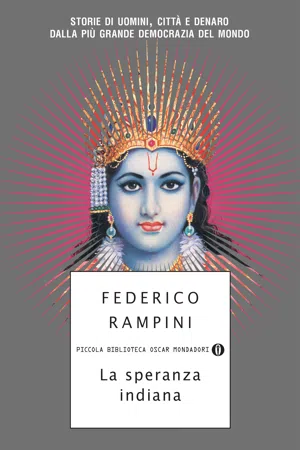Per duemila anni l’idea di Oriente è stata estranea agli orientali. Per i cinesi il loro paese si è sempre chiamato Zhong Guo, cioè la terra di mezzo, l’impero al centro del mondo. Fuori c’erano i barbari, le periferie della civiltà. Vista da Pechino e da Delhi anche l’Asia è un’astrazione geografica, povera di significato storico, politico, culturale: associa la Cina con il Libano, unisce arbitrariamente gli indiani ai giapponesi. Edward Said nel 1978 scriveva: «L’Oriente era un’invenzione dell’Occidente sin dall’antichità». Said coniò il termine «orientalismo» per descrivere un misto di attrazione-repulsione verso il mistero e l’esotico, una miscela di spaesamento e proiezioni fantastiche, di stereotipi e pregiudizi imperialisti. Si riferiva soprattutto alla nostra visione del vicino Oriente islamico. Ma l’invenzione dell’Oriente si è proiettata ben più in là, ha avuto il suo culmine nel nostro rapporto con l’India e la Cina, ha voluto individuare in loro culture irriducibilmente diverse, l’Altro da noi. Elaborata dai più grandi pensatori europei, la maggior parte dei quali non misero mai piede fuori dal nostro continente, questa immagine favolosa e parziale dell’Oriente è diventata indispensabile soprattutto per definire la nostra identità, quello che vorremmo o crediamo di essere.
Il precursore di tale invenzione è il padre di tutti gli storici, Erodoto, che nelle sue cronache di guerra fra greci e persiani costruisce l’archetipo dello «scontro di civiltà». Fin dagli albori il conflitto Est-Ovest diventa un confronto tra valori, modelli di società, sistemi politici: la vittoria finale dei greci è il trionfo delle democrazie contro la forza bruta della massa di soldati-schiavi agli ordini di imperatori feroci. L’Oriente è tirannide, l’Occidente è libertà. Ecco creato l’archetipo indistruttibile. Due millenni dopo, bombardati come siamo da nuove informazioni su quei mondi, senza accorgercene, continuiamo a vedere la differenza tra «noi» e «loro» attraverso il filtro di quella lente. Nei secoli l’idea di Erodoto si è sedimentata, ha sviluppato tutta la sua potenza, applicandosi a terre molto più lontane dell’Asia Minore persiana.
Nella costruzione del mito d’Oriente nell’era moderna hanno avuto un ruolo chiave due italiani, tra i pochi, ai loro tempi, a poter vantare una conoscenza diretta dell’Asia. Il primo è Marco Polo, alla fine del Duecento. La sua personale «invenzione del Catai» – una Cina fantastica ricostruita nel Milione attraverso precisi ricordi di viaggi personali, mescolati con leggende e miti – ha un ruolo essenziale nell’eccitare gli appetiti economici dell’Europa, lanciando navigatori e mercanti alla ricerca delle ricchezze di un Estremo Oriente sviluppato e raffinato. Il secondo è il gesuita Matteo Ricci che visse in Cina nel Cinquecento e tentò vanamente di evangelizzarla. Ricci è il primo sinologo, il tramite essenziale per far conoscere la cultura cinese agli europei. È decisiva la sua scelta di campo a favore di Confucio (nel suo pensiero vede un’etica compatibile con quella di matrice greco-giudaico-cristiana), contro il buddhismo che dipinge come un misticismo irrazionale e superstizioso.
Proprio mentre gli imperi europei si espandono conquistando terre sempre più lontane, nel contatto con queste civiltà si afferma l’idea occidentale che i grandi popoli con i loro sistemi di valori, religioni, lingue, culture, rappresentino organismi ben distinti, separati da confini storici precisi, a volte condannati all’incomunicabilità. Nel Settecento Montesquieu lancia il concetto di «dispotismo orientale» che sarà usato indiscriminatamente per unire realtà politiche tanto diverse come le dinastie imperiali cinesi, i khanati di origine mongola, i Moghul in India, i califfati del mondo islamico ottomano, più tardi perfino lo zarismo russo. Oriente e dispotismo diventano sinonimi per l’Europa, ignorando che l’India è stata nel 1600 un laboratorio politico di tolleranza e dialogo fra le religioni, proprio mentre a Roma la Santa Inquisizione condannava al rogo per eresia Giordano Bruno. Il massimo teorico della superiorità europea è il filosofo tedesco Hegel: riprende l’idea che l’Occidente è la culla della libertà, vi aggiunge che è la patria della scienza e della tecnologia, del razionalismo e dell’individualismo creativo. Per Hegel la civiltà occidentale non è una fra le tante: è l’unica a poter capire e «includere» le altre nella sua sintesi; è la sola a svolgere una missione universale. Nella filosofia della storia hegeliana lo spirito del mondo abbandona l’Oriente immobile e passivo, si sposta verso l’Occidente che è motore di progresso. La modernità siamo noi, cinesi e indiani sono condannati al declino perché prigionieri della tradizione. La colonizzazione inglese dell’India per Hegel (che in India non è mai stato) è inevitabile e positiva.
Nel mondo reale la grande discriminante affermata da Montesquieu e da Hegel ha successo. L’Inghilterra vittoriana si impadronisce dell’idea di una missione civilizzatrice e la traduce in un complesso di superiorità verso le altre razze. Il «dispotismo orientale» è riscoperto e aggiornato di continuo: piace a Karl Marx, a Max Weber che descrive India e Cina come Stati «idraulico-burocratici», a Karl Wittfogel. Ernst Jünger e Carl Schmitt nel 1953 nel saggio Il nodo di Gordio arrivano a dipingere perfino Hitler come un mostro alieno dalla nostra cultura, il nazismo come una «incursione dell’Asia dentro l’Europa». Per loro nella contrapposizione tra Est e Ovest la geografia diventa una metafora degli atteggiamenti umani: l’Asia «massa terrestre» coltiva l’arcano, la magia e la sacralità del potere; l’Occidente circondato da oceani ha per valori la mobilità, la circolazione delle idee, il potere limitato dalla ragione e dal diritto.
Il buddhismo indiano ispira una diversa forma di «orientalismo». Nasce fra i romantici tedeschi Herder, Goethe, Schelling, Schopenhauer. Condividono l’idea che bisogna cercare in Asia «la sorgente primaria di tutte le idee» (Schlegel), si staccano dalla «ragione» di Voltaire perché quel che li attira dell’Oriente è lo stereotipo opposto: l’irrazionalismo, il misticismo indiano. I romantici prendono le distanze dall’infatuazione europea per il progresso, la scienza, la tecnica, lo sviluppo economico. L’India spiritualista diventa l’anti-Occidente per eccellenza. Il compositore Richard Wagner attraversa una fase buddhista in rivolta contro i «dogmi limitati e meschini» della tradizione europea. Per Nietzsche il bello del buddhismo è l’assenza del ripugnante senso di colpa cristiano. Quest’altro Oriente immaginario impregna la nostra cultura fino a oggi. Ispira lo psicanalista Carl Gustav Jung che trova nel taoismo una capacità unica di sintonizzarsi con la nostra «esperienza interiore», di scavare nella dimensione nascosta della nostra psiche, di superare la contrapposizione fra la materia e lo spirito. Lo psicanalista svizzero è un capostipiùte della re-invenzione dell’Oriente che attraversa la cultura del Novecento: il Siddharta di Hermann Hesse diventa la lettura obbligata per l’educazione spirituale di intere generazioni, il rito iniziatico del pellegrinaggio in India unisce i poeti della Beat Generation, la New Age californiana, i Beatles. Più entrano in crisi le nostre certezze sul progresso e sulla razionalità, più l’Occidente affonda nell’insicurezza e nel vuoto di valori, più si convince che la vera saggezza va cercata sulle rive del Gange o sui monti del Tibet.
Alla lunga la nostra immagine dell’Oriente ha finito per proiettarsi sull’idea che le nazioni asiatiche hanno di se stesse. Sotto choc per la decadenza della dinastia Qing, aggredita dalle potenze imperialiste, alla fine del XIX secolo, una élite cinese si adegua a pensare la storia come una «gara» Oriente-Occidente. Nel passato più antico la Cina aveva subito sconfitte militari e invasioni solo da popoli che avevano finito per lasciarsi sinizzare, come i mongoli di Gengis Khan. Dall’Ottocento per la prima volta il confronto è con civiltà che si affermano superiori, vogliono imporre i loro modelli alla Cina. Per quelle classi dirigenti cinesi che si ribellano al declino, Occidente è sinonimo di rivoluzione industriale, nuove tecnologie, modernità economica. Anche in India lo choc della colonizzazione imprime stereotipi e semplificazioni europee. Nell’Ottocento il filosofo induista Vivekananda condanna il «materialismo occidentale», riecheggiando i romantici tedeschi. La realtà è più complicata, naturalmente: varie forme di protocapitalismo sono fiorite nel mondo confuciano secoli prima che Max Weber ne attribuisse il merito all’etica protestante; e una visita agli affollati templi indiani nei giorni degli esami universitari è rivelatrice dell’utilitarismo che si nasconde a volte dietro la religiosità orientale.
Un veneziano alla corte dei Moghul
«Non ero ancora adulto e già mi divorava il desiderio più ardente di vedere il mondo. Nonostante il rifiuto ostinato di mio padre lasciai Venezia, la culla della mia tenera infanzia, e presi la decisione di navigare. Seppi che una tartana stava per salpare, sa il diavolo per dove, e m’imbarcai. Era il 1653 e avevo quattordici anni.» Così inizia la Storia do Mogor di Niccolò Manucci, il veneziano che visse alla corte dei Moghul e raccontò al mondo l’India del XVII secolo. Un’autobiografia avventurosa, quasi un romanzo picaresco, fin dalle prime pagine. Passeggero clandestino per Smirne, il quattordicenne viene scoperto dal comandante che vuole gettarlo in mare. Lo salva l’intervento di un finto mercante inglese che si rivelerà essere Lord Bellomont, ambasciatore segreto del futuro Carlo II d’Inghilterra presso i sovrani indiani. È con il suo protettore britannico che il Manucci arriva nell’impero Moghul dove se la sbroglia in tutti i mestieri: s’improvvisa artigliere, si spaccia per farmacista e medico, diventa confidente delle dame dell’harem, diplomatico e spia al servizio di tutti i potenti di turno, indiani o portoghesi, inglesi o francesi. Sempre in bilico, come un trapezista, tra la gloria e la morte, Manucci scampa ad agguati, trappole ed esecuzioni. Sfugge alla Santa Inquisizione travestito da carmelitano. Ruba agli odiati gesuiti il segreto di un afrodisiaco. Per i servigi resi alla corona viene insignito del titolo di Maestro e Cavaliere dell’Ordine di Santiago dal re del Portogallo. Sposa una ricca vedova inglese e infine dedica la vecchiaia a scrivere le sue memorie a Pondicherry, colonia francese in India, dove muore nel 1717 all’età di 79 anni.
Per la ricchezza e l’originalità dei suoi resoconti sull’India, Manucci meriterebbe di essere celebre e studiato quasi quanto il suo concittadino Marco Polo lo è sulla Cina e l’Estremo Oriente. Invece la Storia do Mogor non ha avuto una fortuna neppure lontanamente paragonabile a quella del Milione. Una ragione va cercata negli incidenti «politici» che perseguitano il suo testo. Il primo manoscritto nel 1698 finisce nelle mani di un gesuita francese del collegio di Clermont, François Catrou, che censura l’autobiografia tagliando senza pietà le pagine più scomode, e intercalandovi commenti faziosi contro il paganesimo induista. Manucci ne riscrive una seconda versione tra il 1705 e il 1713, affidata poi a un frate cappuccino perché la porti a Venezia. Questa cronistoria troppo sincera dell’India seicentesca rischia i fulmini della Chiesa; la censura veneziana ne vieta la diffusione. Il manoscritto originale sonnecchia per due secoli nascosto nella Biblioteca Marciana. A riscoprirlo cent’anni fa non sono gli italiani ma un funzionario coloniale del Raj britannico in India, William Irvine, biografo dell’imperatore Aurangzeb e appassionato cultore della civiltà Moghul. Irvine dedica un decennio della sua vita a studiare i testi di Manucci e nel 1907 pubblica la fortunata traduzione inglese della Storia do Mogor. Finalmente molti capiscono il valore di quell’opera: se ne innamora fra gli altri lo scrittore Blaise Cendrars i cui elogi figurano sul frontespizio della moderna traduzione francese, Un Vénitien chez les Moghols, finalmente ripulita delle manomissioni di Catrou.
Molte notizie e descrizioni di Manucci intanto sono state saccheggiate da altri autori del suo tempo, come i famosi viaggiatori transalpini François Bernier e Jean-Baptiste Tavernier (Manucci scriveva mescolando veneziano, portoghese e francese). L’Europa del Seicento e del Settecento è avida di descrizioni dell’Oriente, il «viaggio in India» si afferma come un genere letterario di successo. Si moltiplicano le testimonianze dirette, agli europei si apre finalmente la possibilità di rivedere gli stereotipi sull’India che erano rimasti fermi alle descrizioni favolose dell’antichità greco-romana: gli spezzoni di ricordi lasciati dalla campagna asiatica di Alessandro Magno, la missione dell’ambasciatore greco Megastene alla corte dell’imperatore Chandragupta Maurya nel 300 avanti Cristo; le leggende riportate da Erodoto e Senofonte o dal latino Plinio, secondo il quale l’India copriva un terzo dell’intera superficie terrestre. I filosofi dell’Illuminismo come Voltaire, critici verso il cristianesimo, sono ben disposti nei confronti dell’Oriente. Fino a quando gli inglesi non diventano i padroni dell’India (cioè fino alla conquista del Bengala nel 1765) non c’è un interesse coloniale a dipingere la civiltà indiana come inferiore e bisognosa di essere «salvata» dall’uomo bianco. Sono all’opera però tanti pregiudizi razziali e religiosi, che danno per esempio alle cronache indiane di Bernier un carattere decisamente eurocentrico. È proprio di questi vizi ideologici che è libero invece il Manucci. Figlio di un droghiere (forse marrano, cioè ebreo convertito al cattolicesimo), cresciuto annusando le spezie orientali nella bottega paterna, abituato a incrociare fin da bambino mercanti di ogni colore venuti a Venezia da lande esotiche, Niccolò ha una vocazione per il nomadismo, oltre che un talento speciale di intermediario fra popoli e culture diverse. Durante il viaggio da Smirne all’India impara il turco e il persiano, appena arrivato in India si applica al sanscrito e comincia a studiare gli annali di corte dei Moghul. È il 1656, regna ancora Shah Jahan e la sua corte è cosmopolita, aperta sul mondo. Lavorano al suo servizio molti europei esperti di armi e di medicina: perciò Manucci lascia credere di essere anch’egli un maestro in quelle discipline. La fama di artigliere gli vale il privilegio di partecipare in prima fila ad alcune grandiose battaglie di successione, nel lungo conflitto fratricida che oppone i successori al trono di Shah Jahan. Le sue descrizioni dell’esercito indiano in marcia sono memorabili. «Sembrava un mare che copriva la terra. Il principe Dara, al centro del suo squadrone, evocava una torre di cristallo, splendente come il sole a mezzogiorno. Attorno a lui cavalcavano molti squadroni di cavalieri rajput le cui armature scintillanti si vedevano da lontano, con le punte delle lance che muovendosi sprizzavano lampi di luce. Altri squadroni di cavalleria erano armati di giavellotti e preceduti da feroci elefanti in corazze di metallo brillante, con le proboscidi cariche di catene e le zanne incrostate d’oro e d’argento. Era una gran meraviglia quel corteo che passava dalle cime alle vallate come le onde di un mare in tempesta.»
Quando viene convocato per la prima volta d’urgenza al capezzale di un alto dignitario malato, Manucci non si fa scrupolo della propria ignoranza. «Ascoltavo solo il mio desiderio d’introdurmi nelle loro case e di scoprire i loro costumi.» Spronato dalla curiosità, il veneziano è assistito anche da una buona memoria: da figlio di speziale ha visto preparare nella bottega veneziana erbe medicinali, estratti e pozioni curative. «Ricordai di aver visto somministrare lavaggi a base di malva, indivia e altre erbe, con l’aggiunta di un pizzico di zucchero bruno, sale, olio d’oliva e canna fistola.» Comincia la sua lunga carriera di guaritore, in cui sembra non faccia peggior figura di tanti suoi colleghi dell’epoca. Nel dubbio, ricorre sempre con generosità alle due «terapie» più diffuse in Europa a quel tempo: il salasso e il clistere. Non c’è paziente a cui Manucci risparmi il taglietto di bisturi per alleggerirlo di un po’ di sangue, che secondo la dottrina di allora conteneva gli «umori» della malattia.
La fama di guaritore conquista a Manucci un privilegio riservato a pochissimi maschi bianchi: l’accesso, sia pure regolato da limiti e precauzioni, agli harem nobiliari. Le sue testimonianze diventano una lettura prelibata per gli europei, ghiotti di informazioni sulla condizione della donna in India. Nell’Europa del Seicento imperversa la cosiddetta querelle des femmes, una controversia etico-filosofica sul carattere della donna: virtuosa o viziosa per indole, naturalmente casta oppure depravata e insaziabile di piacere sessuale? Le fantasie sulla femmina orientale, la curiosità morbosa eccitata dai misteri dei serragli, si innestano su quel clima. Manucci offre al voyeurismo dei suoi contemporanei nuovi dettagli inediti. «Quando applicavo il salasso alla sposa del re» scrive «ella allungava il braccio attraverso una tendina. La pelle era tutta avvolta nella seta salvo una piccola zona lasciata nuda, vicino alla vena. Ogni mese principesse e dame si lasciavano curare da me nel modo che ho descritto.» Per verificare che il medico veneziano non sia un pericolo per le donne, il sovrano lo sottopone più volte a tentazione. «Mise a punto uno stratagemma per cogliermi in fallo. Mi mandò in casa una superba creatura di diciott’anni, con il pretesto che aveva bisogno di cure, accompagnata da una vecchia. Facendo l’ingenua, l’anziana si allontanò in giardino e la ragazza, rimasta sola con me, si mise a fare la libertina sia con le parole che con gli atti.» Manucci subodora il tranello e caccia la giovane. «Due mesi più tardi si presentò una ragazza ancora più graziosa, sola e trasportata dai servitori su una portantina. Sedicente malata, veniva da lontano per esser curata, o così volle farmi credere. Entrò velata, ma si scoprì avvicinandosi, si gettò ai miei piedi e mi supplicò di tenerla con me. Notai che indossava gioielli di valore e non era vestita come una donna qualunque. I suoi veli erano così sottili che s’indovinava la pelle di sotto. Capii la trappola. Dovevo accoppiùarmi con quella seduttrice e seguire la strada di tutti quelli che avevano perso l’anima per l’amore di una donna. Qualche anno prima due cappuccini portoghesi, di cui uno era priore di convento, cascarono in questa disgrazia e furono costretti a diventare maomettani.»
Manucci introduce una distinzione tra la condizione della donna musulmana – custodita gelosamente da mariti possessivi – e quella della donna indù che a volte appare disinibita, provocatrice e peccatrice. È un’immagine che fa presa in Europa. Proprio mentre il veneziano vive le sue avventure alla corte dei Moghul, in Francia appare Les voyages et observations di François de la Boullaye le Gouz, un diario di viaggi con ricche illustrazioni, dove una donna indù è ritratta mentre fa il bagno nuda, si massaggia la pelle con l’olio, gioca con i veli per eccitare la fantasia del lettore.
È di Manucci la prima descrizione della potenza delle donne indiane di religione islamica che vivono negli harem. «I maomettani passano la maggior parte del tempo in mezzo alle loro donne. Sono queste ultime che hanno spesso l’ultima parola sugli affari di corte. Per conto mio non l’ho mai dimenticato, e più d’una volta per i miei interessi ho fatto ricorso all’intervento di una principessa importante. Tutti gli intrighi di Stato, le guerre e le paci, le nomine di governo, sono ottenute attraverso i loro mezzi. Sono loro il vero gabinetto esecutivo del Gran Moghul. La preoccupazione primaria di ogni grande ufficiale dell’impero è di entrare nelle grazie di una signora protettrice alla corte. Una rottura con lei è la rovina. Fortunato l’uomo la cui sorte non dipende da una protettrice troppo capricciosa!»
È sua anche la descrizione della forza militare femminile che presidia l’harem. «Ciò che appare assai straordinario è che l’imperatore è sempre scortato dentro il serraglio da uno squadrone di virago tartare, un centinaio di donne armate di archi e frecce, pugnali e scimitarre. La signora capitana ha il rango di un alto ufficiale dell’esercito.»
I racconti di Manucci hanno oggettività e freddezza, l’autore non vi aggiunge di suo alcuna malizia. Altri suoi contemporanei indulgono in raffigurazioni ben più misteriose e minacciose (oggi diremmo sadomaso) della donna indiana. Il pregiudizio religioso ci aggiunge del suo, attribuendo alle indù riti demoniaci e perversioni pagane.
A distinguersi nelle fantasie morbose sono gli inglesi. Ecco il viaggiatore Sir Thomas Herbert, nel 1634: «La loro cerimonia più oscena è questa. Al matrimonio di una vergine lo sposo, per onorare gli idoli demoniaci, la conduce presso l’idolo o Pagoda; che è di alta statura, di forma orrenda, ed è fatto d’oro o d’argento nelle sue parti intime che sono lo strumento per violare la castità di lei. Una volta montato questo arnese e dopo aver sanguinato in abbondanza lei torna piena di gioia dal suo marito pagano. E se ha figli in quell’anno si suppone che sia stata fecondata dalla Pagoda». Il libro di Herbert, A Relation of Some Yeares Travaile, va a ruba e l’editore londinese ne fa numerose ristampe. Nell’arco di trent’anni ne vengono pubblicate due nuove edizioni sempre più lunghe. Gli inglesi inorridiscono e si dilettano al tempo stesso, di fronte a descrizioni di don...