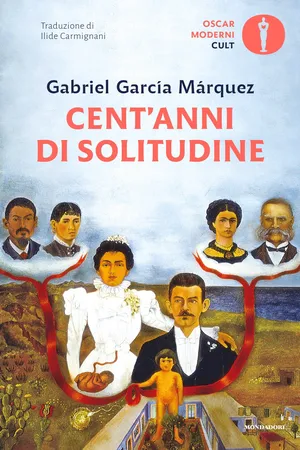Molti anni dopo, davanti al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía avrebbe ricordato quel pomeriggio remoto in cui suo padre l’aveva portato a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di fango e canne costruite sulla riva di un fiume dalle acque diafane che si precipitavano su un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano senza nome, e per menzionarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, nel mese di marzo, una famiglia di zingari straccioni piantava la tenda vicino al villaggio, e con gran chiasso di fischietti e timbales veniva a far conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita. Uno zingaro corpulento, con una barba selvatica e mani di passero, che si presentò col nome di Melquíades, diede una truce dimostrazione pubblica di quella che chiamava l’ottava meraviglia dei sapienti alchimisti di Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici, e tutti si spaventarono vedendo che paioli, padelle, pinze e fornelli cadevano in terra, e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiodarsi, e anche gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano là dove più erano stati cercati, e strisciavano in un turbolento fuggifuggi dietro ai ferri magici di Melquíades. «Le cose hanno vita propria,» proclamava lo zingaro in tono aspro «è solo questione di risvegliarne l’anima.» José Arcadio Buendía, la cui smisurata immaginazione andava sempre oltre l’ingegno della natura, e addirittura più in là del miracolo e della magia, pensò che fosse possibile servirsi di questa invenzione inutile per sviscerare l’oro dalla terra. Melquíades, che era un uomo onesto, lo avvisò: «Per quello non funziona». Ma José Arcadio Buendía all’epoca non credeva nell’onestà degli zingari, così scambiò il suo mulo e una partita di capre con i due lingotti calamitati. Úrsula Iguarán, sua moglie, che contava su quegli animali per accrescere lo stentato patrimonio domestico, non riuscì a dissuaderlo. «Ben presto avremo tanto oro da lastricare la casa» replicò il marito. Per vari mesi si impegnò a dimostrare la validità delle sue congetture. Esplorò palmo a palmo la regione, compreso il fondo del fiume, trascinando i due lingotti di ferro e recitando a voce alta la formula magica di Melquíades. L’unica cosa che riuscì a dissotterrare fu un’armatura del Quattrocento, con tutti i pezzi saldati insieme da una crosta di ruggine e che all’interno suonava vuota come un’enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendía e i quattro uomini della sua spedizione riuscirono a disarticolare l’armatura, trovarono uno scheletro calcificato che appeso al collo aveva un reliquiario di rame con un ricciolo femminile.
A marzo tornarono gli zingari. Stavolta avevano un cannocchiale e una lente d’ingrandimento delle dimensioni di un tamburo, che esibirono come l’ultima scoperta degli ebrei di Amsterdam. Fecero sedere una zingara all’altro capo del villaggio e piazzarono il cannocchiale all’ingresso della tenda. Pagando cinque reales, la gente guardava dentro il cannocchiale e vedeva la zingara a portata di mano. «La scienza ha eliminato le distanze» proclamava Melquíades. «Fra poco, l’uomo potrà vedere che cosa accade in qualsiasi angolo della terra, senza muoversi di casa.» Un mezzogiorno torrido fecero una dimostrazione sbalorditiva con la gigantesca lente: misero un mucchio di erba secca in mezzo alla strada e la incendiarono concentrando i raggi solari. José Arcadio Buendía, che non si era ancora consolato del tutto per il fallimento delle sue calamite, concepì l’idea di usare quell’invenzione come arma di guerra. Melquíades, ancora una volta, cercò di dissuaderlo. Ma finì per accettare i due lingotti calamitati e tre monete coloniali in cambio della lente. Úrsula pianse di costernazione. Quel denaro faceva parte di uno scrigno di dobloni d’oro che suo padre aveva messo da parte in una vita di privazioni, e che lei aveva sepolto sotto il letto in attesa di una buona occasione per investirli. José Arcadio Buendía non tentò nemmeno di consolarla, completamente assorbito dai suoi esperimenti tattici, con l’abnegazione di uno scienziato e addirittura a rischio della vita. Cercando di dimostrare gli effetti della lente sulle truppe nemiche, si espose ai raggi solari concentrati e riportò bruciature che si trasformarono in ulcere e impiegarono molto tempo a guarire. Fra le proteste della moglie, allarmata da una così pericolosa inventiva, per poco non incendiò la casa. Passava lunghe ore nella sua stanza, facendo calcoli sulle potenzialità strategiche di quell’arma nuova, finché non riuscì a compilare un manuale di sbalorditiva chiarezza didattica e irresistibile forza di convincimento. Lo inviò alle autorità insieme a numerose relazioni sulle sue esperienze e vari fascicoli di disegni illustrativi, affidandolo a un messaggero che attraversò la sierra, si smarrì in acquitrini sconfinati, risalì fiumi tumultuosi e per poco non perì sotto il flagello delle bestie feroci, della disperazione e della peste, prima di trovare una strada di collegamento con le mule della posta. Benché il viaggio nella capitale fosse a quei tempi poco meno che impossibile, José Arcadio Buendía prometteva di tentarlo non appena il governo glielo avesse ordinato, al fine di dare dimostrazioni pratiche della sua invenzione agli alti comandi militari, e di addestrarli personalmente nella complicata arte della guerra solare. Aspettò la risposta per diversi anni. Alla fine, stanco di aspettare, si lamentò con Melquíades del fallimento della sua iniziativa, e lo zingaro diede allora una convincente prova di onestà: gli restituì i dobloni in cambio della lente, e aggiunse anche delle mappe portoghesi e vari strumenti di navigazione. Scrisse di suo pugno una densa sintesi degli studi del monaco Ermanno, che gli lasciò a disposizione perché potesse servirsi dell’astrolabio, della bussola e del sestante. José Arcadio Buendía passò i lunghi mesi di pioggia chiuso in una stanzetta che aveva costruito in fondo alla casa perché nessuno disturbasse i suoi esperimenti. Completamente dimentico dei doveri domestici, rimase per notti intere nel patio a vigilare il corso degli astri, e fu lì lì per prendere un’insolazione cercando di mettere a punto il metodo esatto per stabilire il mezzogiorno. Quando si destreggiò nell’uso e nel maneggio dei suoi strumenti, acquisì una conoscenza dello spazio che gli permise di navigare per mari incogniti, di visitare territori disabitati e di stringere rapporti con esseri splendidi, senza bisogno di lasciare il suo studio. Fu a quell’epoca che prese l’abitudine di parlare da solo, vagando per casa senza badare a nessuno, mentre Úrsula e i bambini si spezzavano la schiena nell’orto a coltivare i banani e la malanga, la manioca e le patate dolci, le zucche e le melanzane. Di colpo, senza alcun preavviso, la sua attività febbrile s’interruppe e fu colto da una specie di allucinazione. Rimase vari giorni come stregato, ripetendo fra sé una sfilza di sbalorditive congetture, senza dar credito ai suoi stessi ragionamenti. Finalmente, un martedì di dicembre, all’ora di pranzo, scaricò di colpo tutto il peso del suo tormento. I bambini avrebbero ricordato per il resto della vita l’augusta solennità con cui il padre si sedette a capotavola, tremante di febbre, devastato dalla lunga veglia e dall’accanimento della sua immaginazione, e rivelò la sua scoperta:
«La terra è rotonda come un’arancia.»
Úrsula perse la pazienza. «Se devi diventare matto, fallo da solo» gridò. «Ma non inculcare nei bambini le tue idee da zingaro.» José Arcadio Buendía, impassibile, non si lasciò intimidire dalla disperazione della moglie, che in un accesso di collera gli spaccò l’astrolabio per terra. Ne costruì un altro, radunò nella stanzetta gli uomini del villaggio e dimostrò, con teorie che erano incomprensibili a tutti, la possibilità di tornare al punto di partenza navigando sempre verso oriente. Tutto il villaggio era convinto che José Arcadio Buendía avesse perso il senno quando arrivò Melquíades a rimettere a posto le cose. Esaltò in pubblico l’intelligenza di quell’uomo che attraverso la pura speculazione astronomica aveva elaborato una teoria già confermata nella pratica, benché fin allora sconosciuta a Macondo, e come prova della sua ammirazione gli fece un regalo che avrebbe esercitato un’influenza decisiva sul futuro del villaggio: un laboratorio di alchimia.
A quell’epoca, Melquíades era invecchiato con una rapidità sbalorditiva. Le prime volte dimostrava la stessa età di José Arcadio Buendía. Ma mentre questi conservava la sua forza eccezionale, che gli consentiva di atterrare un cavallo prendendolo per le orecchie, lo zingaro sembrava consunto da un male tenace. Era, in realtà, il risultato delle molte e rare malattie contratte nei suoi innumerevoli viaggi intorno al mondo. Come lui stesso raccontò a José Arcadio Buendía mentre lo aiutava ad allestire il laboratorio, la morte lo seguiva ovunque, annusandogli i pantaloni, ma senza decidersi a dargli la zampata finale. Era scampato a tante piaghe e catastrofi quante avevano flagellato il genere umano. Era sopravvissuto alla pellagra in Persia, allo scorbuto nell’arcipelago della Malesia, alla lebbra ad Alessandria, al beriberi in Giappone, alla peste bubbonica in Madagascar, al terremoto in Sicilia e a un naufragio di massa nello stretto di Magellano. Quell’essere prodigioso che diceva di possedere le chiavi di Nostradamus era un uomo lugubre, avvolto da un’aura triste, con uno sguardo asiatico che sembrava conoscere l’altro lato delle cose. Portava un cappello grande e nero, come le ali spiegate di un corvo, e un panciotto di velluto patinato dal verderame dei secoli. Nonostante la sua immensa saggezza e l’ambito misterioso, aveva un peso umano, una condizione terrestre che lo teneva vincolato ai minuscoli problemi della vita quotidiana. Si lamentava di mali da vecchio, soffriva per le più insignificanti difficoltà economiche e aveva smesso di ridere da molto tempo, perché lo scorbuto gli aveva strappato i denti. Il soffocante mezzogiorno in cui Melquíades gli rivelò i suoi segreti, José Arcadio Buendía ebbe la certezza che fosse l’inizio di una grande amicizia. I bambini rimasero a bocca aperta ai suoi racconti fantastici. Aureliano, che allora non aveva più di cinque anni, lo avrebbe ricordato per il resto della sua vita così come lo vide quel pomeriggio, seduto contro il chiarore metallico e riverberante della finestra, intento a illuminare con una profonda voce d’organo i territori più oscuri dell’immaginazione, mentre l’unto disciolto dal caldo gli colava sulle tempie. José Arcadio, il fratello maggiore, avrebbe trasmesso quell’immagine meravigliosa, come un ricordo ereditario, a tutta la sua discendenza. Úrsula, invece, conservò un brutto ricordo di quella visita, perché entrò nella stanza nel momento in cui Melquíades ruppe per sbaglio una boccetta di bicloruro di mercurio.
«È l’odore del diavolo» disse lei.
«Niente affatto» la corresse Melquíades. «È provato che il diavolo ha proprietà solforiche, e questo è solo un po’ di sublimato.»
Didattico com’era, fece una dotta esposizione delle virtù diaboliche del cinabro, ma invece di ascoltarlo Úrsula portò via con sé i bambini a pregare. Quell’odore pungente le sarebbe rimasto per sempre nella memoria, legato al ricordo di Melquíades.
Il rudimentale laboratorio – senza contare una miriade di pentolini, imbuti, storte, filtri e colini – consisteva in un rozzo atanor, in una provetta di vetro con il collo lungo e stretto, imitazione dell’uovo filosofico, e in un distillatore costruito dagli zingari stessi secondo le descrizioni moderne dell’alambicco a tre bracci di Maria l’Ebrea. Oltre a queste cose, Melquíades lasciò dei campioni dei sette metalli corrispondenti ai sette pianeti, le formule di Mosè e Zosimo per la moltiplicazione dell’oro, e una serie di appunti e disegni sui procedimenti del Gran Magistero, che permettevano a chi sapeva interpretarli di tentare la fabbricazione della pietra filosofale. Sedotto dalla semplicità delle formule per moltiplicare l’oro, José Arcadio Buendía corteggiò Úrsula per settimane, perché gli permettesse di dissotterrare le sue monete coloniali e di raddoppiarle tante volte quante era possibile suddividere il mercurio. Úrsula cedette, come sempre, davanti all’inflessibile ostinazione del marito. Allora José Arcadio Buendía buttò i trenta dobloni in un pentolino e li fuse con limatura di rame, orpimiento, zolfo e piombo. Mise tutto a bollire a fuoco vivo in un paiolo d’olio di ricino fino a ottenere uno sciroppo denso e puzzolente che somigliava più a banale caramello che all’oro magnifico. Fusa con i sette metalli planetari in rischiosi e disperati processi di distillazione, lavorata con il mercurio ermetico e con il vetriolo di Cipro, e messa di nuovo a cuocere nello strutto di maiale in mancanza dell’olio di rafano, la preziosa eredità di Úrsula fu ridotta a un cicciolo carbonizzato che non si riuscì a staccare dal fondo del paiolo.
Quando tornarono gli zingari, Úrsula aveva messo contro di loro tutta la popolazione. Ma la curiosità vinse il timore, perché quella volta gli zingari girarono per il villaggio facendo un rumore assordante con ogni tipo di strumento musicale, mentre il banditore annunciava la presentazione della più favolosa scoperta dei nazianzeni. Fu così che andarono tutti alla tenda, e a prezzo di un centesimo videro un Melquíades giovanile, rifiorito, senza rughe, con una dentatura nuova e splendente. Chi ricordava le sue gengive distrutte dallo scorbuto, le guance flaccide e le labbra vizze tremò di paura davanti a quella prova definitiva dei poteri soprannaturali dello zingaro. Paura che si trasformò in panico quando Melquíades si tolse i denti, intatti, infilati nelle gengive, e li mostrò al pubblico per un istante – un istante fugace in cui tornò a essere lo stesso uomo decrepito degli anni precedenti – e poi se li rimise un’altra volta e sorrise di nuovo con pieno dominio della sua giovinezza restaurata. Perfino José Arcadio Buendía pensò che le conoscenze di Melquíades fossero giunte a estremi intollerabili, ma provò un sano entusiasmo quando lo zingaro gli spiegò a quattr’occhi il meccanismo della dentiera. Gli parve una cosa così semplice, e al tempo stesso così prodigiosa, che dalla sera alla mattina perse ogni interesse alle ricerche di alchimia; ebbe una nuova crisi di malumore, smise di mangiare con regolarità e cominciò a passare le giornate ciondolando per casa. «Nel mondo stanno succedendo cose incredibili» diceva a Úrsula. «A un passo da qui, dall’altra parte del fiume, c’è ogni tipo di apparecchio magico, mentre noi continuiamo a vivere come asini.» Chi lo conosceva dai tempi della fondazione di Macondo si stupiva di quanto fosse cambiato sotto l’influenza di Melquíades.
All’inizio, José Arcadio Buendía era una specie di patriarca giovanile, che dava istruzioni per la semina e consigli per allevare bambini e animali, e che collaborava con tutti, anche ai lavori manuali, per il buon andamento della comunità. Dato che la sua casa era stata fin dall’inizio la più bella del villaggio, le altre furono sistemate a sua immagine e somiglianza. Aveva un salottino ampio e molto luminoso, una sala da pranzo fatta come una terrazza con fiori di colori allegri, due camere da letto, un patio con un castagno gigantesco, un orto ben coltivato e un recinto dove vivevano in pacifica comunità i capretti, i maiali e le galline. Gli unici animali proibiti, non solo in casa sua ma in tutto il paese, erano i galli da combattimento.
La laboriosità di Úrsula andava di pari passo con quella del marito. Attiva, minuta, seria, quella donna dai nervi d’acciaio, che nessuno aveva mai sentito cantare in alcun momento della sua vita, sembrava essere da tutte le parti dall’alba a notte inoltrata, sempre inseguita dal dolce sussurro delle sue sottogonne di olanda. Grazie a lei, i pavimenti di terra battuta, i muri di fango non imbiancati, i rustici mobili di legno che si erano costruiti con le loro mani erano sempre puliti, e le vecchie cassapanche dove si conservava la biancheria emanavano un lieve odore di basilico.
José Arcadio Buendía, che era l’uomo più intraprendente che si sarebbe mai visto al villaggio, aveva disposto le case in modo che da ognuna si potesse arrivare al fiume a rifornirsi d’acqua con pari sforzo, e aveva tracciato le strade con tanto buonsenso che nessuna casa prendeva più sole di un’altra nelle ore calde. In pochi anni, Macondo divenne un villaggio così ordinato e laborioso che i suoi trecento abitanti non ne avevano mai visto uno uguale. Era davvero un villaggio felice, dove nessuno aveva più di trent’anni e nessuno era mai morto.
Fin dai tempi della fondazione, José Arcadio Buendía aveva costruito trappole e gabbie. In poco tempo riempì di trupiali, canarini, tangare e pettirossi non solo la sua casa, ma tutte quelle del villaggio. Il concerto di tanti uccelli diversi arrivò a essere talmente assordante che Úrsula si tappò le orecchie con la cera d’api per non perdere il senso della realtà. La prima volta che arrivò la tribù di Melquíades a vendere palle di vetro per il mal di testa, tutti si stupirono che fossero riusciti a trovare quel villaggio sperduto nel sopore della palude, e gli zingari confessarono di essersi orientati col canto degli uccelli.
Quello spirito di iniziativa sociale scomparve in poco tempo, travolto dalla febbre delle calamite, dai calcoli astronomici, dai sogni di trasmutazione e dall’ansia di conoscere le meraviglie del mondo. Da intraprendente e pulito, José Arcadio Buendía divenne un uomo dall’aria sfaticata, trascurato nel vestire, con una barba selvaggia che Úrsula riusciva malamente a regolare con un coltello da cucina. Qualcuno pensò che fosse vittima di qualche strano sortilegio. Ma anche i più persuasi della sua follia abbandonarono lavoro e famiglia per seguirlo quando si mise in spalla gli attrezzi per disboscare, e chiese l’aiuto di tutti per aprire un sentiero che collegasse Macondo alle grandi invenzioni.
José Arcadio Buendía ignorava completamente la geografia della regione. Sapeva che a oriente c’era la sierra impenetrabile, e oltre la sierra l’antica città di Riohacha, dove in epoche passate – come gli aveva raccontato il primo Aureliano Buendía, suo nonno – sir Francis Drake si dava allo sport di cacciare i caimani a cannonate, e poi li faceva rammendare e riempire di paglia per portarli alla regina Elisabetta. In gioventù, lui e i suoi uomini, con donne e bambini e animali e ogni sorta di utensile domestico, avevano attraversato la sierra cercando uno sbocco sul mare, e dopo ventisei mesi avevano desistito dall’impresa e fondato Macondo per non dover intraprendere il cammino di ritorno. Quella era, quindi, una strada che non gli interessava, perché poteva condurlo solo al passato. A sud c’erano i pantani, coperti di un’eterna patina vegetale, e il vasto universo della palude grande, che secondo la testimonianza degli zingari non aveva confini. La palude grande si confondeva a occidente con una distesa acquatica senza orizzonti, dove c’erano cetacei dalla pelle delicata con testa e busto di donna, che perdevano i naviganti con l’incanto delle loro tette smisurate. Gli zingari navigavano per sei mesi su quella rotta prima di raggiungere la striscia di terraferma dove passavano le mule della posta. Secondo i calcoli di José Arcadio Buendía, l’unica possibilità di contatto con la civiltà era la via del nord, cosicché dotò di attrezzi per disboscare e armi da caccia gli stessi uomini che lo avevano seguito nella fondazione di Macondo, buttò in uno zaino gli strumenti per orientarsi e le mappe, e intraprese quella temeraria avventura.
I primi giorni non trovarono ostacoli degni di nota. Discesero per la sassosa riva del fiume fino al punto in cui anni prima avevano trovato l’armatura del guerriero, e là entrarono nella boscaglia da un sentiero di aranci selvatici. Alla fine della prima settimana, ammazzarono e arrostirono un cervo, ma si accontentarono di mangiarne metà e salarono il resto per i giorni seguenti. Con questa precauzione intendevano sottrarsi alla necessità di mangiare sempre ara, la cui carne azzurra di pappagallo aveva un aspro sapore di muschio. Poi, per oltre dieci giorni, non videro più il sole. Il terreno diventò umido e molle, come cenere vulcanica, e la vegetazione si fece sempre più insidiosa, e sempre più lontane le grida degli uccelli e il chiasso delle scimmie, e il mondo divenne triste per sempre. Gli uomini della spedizione si sentirono sommersi dai loro ricordi più antichi in quel paradiso di umidità e silenzio, anteriore al peccato originale, dove gli stivali affondavano in pozze di oli fumanti e i machete facevano a pezzi gigli sanguigni e salamandre dorate. Per una settimana, quasi senza parlare, avanzarono come sonnambuli in un universo di angoscia, illuminati appena dal tenue riverbero di insetti luminosi e con i polmoni oppressi da un soffocante odore di sangue. Non potevano tornare indietro perché il sentiero che aprivano passo passo si richiudeva poco dopo, con una vegetazione nuova che vedevano quasi crescere sotto i propri occhi. «Non importa» diceva José Arcadio Buendía. «L’essenziale è non perdere l’orientamento.» Sempre attaccato alla bussola, continuò a guidare i suoi uomini verso il nord invisibile, finché non arrivarono alla fine della regione incantata. Era una notte compatta, senza stelle, ma l’oscurità era impregnata di un’aria nuova e pulita. Esausti per la lunga marcia, appesero le amache e dormirono profondamente per la prima volta in due settimane. Quando si svegliarono, con il sole già alto, rimasero a...