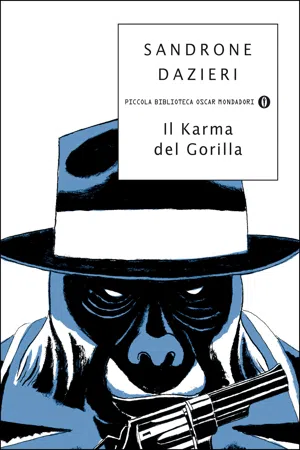
Questo libro è disponibile per la lettura fino al giorno 13º gennaio, 2026
- 294 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Disponibile fino al giorno 13 Jan |Scopri di più
Il karma del gorilla
Informazioni su questo libro
Ora che sbarca il lunario come addetto "free lance" alla sicurezza, il Gorilla non ha rinunciato alle brutte abitudini, e passa il tempo a sbronzarsi e a fare a pugni con focosi supporter della guerra in Irak. A rendergli le cose più complicate riappare Sammy, un vecchio amico che ha un incarico per lui: rintracciare la sua ex fidanzata, scomparsa da anni, e probabilmente finita nei guai. Un incarico che al Gorilla non piace, ma che è costretto ad accettare perché Sammy conosce il suo segreto: l'esistenza del Socio, la seconda personalità schizofrenica che agisce nel corpo del Gorilla quando questi si addormenta. Un segreto che se fosse rivelato metterebbe fine al delicato equilibrio della sua vita, fatto di continue menzogne e sotterfugi. Mentre qualcuno si dimostra disposto a uccidere pur di fermarlo, il Gorilla sarà così costretto a cominciare una rischiosa indagine senza quartiere, tra ambigui poliziotti, servizi segreti deviati, manager e modelle, alla ricerca di una verità che si nasconde nel suo passato.
Noir avvincente e spietato, oltre che ironico ritratto del nostro presente, Il Karma del Gorilla conferma Dazieri come una delle voci più originali del noir italiano.
Noir avvincente e spietato, oltre che ironico ritratto del nostro presente, Il Karma del Gorilla conferma Dazieri come una delle voci più originali del noir italiano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il karma del gorilla di Sandrone Dazieri in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804561668eBook ISBN
97888520111911
La telefonata che diede inizio alla più disastrosa serie di avvenimenti che avesse mai coinvolto la mia persona arrivò in contemporanea con il tifone Katrina su New Orleans. Io e Piero stavamo seguendo la diretta sulla Cnn, unici due abitanti svegli del complesso di loft a buon mercato che ci faceva da casa. La notte prima, tutti i miei vicini avevano festeggiato la fine dell’estate con un rave nel cortile, andando avanti fino alle sei del mattino con la musica a palla e qualcosa come seicento ragazzotti che ballavano e vomitavano in tutti gli angoli. Capita, quando i tuoi vicini sono tutti giovani di tendenza, che campano con lavori creativi e improbabili. Anche Piero era un giovane di tendenza, visto che gestiva un atelier di moda, ma invece di andare a dormire era venuto a bussare alla mia porta a mezzogiorno, con l’ultima bottiglia di vodka ancora intatta, e io l’avevo accolto facendogli posto sul divano.
Quando suonò il telefono, le immagini in televisione erano quelle di un nero che trasportava del cibo su una barca. Lo speaker stava dicendo che aveva saccheggiato un supermercato, con il tono di chi riterrebbe più logico morire di fame. Guardai il display del mio cellulare e rabbrividii. «È Padre Molinas» dissi prendendo la bottiglia.
«E non gli rispondi?» chiese Piero.
«Non so se me la sento. Ha sempre una rogna in serbo.»
Padre Molinas era il direttore di una rete di centri di accoglienza sparsi per la penisola, oltre che il più grosso impiccione che avessi conosciuto. Non l’avevo mai visto in tonaca, preferiva maglioni grigi che gli davano l’aspetto di un camionista cattivo. Fumava il sigaro e una volta lo avevo visto battere un facchino albanese in una gara di sputi.
Il telefonino smise, poi riprese. Continuai a fissarlo.
«Mi sa che non ti molla» disse Piero.
«Mi sa anche a me.»
Alla fine risposi e mi toccò andare a infilarmi i calzoni e le scarpe e saltare in macchina.
L’ennesima rogna che Padre Molinas mi aveva scodellato riguardava una coppia di fratelli egiziani: Muhammad e Haifa. Erano scappati dall’Egitto per sottrarsi a un arresto per attività sovversive e, gira e rigira, lei era finita da parenti lontani in Germania e lui a Varese, dove si arrangiava dando ripetizioni di inglese, scaricando camion e insegnando il Corano in moschea. Quando Muhammad aveva smesso di farsi vivo, Haifa era venuta in Italia a cercarlo. Ci aveva impiegato un annetto per arrivare, tra visti e menate, e qui aveva scoperto che all’indirizzo del fratello viveva adesso una coppia di italiani poco gentili. Muhammad si era dato senza pagare l’affitto più o meno nel periodo in cui aveva smesso di rispondere alle lettere.
Haifa aveva pellegrinato tra ospedali e centri islamici senza cavarne niente. Mentre stava per finire i pochi soldi, aveva incontrato una vicina di casa del fratello, un’algerina piuttosto spaventata e sfuggente, che mossa a pietà le aveva rivelato quello che ormai Haifa sospettava. Muhammad era stato rapito. Un giorno, mentre usciva dal portone, tre occidentali gli si erano avvicinati e l’avevano caricato su un furgone con la scritta TRASLOCHI. Lui aveva cercato di scappare, uno dei tizi lo aveva preso a pugni in pancia e aveva chiuso lo sportello. Visto che la polizia non sembrava interessata al caso, Haifa era andata a chiedere consiglio alla mensa dei poveri dove consumava i suoi pasti. E qui aveva trovato Padre Molinas, e Padre Molinas aveva trovato me.
Quando arrivai al Centro Mani Aperte, Molinas era sulla soglia che fumava il toscano. «Ce ne hai messo.»
«Mi si è rotto il teletrasporto.»
Mi spinse dentro. “Va be’, adesso che sei qui datti da fare.»
Facemmo un conciliabolo a tre attorno al bigliardino del refettorio. Haifa raccontò di nuovo la sua storia, alternando tedesco sgrammaticato e arabo.
Padre Molinas mi prese in disparte. «Che ne pensi?»
«Secondo me dice la verità. Non mi sembra in grado di essersela inventata. È una roba da sbirri, questa.»
«Se volevano occuparsene, mica chiamavo te.»
«C’ero arrivato. Va be’, sentiamo Mirko Bastoni.»
Mirko era il mio avvocato di fiducia, quarantacinque anni con una faccia che ne dimostrava la metà, sguardo da ragazzino e lingua biforcuta. Ci conoscevamo da quando ero un militante politico al centro sociale Leoncavallo, il che significa da un sacco di tempo. Lo dovetti pregare un po’, ma neanche tanto, considerando che doveva lavorare gratis.
Un paio di ore dopo, andammo insieme a dare l’assalto alla questura di Varese. Lui fece del suo peggio, bussò alle porte di tutti gli uffici con me come sostegno morale, pregò e minacciò senza cavarne molto. Poi si fece portare al tribunale di Milano e sparì nei suoi meandri.
Io lo aspettai seduto al tavolino di un bar poco distante, dando da mangiare ai piccioni il mio panino alle verdure. Erano le sei. Il bar era pieno di avvocati in libera uscita e poliziotti. Mirko tornò che mi era rimasta solo la melanzana alla griglia, talmente dura che non riuscivo a spezzarla. La tirai ai pennuti che la smembrarono a colpi di becco.
Mirko era accompagnato da una donna sulla cinquantina, l’aria asciutta e occhiali più spessi dei miei.
«Sandrone, ti presento la dottoressa Pagni, sostituto procuratore.»
Anche la sua stretta di mano fu asciutta. Si sedettero al mio tavolino e ordinarono un caffè. La dottoressa Pagni andò subito al punto. «Signor Dazieri, lei ha idea di che cosa sia un’extraordinary rendition?» mi chiese.
«No. Ma mi sa che non è niente di buono.» Diedi un’occhiata ai miei piccioni: la melanzana era sparita.
«È un termine tecnico della Cia. Significa…»
«Aspetti un attimo. La Cia? Quella di Langley e James Bond?»
«Sì, signor Dazieri, anche se credo che l’agente 007 fosse inglese.»
«La Cia…»
La donna sospirò. «Mi rendo conto che possa apparire quanto meno drammatico, ma è così. Le sto spiegando questa cosa perché il dottor Bastoni mi ha raccontato il suo… ruolo in questa faccenda, e mi ha anche assicurato che lei terrà la bocca chiusa.»
«La Cia…» ripetei.
«Ti si è incantato il disco?» ghignò Mirko.
«Per farla breve, signor Dazieri, la rendition è quando la Cia va in un altro Paese e si porta via un sospetto terrorista. Dopo l’11 settembre ne sono già state documentate almeno una settantina. Li prendono, li scaricano da qualche parte dove hanno mano libera, tipo Egitto, Marocco, Pakistan… Avrà sentito parlare dell’Imam di viale Jenner, a Milano. Abu Omar.»
Mi riscossi dai miei incubi a base di ombrelli al cianuro e le feci cenno di proseguire. Avevo letto la storia sui giornali.
«L’hanno portato via il 17 febbraio del 2003» continuò la procuratrice. «Per due anni non se ne è saputo niente. Adesso sappiamo che è nel carcere egiziano di Torah, ed è stato torturato con tale brutalità che ha grossi problemi di salute. Se il signor Muhammad ha subito la sua stessa sorte, è stato portato con un mezzo affittato o rubato sino alla base militare di Aviano, caricato su un aereo militare degli Stati Uniti e, probabilmente, rimandato in Egitto. L’Italia non è l’unico paese europeo, comunque, in cui la Cia si muove come a casa propria. Ci risultano altri casi. Per esempio quello del signor Khaled el Masri. Era un venditore di automobili a Ulm, ma era quasi omonimo di un terrorista ricercato. I servizi segreti americani l’hanno portato in Afghanistan, fatto rinchiudere in prigione, torturato e in seguito liberato su un sentiero di montagna in Albania. Stavolta è stato il governo tedesco a dire di non saperne niente.»
«Tutto il mondo è paese.»
La procuratrice mi fissò con evidente disgusto. «Se la storia del signor Muhammad è quello che sembra, è l’ennesima dimostrazione che le rendition stanno andando avanti.»
«Di quante siete sicuri?» chiesi.
«Sicuri? Di nessuna.» Fece una smorfia, e io non capii se le pesasse di più parlare con me o tutta la faccenda. «Come può immaginare, la comunità immigrata, tra clandestini e persone di fatto ostili al nostro paese, non ci è di molto aiuto. E il governo statunitense non risponde alle nostre richieste di informazioni. O a nient’altro. Per il rapimento di Abu Omar la nostra magistratura ha emesso venti ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini americani, ma non ci verranno mai consegnati. Uno era l’ex console di Milano.»
«Allora perché darsi tanta pena?»
Quasi le si creparono gli occhiali. «Perché nessuno, signor Dazieri, tanto meno gli agenti della Cia, può pensare di essere al di sopra della legge del nostro paese.»
Mirko allontanò un piccione troppo interessato al suo piede. «Sandrone, io non ho una grande passione per i terroristi, e neanche la procuratrice qui presente, ma di Muhammad si poteva solo dire che era musulmano e che era contrario alla guerra in Irak.»
«Niente prove» dissi.
«No.»
Sospirai. «Va bene, cosa volete che faccia? Perché vi avviso, il controspionaggio internazionale non è il mio pane.»
La procuratrice alzò le sopracciglia. «Noi vogliamo che lei non faccia nulla.»
Mi rincuorai. «Ah, davvero? È quello che so fare meglio.»
«Sono venuta chiederle di lasciar perdere. Il dottor Bastoni mi ha detto quello che sapevate. Sarà mia cura raccogliere la deposizione della sorella del rapito e aprire un fascicolo contro ignoti. Con la massima discrezione, per evitare che qualcuno decida che è meglio rimandarla di corsa in Germania.»
Guardai Mirko. «Non ci sono molte possibilità o sbaglio?»
Sì alzò. «Accompagno io la dottoressa Pagni. Grazie per avermi rovinato la settimana.»
«Non c’è di che.»
Rimasi al tavolino del bar a guardarli andare via. Una coppia di coraggiosi in lotta contro l’Impero del Bene, non ci avrei scommesso due lire. Ordinai da bere per brindare allo scampato pericolo, ma mi accorsi che invece di sentirmi sollevato il malumore montava. E con il malumore montava anche la voglia di prendermela con qualcuno o spaccare qualcosa. Il bar chiuse, ne trovai un altro in piazza San Babila, ancora troppo sobrio per tornarmene a casa a guardare i muri. Ebbi quello che cercavo.
Milano è così, qualche volta gli idioti ti arrivano a domicilio. Come fecero i sei buzzurri in mimetica mentre mi era stato appena servito il cocktail con ombrellino di carta. Erano cinque ragazzotti muscolari e un cinquantenne con il cappello da alpino.
Il tizio con il cappello chiese un attimo di silenzio, poi invitò tutti ad alzarsi in piedi e cantare l’inno nazionale in segno di solidarietà verso i soldati italiani in Irak. Guardai le facce degli altri sorpresi a bere l’aperitivo e vidi occhi che si abbassavano sul caffè, sorrisi che sparivano, nessuno che accennasse una protesta o una risata. Aspettai che i più fessi si unissero al coretto e saltai addosso a quello che reggeva la bandiera di Casa Savoia. Era il più piccolo del gruppo, lo avevo scelto apposta, e andò giù subito prima che gli altri mi saltassero addosso.
Dopo un secondo eravamo diventati la palla cinetica dei cartoni animati, con braccia e gambe che spuntano dal fumo. Rotolammo in strada e continuai a picchiare nel mucchio. Non tanto a lungo. Uno dei tizi mi prese al mento con un calcio da mille tonnellate. Volai all’indietro e caddi lentamente mentre i suoni diventavano liquidi. Però feci il possibile per rimanere sveglio mentre mi suonavano come un tamburo. Non volevo che il mio Socio si svegliasse e mi togliesse il divertimento.
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Il Karma del Gorilla
- Capitolo 1
- Capitolo 2
- Capitolo 3
- Capitolo 4
- Capitolo 5
- Capitolo 6
- Capitolo 7
- Capitolo 8
- Capitolo 9
- Capitolo 10
- Capitolo 11
- Capitolo 12
- Capitolo 13
- Capitolo 14
- Capitolo 15
- Capitolo 16
- Capitolo 17
- Capitolo 18
- Capitolo 19
- Capitolo 20
- Capitolo 21
- Capitolo 22
- Capitolo 23
- Capitolo 24
- Capitolo 25
- Capitolo 26
- Capitolo 27
- Capitolo 28
- Capitolo 29
- Capitolo 30
- Capitolo 31
- Capitolo 32
- Capitolo 33
- Capitolo 34
- Capitolo 35
- Capitolo 36
- Capitolo 37
- Capitolo 38
- Capitolo 39
- Capitolo 40
- Capitolo 41
- Capitolo 42
- Capitolo 43
- Capitolo 44
- Capitolo 45
- Se siete arrivati fin qui…
- Copyright