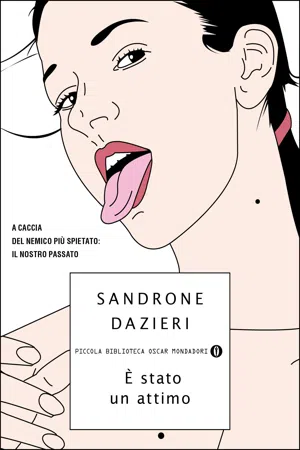Mi svegliò una vibrazione ritmica proveniente dal comodino. Non aprii subito gli occhi e per un po’ rimasi a chiedermi perché la luce sembrasse provenire dalla direzione sbagliata. Anzi, perché ce ne fosse. La mia stanza nell’appartamento di viale Monza aveva praticamente la finestra appiccicata al palazzo di fronte e il sole non riusciva a infilarvisi. Aprii gli occhi: il mondo del futuro era ancora intorno a me. E io ero sempre io, pubblicitario prendilo in quel posto. Però se fosse stato solo un brutto sogno non mi sarei lamentato.
La vibrazione si ripeté, e scoprii che proveniva dal mio telefonino. Ne avevo uno anch’io, ce l’avevano tutti a quanto pareva: il pubblicitario doveva averlo lasciato a casa prima di andare alla Scala. Lo presi in mano e vidi sullo schermo la scritta ufficio diventare chiamata persa. C’era anche l’ora, 10.25. Ufficio, da ridere.
Mi trascinai in bagno e qui fui costretto a guardarmi di nuovo. Facevo davvero schifo, avrei dovuto coprire gli specchi come le dive del muto. Oppure mettermi a dieta: al solo pensiero mi venne una fame da lupo. Da quanto non mangiavo?
La doccia era un cilindro di cristallo piazzato al centro del bagno e dentro aveva più leve e bottoncini della plancia di un aeroplano. Entrai e armeggiai con i comandi fino a quando i tubi gorgogliarono e venni frustato da una serie di getti gelidi provenienti da cento direzioni diverse. Sputacchiando premetti ancora e il getto divenne uno, dall’alto, che alla fine riuscii a regolare alla temperatura giusta. Sapone liquido marca Body Shop, Non testato sugli animali. Che buon cuore aveva il pubblicitario. Viveva nella casa di Elvis Presley, ma badava ai particolari. Quando chiusi l’acqua sentii un rumore provenire dal piano di sotto. Mi avvolsi in un accappatoio Missoni e mi sporsi a guardare dal ballatoio. C’erano due cinesi, uomo e donna sui trent’anni, che si sbattevano in giro con aspirapolvere e scopa. Pure la servitù, mi sembrava giusto.
I due alzarono la testa, stupiti di vedermi, io feci un cenno benevolente e ritornai in camera a cercare qualcosa da mettermi. L’armadio in bambù e carta di riso conteneva solo coperte e cuscini. Stavo già pensando di infilarmi di nuovo il pigiama da checca, quando scoprii che uno degli specchi era in realtà un pannello scorrevole dietro cui si nascondeva un guardaroba grande come il mio caro, vecchio monolocale. Trovai mutande e calzini in una cassettiera che saliva a zigzag come un serpente e, appesi nella cabina armadio su una rastrelliera a motore, una fila di completi. Premetti il bottone e gli abiti cominciarono a scorrere. Tutti uguali, tutti ugualmente neri. Poi passarono i bianchi, poi di nuovo la sezione nera. Rimasi a guardarli scorrere, indeciso se ridere o piangere. Ero diventato un pirla con gli anni, per fortuna adesso potevo rimediare.
Trovai un paio di jeans piegati su un ripiano, pieni di strappi e parti lise, anche se qualcosa mi fece pensare fossero nati così, già consumati per evitare la fatica a chi li comprava. Marca: Marité François Girbaud. Misi quelli e un maglione peloso direttamente sulla pelle nuda. Mentre mi infilavo un paio di Nike arancione brillante con delle suole da Star Trek, sentii qualcuno armeggiare in camera. Mi affacciai. Il cinese stava rifacendo il letto. «Good morning, mister.»
«Ciao.»
«No job today?»
Non mi ero sbagliato, parlava proprio in inglese, e si aspettava che lo capissi. Frugai tra i ricordi delle medie e trovai la traduzione di job. «Sono in ferie.»
«Ah. Did I disturb you?»
«Fai, fai.»
Scesi in cucina. La cinese stava pulendo il lavello. Neanche lei capiva l’italiano, e le feci capire a gesti che avevo fame. Lei sorrise, armeggiò con le chicchere e mi posò di fronte una tazza di broda nera e dei biscotti semitrasparenti. Annusai la broda, non aveva l’odore giusto.
La richiamai con uno schiocco delle dita. «Tipa: caffè. Comprende?»
Mi guardò strano e disse qualcosa in ostrogoto.
«Italian, please.»
«No piace?»
«No piace. Perché ciofec.»
«No orzo?»
Ecco cos’era. «No. Real caffè, please.»
Entrò il cinese maschio, con il mio telefonino in mano. «Telephon call, mister.»
Me lo passò. Lo schermo indicava Monica. Lo rigirai in mano, scoprendo che si apriva in due come un vecchio Grillo, solo grande un decimo. La voce di donna cominciò a pigolare. Sospirando, appoggiai il coso all’orecchio.
«Saint?» Monica parlava a bassa voce ma si sentiva meglio di quanto immaginassi. Un suono pulito, senza i fruscii di sottofondo dei telefoni con il filo. Forse erano migliorati anche quelli.
«Cosa vuoi?»
Abbassò ancora di più la voce. Aveva un tono strano, come avesse appena finito di piangere. «Come stai?»
«Al momento seduto al tavolo che cerco di convincere una cinese a farmi un caffè decente.»
«È filippina» disse in tono stanco. «Si chiama Maria, e il marito Rosario.» Fece una pausa. «Non sei guarito.»
«Ti chiamo io quando capita.»
Singhiozzò, dio che palle. «Per favore, Saint. Devi venire subito in ufficio. È importante.»
Assaggiai un biscotto. Sapeva di cartone. Lessi sulla scatola, Cialde al kamut e farro. Bella merda.
«Saint?»
Ah, già. «Sì?»
«Allora vieni?»
«No.»
«Saint, ti prego.» Altro singhiozzo. «È successa una cosa grave. Io non so come dirtelo ma…»
«Ecco, non dirmelo. Non dirmi più niente. Fatti suora, suicidati, trovati un altro fidanzato. Basta che sparisci.»
Richiusi il telefonino, sentendomi liberato. Maria mi porse un’altra tazza, guardandomi con apprensione. Assaggiai, caffè vero. Brava ragazza. Lo finii e me ne feci fare un altro e, a dispetto del sapore, spazzolai mezza scatola di biscotti. Mi mancavano le sigarette, avrei rimediato con il primo tabaccaio in zona.
Il cappotto riportato da Monica era rimasto sulla sedia del soggiorno dove l’aveva abbandonato. Lo infilai, controllando che in tasca ci fossero ancora le chiavi di casa: c’erano, Monica non mi avrebbe fatto un’improvvisata. Per sicurezza avrei cambiato la serratura. Dalla giacca della sera prima presi il portafoglio. Era di pelle, con una V di metallo cucita sopra, e visto che non era la mia iniziale immaginai fosse dello stilista. Il mio io attuale sembrava stare male senza una marca, ero stato fortunato a non trovarmene una tatuata sul culo. Dentro scoprii le famose carte di credito di cui parlavano gli sbirri la sera prima, con il mio nome sopra. Guardai la data di scadenza di quella grigia, la mitica Platinum: 2008. Mi fece impressione. Mi ero visto Spazio 1999 e mi sembrava una data fantasticamente lontana. Adesso l’avevo superata. Possedevo anche una tessera magnetica con stampata la mia nuova faccia da fesso e il marchio Beagle & Manetti – la sede era in piazza Missori 8 – e un pass per la palestra Nuovi Dei. Non ci andavo molto, a giudicare dalla pancia che mi era venuta. Quando la rimisi via cadde sul tavolo lo scontrino di un bar: caffè, 0,80.
Zero ottanta di cosa? Uhmm. Lo capii tirando fuori i soldi. Sembravano quelli del Monopoli. Euro?
Andai a caccia del filippino. Stava pulendo la cenere del camino. Gli sventolai un biglietto sotto il naso. «Sono soldi, questi?»
Mi guardò confuso.
«Money?»
«Yes.»
«No lire?»
«No, mister.»
«Da quando? No, lascia perdere. Quanto valgono? How much?»
Rise. Ci riprovai. Alla fine capii che un euro valeva circa duemila delle vecchie lire. Nel portafoglio avevo due biglietti da cinquanta e due da cento, e qualche minutaglia. Più di mezzo milione dei miei tempi. Una volta avrei potuto camparci un mese, adesso chissà. Milleseicento lire un caffè, ’sti cazzi.
Nella tasca interna del cappotto trovai anche un libretto degli assegni, una penna stilografica Montblanc con fregi in oro e la patente ciancicata. Non era la mia vecchia, ma nella fotina ero ancora un giovincello scherzoso. Le chiavi dell’automobile erano sul tavolo del salone, attaccate a uno stemma della Porsche. La immaginai slanciata con i sedili in pelle, non vedevo l’ora di posarci le chiappe. Il telefonino vibrò ancora. Altra chiamata persa. Non guardai neanche di chi fosse e lo infilai in tasca. Era tempo di rimettere insieme un po’ di pezzi.