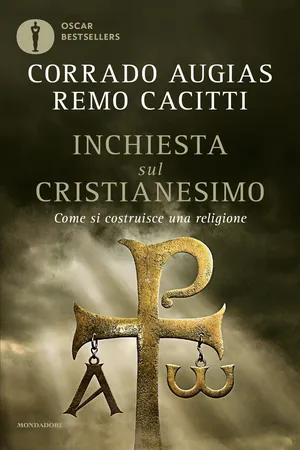Poche religioni, nella fase iniziale e anche in seguito, sono state più differenziate del cristianesimo. Differenziate al punto che non è esagerato parlare di vari cristianesimi che hanno convissuto a lungo nei primi secoli, separati da rilevanti difformità.
E numerosi sono anche i testi che raccontano le prime fasi o forniscono testimonianza di qualche episodio. Per dare solo un’idea si possono enumerare, per esempio, il Vangelo degli ebioniti, il Protovangelo di Giacomo, il Vangelo degli egiziani, il Vangelo dei nazareni, il Vangelo di Giuda, il Vangelo del Salvatore, il Vangelo di Filippo, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Nicodemo, il Vangelo di Pietro, il Vangelo degli ebrei. Quasi altrettanto fitto l’elenco degli «Atti», fra i quali troviamo gli Atti di Pilato, gli Atti di Tecla, gli Atti di Tommaso eccetera. Esistono una quantità di epistole, alcune dichiaratamente false, compresa una corrispondenza fra Paolo e Seneca, una Lettera dello Pseudo-Tito, una Lettera di Barnaba, una Lettera di Clemente, una Lettera di Tolomeo e via dicendo. Anche il catalogo delle apocalissi è ben nutrito.
Tutte queste opere hanno per gli specialisti uno straordinario interesse. Anche quando la loro autenticità appare dubbia, aiutano a capire le condizioni in cui una corrente del movimento cristiano era nata o si stava sviluppando, facilitano, per analogia o per contrasto, la comprensione di altri testi, i loro rapporti reciproci. Prendiamo, per esempio, la corrispondenza fra Paolo e il filosofo Seneca. È chiaro che si tratta di un falso e quasi nessuno ha mai preteso che fosse autentica. È interessante, però, indagare le ragioni per le quali si è sentito il bisogno di fabbricare il falso. Allora si vede che le quattordici lettere che i supposti autori non hanno mai scritto, sono state inventate per dimostrare che Paolo godeva di alta considerazione nei circoli filosofici della sua epoca. Prendiamo la Lettera di Barnaba, che possiamo definire uno pseudoepigrafo, cioè un testo scritto da chissà chi e posto sotto l’autorità di Barnaba, compagno di Paolo. Tale paternità serviva a dare valore alla tesi sostenuta nell’opera, ossia che l’ebraismo è una falsa religione e che l’Antico Testamento è un libro cristiano.
Da un punto di vista storico possiamo dire che i documenti falsi sono importanti quanto quelli autentici, se esaminati da specialisti in grado di collocarli nella temperie della loro epoca e di scoprire le motivazioni per le quali sono stati fabbricati. Quando le gerarchie fecero la scelta di restringere i documenti ritenuti ispirati ai quattro vangeli detti «canonici», dovettero quindi sfoltire enormemente i testi in circolazione e scegliere quelli più simili fra loro. Così è, infatti, per i tre vangeli detti «sinottici» (Marco, Luca, Matteo), lo è di meno per il quarto (Giovanni), che resta però compatibile con i precedenti.
Con un grande balzo di venti secoli, possiamo affermare che le enormi diversità esistenti fra i cristianesimi delle origini continuano anche oggi. Fra i missionari che operano nelle zone disagiate del mondo, spesso a rischio della vita, e un predicatore televisivo americano che insegna come diventare ricchi e felici, esiste una distanza abissale. Eppure, entrambi si rifanno a Gesù, entrambi si dicono cristiani e ispirati dagli stessi vangeli. Ciò che più conta, entrambi reclamano, per la maggior parte, di essere i soli legittimi eredi del messaggio lasciato dal Cristo.
È lecito considerare tali diversità, spesso insignificanti e che sconfinano a volte nel pittoresco, i residui attualizzati delle grandi diversità esistenti nel II e nel III secolo. C’erano allora cristiani convinti che il mondo fosse stato creato da Dio e altri per i quali non il Dio buono, ma una divinità malvagia aveva creato l’universo, il che spiegava come mai nel mondo ci fosse tanto male. Per altri ancora, il fabbricatore del mondo era una divinità di second’ordine, che non disponeva pienamente del predicato essenziale di Dio, cioè dell’eternità. Per secoli ci sono stati cristiani che non hanno mai sentito parlare della verginità della madre di Dio, né mai hanno sentito il bisogno di ipotizzare una circostanza che stride così apertamente con il senso comune. Anche su Gesù circolavano fra i cristiani le opinioni più diverse. Alcuni credevano, in base all’insegnamento di Paolo, che la sua morte e resurrezione avessero comportato la redenzione del genere umano, mentre altri pensavano che non avessero niente a che fare con la salvezza, e altri ancora ritenevano che non fosse mai morto.
Come si spiega che idee tanto diverse convivessero presso persone in assoluta buona fede, rettamente ispirate, tese alla ricerca del bene, che si dicevano seguaci della stessa religione? Si spiega col fatto che, in quei secoli, non era ancora stato costituito un corpus di testi di riferimento valido per tutti, quello che oggi si chiama il Nuovo Testamento, un insieme di 27 scritti che comprende, oltre ai quattro vangeli, gli Atti detti «degli Apostoli», numerose epistole e l’Apocalisse. Ci vorranno secoli perché si arrivi a questa relativa omogeneità e ci vorrà il concilio di Trento, nel XVI secolo, perché essa venga resa ufficiale dalla Chiesa cattolica, anche se il corpus del Nuovo Testamento da almeno un millennio si era ormai assestato.
E degli altri cristianesimi che cosa è stato? La dottrina ufficiale ha operato in modo da cacciarli progressivamente nell’ombra fino a farli dimenticare, quanto meno dalla gran massa dei fedeli che di tante cose non hanno mai inteso parlare. L’opera di rimozione è stata poi completata con un’altrettanto efficace sostituzione. La dottrina ufficiale ha cioè riscritto e divulgato la storia iniziale, come se tutte le diverse interpretazioni non fossero mai esistite, come se le opinioni diventate appunto «ufficiali» fossero state da sempre quelle ereditate direttamente dall’insegnamento del fondatore Gesù. È nata così la «teologia», cioè la branca del sapere che studia la divinità e orienta la fede dei credenti.
È stato un bene o un male che le cose siano andate come sono andate? La domanda, è ovvio, appare quasi priva di senso. La pongo solo perché consente di affermare che, come sempre, il risultato conclusivo è stato un insieme di bene e di male. Di certo, un bene dal punto di vista della Chiesa che, grazie a una dottrina via via consolidata, e poi sagacemente adattata alle circostanze e ai tempi, ha potuto rafforzare e mantenere il suo potere sia spirituale sia politico; un male perché quella stessa solidità è all’origine di tutte le crudeltà e del sangue sparso nel corso dei secoli in nome di un Gesù che non ne è affatto responsabile. Un male anche perché, con i vari cristianesimi delle origini, è stata rimossa pure la possibile ricchezza che le tante interpretazioni avrebbero potuto portare. Ma le ideologie, come sappiamo, non ammettono deroghe e la sopravvivenza di una Chiesa obbedisce a regole che non sono molto diverse da quelle di una qualunque altra istituzione umana.
Forse vale la pena ripetere che, allo stato iniziale, non esisteva un solo cristianesimo. C’erano tanti diversi modi di sentirsi cristiani e non sempre concordavano fra loro sull’essenziale.
Anzi, spesso questi modi confliggevano. Ho accennato alla polemica di Paolo con una frangia cristiana a Corinto, quindi in una comunità che lui stesso aveva fondato. A maggior ragione c’erano conflitti fra espressioni diverse del cristianesimo.
Dovremmo forse fare qualche esempio, anche per capire meglio a quale livello si verificassero questi contrasti d’opinione.
Un esempio cruciale è la figura di Cristo. Fra il I e il II secolo, in molti scritti Cristo è una divinità di secondo livello, più simile al demiurgo platonico che non al Figlio di Dio, seconda persona della Trinità, come verrà stabilito fra il concilio di Nicea nel 325 e quello di Calcedonia nel 451. Nei testi giudeo-cristiani la figura di Cristo appare simile a quella di un angelo, glorioso certo, ma in quanto angelo creatura, non figliolanza. Spesso, inoltre, in quegli stessi testi non è affatto chiara la distinzione tra il Figlio e lo Spirito, che tendono a sovrapporsi.
O ancora, presso una delle frange certo importanti del movimento, quella degli ebioniti, si continuava a osservare la Legge giudaica, mantenendo rigoroso il carattere radicale della propria fede; i suoi membri venivano anche definiti con sprezzo i «poveri», termine che traduce appunto la parola ebraica «ebioniti», poveri, però, non in senso sociale, ma psicologico: una sorta di mentecatti che favoleggiavano su irreali scenari apocalittici, e che avrebbero potuto, secondo i loro avversari, essere pericolosi se non fossero stati semplicemente risibili. Oltre che nella teologia, le differenze si colgono poi anche nel rito, nel culto, nel modo di vivere, nel ruolo delle donne, nel carattere delle adunanze, eccetera.
Anche a questo abbiamo già accennato, ma sempre in termini piuttosto vaghi. Si può fare qualche esempio di questa molteplicità?
Negli Atti degli Apostoli si racconta che, quando Paolo arriva a Efeso, trova dei discepoli e chiede loro: «Avete ricevuto lo Spirito santo quando siete venuti alla fede?». Quelli rispondono che non hanno mai sentito parlare dello Spirito santo. Dicono di aver solo ricevuto il battesimo di Giovanni. Paolo allora li battezza nuovamente «nel nome del Signore Gesù» e a quel punto, ricevuto lo Spirito santo, loro cominciano a parlare lingue diverse e a profetare (At 19,1-7).
Alle origini, insomma, le diversità sono clamorose, riguardano addirittura il sacramento del battesimo, che è un punto cardine della vita cristiana, l’atto che a essa introduce.
Paolo, nei rari casi in cui lo fa, battezza sempre e solo «nel nome del Signore Gesù» ignorando, o comunque non utilizzando, la formula trinitaria che viene invece impiegata nella chiusa del Vangelo di Matteo: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo» (Mt 28,19).
Potrei poi ricordare i contrasti fra Roma e l’Asia sulla data in cui celebrare la Pasqua, oppure quelli fra la stessa sede romana e l’Africa, ancora sulla somministrazione del battesimo. Sono tutti casi in cui si arriva quasi alla rottura definitiva fra le varie Chiese. Solo circostanze esterne o autorevoli mediazioni riescono a scongiurarla.
Uno dei conflitti più accesi e più importanti si verifica fra Paolo e le «tre colonne» della comunità di Gerusalemme: Giacomo, Giovanni e Pietro. Una disputa per certi aspetti addirittura violenta, nella quale si mescolavano ragioni di dottrina e altre molto concrete, compresi problemi di finanziamento. Se ricordo bene, il compromesso alla fine si raggiunse anche sulla promessa di Paolo di andare in giro a raccogliere fondi per quella comunità. È possibile fare una cronaca, dal punto di vista storico, di questo drammatico confronto? Che successe a Gerusalemme? Quali erano le ragioni del contrasto?
Siamo presumibilmente alla fine degli anni Quaranta del I secolo. I protagonisti sono coloro che Paolo stesso definisce «le tre colonne» della Chiesa di Gerusalemme e cioè: Giacomo, Giovanni e Pietro. Una prima notazione, oggi diremmo sociologica, è che la principale delle colonne non è né un apostolo né un evangelista: è Giacomo, fratello del Signore, personaggio di cui abbiamo attestazione nei vangeli e nello stesso epistolario paolino. È, cioè, un membro della famiglia di Gesù, uno di coloro che, insieme con Maria, la madre, ritenevano che Gesù fosse pazzo, per cui si erano messi in viaggio per tentare di riportarlo a casa (Mc 3,20-21). Dal punto di vista umano e storico, sapendo com’è andata a finire, avevano tutte le ragioni di temere e di cercare d’intervenire.
Quando lei definisce Giacomo «fratello del Signore», sa bene di contraddire un insegnamento ufficiale, anzi un dogma della Chiesa che fa di Gesù un figlio unigenito.
Unigenito di Dio, non unigenito di Maria. Che la mia ricostruzione si discosti dal dogma potrà eventualmente essere rilevante in altra sede, non in questa. Gli storici procedono con mezzi limitati e sempre verificabili. La storia, peraltro, non cerca la verità, ma solo un’approssimazione alla verità. Definendo Giacomo «fratello del Signore» non faccio che riferirmi alle numerose attestazioni in questo senso del Nuovo Testamento: Gesù aveva quattro fratelli e un numero imprecisato di sorelle (Mc 6,2-3). Del resto, nella tradizione patristica, sono molti gli autori che non hanno alcuna difficoltà ad ammettere che questa è la situazione nella famiglia di Gesù.
Quello che viceversa può sorprendere è che Giacomo, da un iniziale atteggiamento d’incomprensione del messaggio del fratello, giunga nel volgere di pochissimi anni a un ruolo preminente nella comunità dei credenti in Gesù Cristo. Ciò si spiega con il «califfato ante litteram», vale a dire l’uso orientale (già presso gli ebrei, poi anche presso i musulmani) di trasmettere il potere religioso per via familiare.
Ha appena detto che un altro dei protagonisti è Giovanni. Quale Giovanni?
Giovanni è verosimilmente uno dei Dodici, mentre su Pietro non ci sono dubbi, è proprio il Pietro al quale tutti pensano. Le cosiddette «tre colonne» sono i dirigenti di una cospicua corrente del cristianesimo nascente, la giudaico-cristiana, che riteneva non esservi soluzione di continuità fra ebraismo e cristianesimo. Per loro, la fede nella messianicità di Gesù non comportava il taglio delle radici giudaiche. Pensi che uno storico del II secolo, quindi di poco posteriore agli eventi, Egesippo, racconta che Giacomo aveva la pelle delle ginocchia simile a quella di un cammello a furia di stare inginocchiato nel Tempio. La notizia, vera o no, intende segnalare la sua assiduità al Tempio, cioè la continuità con le norme e le regole dell’ambito giudaico.
Sappiamo che lo scontro fra Pietro e Paolo fu durissimo, come lo stesso Paolo apertamente scrive in alcune sue lettere, facendo capire di aver messo le cose a posto. Il motivo del dissidio è dunque questo: quale doveva essere il peso, l’importanza, delle radici ebraiche nel nuovo movimento.
Il punto è che Paolo vuole portare a tutti, anche a chi non proviene dal giudaismo, il nuovo messaggio. Ma ciò comportava problemi non indifferenti. Che cosa chiedere a coloro che intendono far parte della comunità e che non sono ebrei? Quale tipo di obbedienza? Quali riti? Le «tre colonne» rispondevano: è sufficiente che osservino, insieme con la circoncisione, alcune fondamentali norme di purità nel culto. Come abbiamo già visto, Paolo non è d’accordo. Ciò che salva, nella sua concezione, non è la circoncisione né l’osservanza formale della Legge, ma la fede in Gesù Cristo. Questa, fra l’altro, è la preistoria di un conflitto che nell’Europa del Cinquecento spaccherà la cristianità. È Lutero a riprendere l’assoluta centralità della fede, ma le radici della sua posizione sono già presenti in questa prima disputa. Il dilemma è se si debba essere salvati attraverso le opere oppure attraverso la fede. Paolo trova un brillante compromesso affermando (Lettera ai Galati) che le opere sono sostanzialmente il frutto della fede. Anche se l’apostolo intende le opere non nel senso ebraico di osservanza della Legge, ma come comportamento, oggi diremmo come «etica».
Colgo il doppio riferimento a Paolo e a Pietro per porle un’altra domanda. Nel capitolo 13 della Lettera ai Romani, Paolo esorta i cristiani a obbedire anche alla legittima autorità civile, nel rispetto dell’ordine voluto da Dio. A questa esortazione è stata spesso contrapposta la diversa posizione di Pietro che in Atti 5,29, al sommo sacerdote che ordina agli apostoli di smettere ogni predicazione, risponde: «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». Su questo passo si è fondata la disobbedienza cristiana al potere politico, compresi vari movimenti pacifisti e libertari. Non c’è contraddizione fra i due precetti?
Sicuramente c’è e possiamo cercare di capirne la ragione. Quanto al celeberrimo passaggio paolino secondo cui «ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite» (Rm 13,1), si è sostenuto trattarsi di un’interpolazione tardiva, introdotta per cercare una mediazione fra cristiani e autorità. Vero però che la formula, presente anche altrove nel Nuovo Testamento, è stata uno dei pilastri su cui si è fondata la storia del cristianesimo. Basti pensare alla dottrina luterana dei due regni, vale a dire, in parole poverissime, alla teoria della separazione degli ambiti di giurisdizione del potere politico e di quello ecclesiastico. Lei stesso ha ricordato, però, che questa concezione altrove viene contraddetta. Per esempio nella terribile visione dell’Apocalisse di Giovanni, in cui la Bestia che sale dal mare è una mostruosa effigie del potere politi...