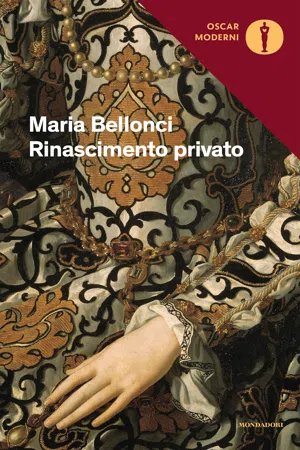
- 504 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Rinascimento privato
Informazioni su questo libro
Meditato per vent'anni, Rinascimento privato è il libro più bello, più intenso, più "vissuto" di Maria Bellonci, originalissima personalità culturale e letteraria del Novecento italiano, fondatrice tra l'altro del prestigioso premio Strega. In queste pagine si racconta la vicenda di Isabella d'Este, divenuta marchesa di Mantova dopo il matrimonio con Francesco Gonzaga; non di una semplice per quanto raffinata biografia si tratta, però, quanto di un vero e proprio romanzo: sia per la presenza di alcuni personaggi totalmente inventati - come Robert de la Pole, corrispondente del re d'Inghilterra e innamorato platonico di Isabella -, sia soprattutto per la qualità della scrittura, che sembra avvolgere in una sorta di abbagliante pulviscolo ogni figura e ogni fatto storico. Un libro denso e sontuoso, fatto di azione e meditazione, di passioni gridate e di silenzi, di storia e di destini. Protagonista assoluta è lei, Isabella, che ormai alla soglia dei sessant'anni rievoca la propria vita da quando, sposa sedicenne, giunse a Mantova e in un periodo tra i più tumultuosi e fulgidi della nostra storia, a cavallo tra Quattro e Cinquecento, resse le fila del piccolo stato costruendo attorno a sé una corte di ineguagliato splendore.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
VII
Per non morire di malinconia
«Ho fatto primiera» esclamai ridendo forte. «Guardate qui, ho quattro carte di seme diverso, chiarissime. Datemi le vostre poste: vinco tutto.»
Radunai i denari delle giocate con un colpo di mano circolare e di nuovo risi: davanti a me si era formato un monticello di piccole monete di quelle che chiamiamo da elemosina. Tutti, nel barcone trainato lentamente lungo la riva del canale da muli robusti, stavano interdetti a scrutarmi.
«Che vi prende?» domandai.
Rispose mia cugina Camilla:
«Isabella, è la prima volta che vi vediamo ridere da quando siamo in viaggio. Dio vi benedica.»
«Non possiamo più giocare, non abbiamo più monete» si lamentò Domenico Venier l’ambasciatore veneziano «e qui nessuno ci cambierà l’oro.»
«Pirro, cambiate l’oro all’ambasciatore» dissi a Pirro Donati. «A Ravenna avete fatto moneta spicciola. Avanti, signori, riprendiamo il gioco.»
Prima di riportare lo sguardo sulle carte distribuite dal mazziere avevo raccolto il fulgore giallo dei campi esalato dall’immensa pianura del Po fitta di grano tra poco maturo. Tra qualche ora saremmo arrivati a Ferrara: e di lì, a casa. Ben presente al gioco, seguivo in me quel palpito ilare che mi legava istantaneamente alla realtà della mia giornata. Del mese di maggio, dopo il giorno tredici, serbavo un ricordo frantumato: ad Ostia ci eravamo fermati tanti giorni – non sapevo numerarli – nell’alloggio scomodo della Rocca, quasi senza mangiare perché gli abitanti del luogo tenevano nascoste le provviste temendo le scorrerie dei lanzichenecchi. Avvisato da qualcuno, Ferrante ci aveva mandato da Roma, su uno zatterone, pane farina olio e vino. E finalmente il cielo si era stancato di versare pioggia.
Mi trovavo in nave e approdavo a Civitavecchia. Non so come decisi di andare per terra affidando il nostro bagaglio, ceste inzeppate di argenti, vesti, ornamenti, libri, ad una nave che, scortata dalla galea genovese, lo avrebbe sbarcato a Pisa. Sostammo a Corneto e di lì avanti verso Viterbo, e per la via di Orvieto e Perugia fino a Cagli a Pesaro a Ravenna. Indossavo solo panni da cavalcare, pativo senza sofferenza le fatiche del viaggio per l’asperità dei monti e della mutevole stagione, e solo alle fitte di stanchezza mi accorgevo di essere viva almeno in una parte di me. L’altra parte rimaneva in una zona muta alla quale non arrivavo: né mi era possibile ricostruire una mia integrità.
A Ravenna mi raggiunsero le prime folate di coscienza. In barca, avevo riso per il giro fortunato di quel gioco di primiera che sempre mi ha appassionato fin da bambina: e via via più chiaramente mi sorpresi a chiedermi, sgomenta, che cosa avessero fatto intorno a me, donne, ragazzi, gentiluomini, la scorta di quasi cento cavalli durante un intero mese. Mi pareva di essere andata avanti a spinte meccaniche: dovevo essere apparsa insensata se al mio riso tutti avevano ringraziato Dio come per un prodigio. Avvertivo uno stimolo che mi veniva dal ripetere nomi degli itinerari che a questo punto del viaggio suonavano consueti: per canale a Ferrara e poi per fiume dalla Stellata a Sermide, a Govèrnolo, a Mantova; sogguardai il mio abito da cavalcare di lanetta sottile grigia a piccoli galloni dorati; non avevo altro con me salvo la borsa dei denari, il velo bianco e l’involto con la berretta cardinalizia di Ercole. E mi rendeva leggera sentirmi spoglia d’ogni altro bene.
Avvistai Ferrara dalle quattro torri del Castello, e mi venne incontro una cavalcata guidata da Ercole d’Este il primogenito di Alfonso; in quel momento mio fratello era a Milano. I cavalieri ci scortarono dagli argini, levando ogni tanto le lance imbandierate in segno di saluto. Trovai la mia Margherita Cantelma e Alda Boiarda sulla passerella con molti gioiosi accoglimenti. Dormii nelle mie solite camere di Porta Leone e tutto della mia infanzia mi rifluì in petto. Non mi ricordo chi, al momento di ripartire il giorno seguente, mi sussurrò che a Sermide mi avrebbe riverito la Boschetta.
Non si presentò la Boschetta a Sermide: ma un intero paese stava sugli argini agitando fronde augurali. E così fui in territorio mantovano e subito scrissi una lettera ai miei figli e disposi dove e come dovevamo incontrarci: a Govèrnolo avrei consegnato ad Ercole quella berretta cardinalizia che mi era costata tanta passione. Invece Ercole, rivestito di porpora, grave e felice, lo vidi prima, alla Stellata, e raggiungemmo insieme Federico a Govèrnolo: là su una piazzetta di terreno battuto presso il corso del fiume, al mio secondogenito inginocchiato posi sul capo la berretta. Nessuno di quanti erano presenti si ritenne dal lacrimare di vera letizia. Il mio cardinale accompagnato da Federico andò in Duomo con tutta la nobiltà: ed io a Sant’Andrea per venerare le reliquie del Sangue di Cristo non potendo comparire ad una cerimonia solenne col mio abituccio polveroso.
Il popolo sembrava che mi amasse più teneramente così vestita: tutti giubilavano, altro non si udiva se non suoni di campane e voci che chiamavano «Isabella, Isabella». Tanta era la gente che si affollava a toccarmi la mano che Jacopo Tridapale, nostro gentiluomo, esclamò che gli pareva d’essere al giubileo della meschina Roma: qualche cosa di convulso mi percorse per un istante ombrando la luce viva. Proprio allora qualcuno mi salutò a nome di mia figlia Eleonora: e per la prima volta nella mia vita parlai di lei come diletta alla mia anima.
Trascorrevo da un viso all’altro di coloro che apparivano vicino alla testa del mio cavallo per applaudirmi: mai s’era vista una simile felicità pubblica. Il mio miracoloso salvataggio si proponeva quale esempio di una tremenda avventura felicemente conclusa alla quale ognuno anche da lontano aveva partecipato; era esaltante il trionfo che univa me e i miei figli dinnanzi al popolo, né mai avrei dimenticato, di Federico e di Ercole, quell’inchinarsi umilmente insieme davanti a me sulla piazzetta di terra battuta a Govèrnolo, diversamente grati e adoranti. Eppure una stanchezza non tanto fisica quanto morale mi spossava come per una convalescenza pesante. Ero felice di non dovermi arrampicare per le scale entrando nelle mie camere terrene di Cortevecchia: fresche, profumatissime per i boschetti di tigli disposti fittamente intorno, mi accolsero: ma non avevo più l’animo a nulla, né a ridere né a piangere.
Quando mi svegliai un biancore un po’ sull’indaco scialbava il cielo. D’istinto scendo dal letto pianissimo per non destare le mie donne che riposano nella stanza vicina, prendo una lanterna dallo scaffale e l’accendo. Attraverso l’appartamento, tutta la loggia e sono nel giardino segreto. Appena appena discerno le cupolette degli alberi e l’albicocco acceso dei suoi frutti forse maturi. Mi sorride lo spazio inquadrato dalla geometria del muro. Che dolce aria. Alzo la lampada rientrando e nel corridoio passo in rassegna le figurazioni delle mie imprese. Tento un gioco con me stessa: ad ogni figurazione o motto un commento per mio uso momentaneo. Le pause musicali: la pazienza è un angelico esercizio che può diventare demoniaco. Ventisette: vinte le sette, non si finisce mai di vincere la congiura intorno a noi. Il candelabro ad una sola luce, Sufficit unum: e quell’uno posso essere io? Nec spe nec metu: la speranza è un segreto slancio più inebriante se si finge freddo. Mentre sto scherzando con me stessa avverto un rumore e non ho bisogno di domandarmi chi è. Il viso bianco e affettuoso viene avanti.
«Pirro!»
«Signora mia, siete voi? Il guardiano di notte mi aveva avvisato che un lumino vagava da queste parti e mi sono buttato giù dal letto. Così sola?»
«Giocavo, Pirro, giocavo un po’ per ristabilirmi in equilibrio. Entriamo nella Grotta. Vediamo dopo due anni e più di lontananza come stanno i miei strumenti musicali. È possibile che ad alcuni si dovranno cambiare le corde almeno in parte.»
Pirro, amabilmente divertito, mi fa strada e apre gli sportelli a tarsie dei miei armadi. Ritrovo il mio flauto, e un flauto dolce, provo un liuto, un’arpa, e due viole. Bisognerà chiamare l’accordatore perché sento qualche dissenso negli strumenti. Mentre li rimetto delicatamente a posto la mia mano tocca un quadretto. Lo tiro fuori, curiosa.
«Maria» esclamo, «Maria Paleologa.»
È un avviso, un richiamo? Maria Paleologa, la sposa di Federico, la figlia di Anna d’Alençon, bella come la madre, incoronata di fiori come una piccola ninfa, il viso ovale dagli zigomi alti. Che pazzia fece Federico a sposarla mentre il contratto escludeva per il momento le nozze. Fu lei, Anna, a volere sua figlia sposa a otto anni, o un capriccio di Federico? E questo sposalizio vale anche oggi; Federico è legato a Maria, è suo marito per la Chiesa.
Veloci come daini i miei pensieri fuggivano, discordanti, da quell’immagine, e ad essa tornavano per forza d’attrazione.
Ho pronunciato il nome di Maria Paleologa e dietro di lei si disegna il viso di un nostro oratore e ambasciatore: Giovan Francesco Capi, detto il Cappino, quell’attento segaligno di pelle chiara molto legato a famiglie dell’alto nord essendo lui stesso originario di Novara: uomo nostro, dei pazienti e veridici. Mi fa resoconto di un suo viaggio a Casale Monferrato avvenuto alcuni mesi dopo il mio arrivo a Mantova. Penso che proprio il ritrovamento di quel ritrattino la prima notte del mio ritorno a casa sia stato un segno imperativo. “Di novembre avevo ripreso la strada di Casale”, così inizia a raccontare il Cappino con quel suo modo a scivolo pacato da informatore segreto. Al Castello fu ricevuto in una sala foderata di drappi dove in un gran letto a cortinaggi stava disteso un ragazzo di tredici anni smunto e impaziente: una governante gli rincalzava le coperte. Sua madre Anna d’Alençon, vivace e briosa cercava di consolarlo.
«Il medico dice che fra poco vi potrete alzare, figlio mio. Siete contento?»
In quel momento si accorse del mio oratore.
«Signor Cappino, giungete adesso da Mantova? Siamo felici di vedervi, lo sapete.» Si volse alla figlia che era presso la finestra e la chiamò: «Maria! C’è il signor Cappino, l’ambasciatore del tuo sposo. Sentiamo che cosa ha da dirci.»
Maria si staccò dalla finestra e avanzò con passo reticente senza parlare. Una porta interna si aprì di colpo e apparve una giovinetta diciassettenne, Margherita, la sorella minore di Maria. Disse a voce alta:
«Sì, l’ho finita, proprio finita! Venite Maria, signora madre venite anche voi, vi prego.»
Scorgendo il nostro Cappino, la ragazza lo salutò lietamente. Le tre donne sparirono nella stanza vicina e lasciarono tutto solo l’oratore col fanciullo che, silenzioso, abbassava le palpebre sul viso pallido. Dopo qualche minuto due ragazze di camera rientrarono reggendo a braccia tese una coperta nuziale di broccato paglierino ricamata di sete colorate e fili d’oro e d’argento: gli stemmi dei Paleologi e dei Gonzaga si intrecciavano al centro e agli angoli in un rameggiato disegno a punto arazzo. Dietro il trionfante emblema stavano le tre Paleologhe. Anna d’Alençon indicò la coltre al Cappino e a Bonifacio.
«Osservate che lavoro ha compiuto la mia Margherita con le sue donne. È la più bella coperta nuziale che si sia mai vista. E guardatela anche voi, Maria: non girate il capo, è vostra.»
Maria parlò svelta e ironica:
«È bella, bellissima, vera coltre nuziale; ma io da undici anni non ho mai avuto vicino il mio sposo neppure per un giorno.»
Anna rispose:
«Uno sposo come Federico Gonzaga bisogna meritarselo, figlia mia. Non è soltanto un uomo valoroso, cortese, amabile, ma qualche cosa di più. Somiglia alla sua impareggiabile madre una delle grandi donne del nostro tempo. E per quale ragione credete che vostro padre di felice memoria ed io avremmo scelto lui fra tanti principi che vi chiedevano in moglie? Federico è il migliore di tutti, diverso da tutti: è unico.»
Margherita intervenne da giovinetta impulsiva e ardente:
«Quando venne qui a Casale a sposarvi era tutto vestito di bianco e argento con i capelli ramati lunghi lunghi: si mostrava sempre festoso, sorridente. Vi ricordate, Maria, quando vi dette l’anello e vi chiamò la sua bella sposina?»
Maria s’impazientì.
«Non so come fate a ricordare tante cose, Margherita! Avevate solo sei anni.»
Anna rise.
«Margherita ha una fantasia vivace: è ancora una bambina: per lei Federico è una straordinaria favola da ripetere. Ma voi, cara figlia, pensate al futuro. Mantova è una realtà, una corte piena di vita. Ci sono poeti, musici, pittori. Ogni giorno si festeggia e s’inventa qualche cosa di nuovo. Federico mi ha confidato che farà costruire una palazzina sul lago per abitarla voi due soli. Il progetto sarà di quel gran maestro romano, Giulio Pippi, famosissimo: la palazzina sorgerà nei giardini presso il Castello verso la riva.»
Maria insorse:
«Parole come sogni, madre mia. Mi ripetete le stesse cose da anni. Che sposa sono io? Una sposa di carta, di dispacci, di documenti e di firme, non di fatto. Federico mi aveva promesso di mandarmi a prendere quando avessi avuto sedici anni e ne sono già passati tre. E il signor Cappino che ambasciata mi porta oggi? Dal suo volto capisco che non andrò a Mantova nemmeno questa volta. Tutto ci divide.»
«Tutto vi unisce!» proruppe Anna. «Il volere del papa, la benevolenza dell’imperatore, il consenso del nostro parente il re di Francia, il desiderio del popolo mantovano e l’affetto vero della marchesa Isabella. Lei è la vostra alleata migliore.»
Maria replicò ancora:
«L’imperatore, il re di Francia, il papa, la madre, il popolo. Lo vedete? Sono gli altri a desiderarmi, sono gli altri che vogliono costringere lui. Ecco perché Federico non mi ama. Una cosa sola mi premerebbe: che egli venisse a me in uno slancio di cuore. È mio sposo, mi avete comandato d’amarlo: ed io vi obbedirò sempre.»
Anna posò lo sguardo sulla figlia: esprimeva una caparbia tenerezza:
«Adesso faremo parlare il signor Cappino, e sentiremo che cosa deve dirci. E tu non perdere la fiducia. Federico verrà presto, sta’ certa: sono ombre false le tue. Un giorno non te ne ricorderai più. Signor Cappino, vi prego, dite.»
Il Cappino tentò un tono disinvolto:
«Signora, il marchese Federico vi ama e vi rammenta sempre. Ma ha ragione vostra madre, dovrete aver pazienza. Il mio signore in questo momento è gravato da pesanti impegni militari e ancora non può fissare la data per venire a Casale.»
La marchesa Anna aggrottò la chiara fronte; ma fu un istante.
«Verrà» affermò decisa. «Non temere, Maria, verrà.»
Inatteso mi giunse l’invito. Mio figlio entrò nelle mie stanze e con il suo fare da lusingatore mi chiese con insistenza di assistere la sera di Natale alla breve rappresentazione degli animali parlanti che alcuni suoi famigli preparavano nella stalla della Motteggiana la bella villa gonzaghesca presso il Po, di fronte a Borgoforte. Si trattava di una rappresentazione molto molto antica che si tramandava di generazione in generazione dai contadini, una specie di rito che aveva del teatrale e del magico. Non sapevo che pensare, e per saperlo dissi di sì. Sarei andata in carretta coperta con un gruppetto di mie donne tutte inebriate dalla festa insolita. Federico pareva felice del mio consenso.
Di sera mentre il nevischio passava radente sulla campagna rigando diagonalmente il terreno, ci ritrovammo alla Motteggiana. Nel buio della notte scura appena s’intravedevano le elegantissime proporzioni dell’edificio di Luca Fancelli e i comignoli che sembrano lavorati all’orientale e fanno di questa dimora un luogo di favola riveduta dalla grazia dei numeri. Mio figlio ci aspettava e aveva fatto preparare vino speziato e il consueto sorbir. Poi scendemmo nella stalla bella e ampia, simile ad una navata bassa di chiesa, e prendemmo posto di fronte ad una mangiatoia addobbata come una scena, con drappi di broccato e un tappeto sulla pedana. Contadini, servi, staffieri e genti di fatica erano seduti sulle panche e sulle balle di fieno disposte in giro. Nella mangiatoia intorno ad un Bambino Gesù di legno stavano quattro putti con teste da maschera, figurando il gallo, il bue, l’asino e la pecora. Alcuni musici della corte di Federico suonavano canzoni popolari, nenie natalizie con variazioni semplici da cantare facilmente. Cessata la musica, cessati i canti, i bambini avanzano alla ribalta. Il gallo fa uno squillante chicchirichì e annuncia:
«Puer natus est, puer natus est.»
Subito un altro fanciullo facendo una voce più grave e quasi muggendo interviene:
«Uuhm, uuhm, ubi? Ubi est?»
È la volta della pecora:
«Beehee, beehee, a Betlèmme. A Betlèmme!»
E attacca l’asino con un sottofondo di raglio:
«Iha! Iha! Andemus, andemus...»
Su questo intrecciarsi di voci animalesche i bambini alternano i movimenti con graziosa perizia. Alla fine contemporaneamente riuniscono i loro vari chicchirichì uuhm, uuhm, beehee, beehee, iha, iha.
«Gesù è nato, Gesù è nato!» grida un coro celato nella stalla, e tutto il pubblico fa eco festosamente...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Rinascimento privato
- Maria Bellonci
- RINASCIMENTO PRIVATO
- I. Misura di giovinezza
- II. Coraggiose paure
- III. Armata di solo scudo
- IV. Fuggire per tornare
- V. Federico anima mia
- VI. Roma Roma
- VII. Per non morire di malinconia
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Rinascimento privato di Maria Bellonci in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Letteratura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.