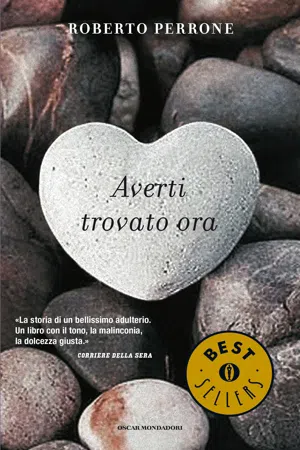![]()
Il mio primo procuratore si chiamava Mimì Cascella.
Il diminutivo Mimì non sapevo da dove venisse. Qualche volta ero stato attraversato dalla voglia di frugare nel suo portadocumenti e guardare la patente o la carta d’identità per leggere il nome vero, ma se mi avesse sorpreso sarei finito malissimo. Nessuno lo sapeva e Mimì non ci teneva a farne conoscere in giro l’origine. Quando qualcuno, avventato, provava a chiederglielo, lui, dopo aver scrutato con disprezzo il malcapitato, rispondeva: «Da Mimì metallurgico ferito nell’onore».
Non sapevo da dove venisse il nome, ma sapevo da dove veniva Mimì. Era nato ad Acquaviva delle Fonti. Questo gli piaceva dirlo, perché a Mimì piacevano le frasi storiche, le sentenze e anche gli epitaffi, sebbene non conoscesse il significato della parola. Del paese dov’era nato diceva: «Vengo da un posto di merda con un nome bellissimo». Siccome non ci sono mai stato, non posso dire nulla sulla prima parte della sua affermazione – magari è un paese bellissimo, ho sempre in mente di andarci – ma sulla seconda posso e devo ammettere che ha ragione lui.
Mimì mi prese che ero poco più di un ragazzo. Lui già allora aveva un’età indefinita che nascondeva dietro l’incredibile grassezza.
Eravamo alla fine degli anni Novanta e Mimì aveva la procura di tanti giovani come me, soprattutto del Centro-Sud. Era nell’ambiente da molti anni.
Quando mio padre mi portò da lui, dopo la relazione favorevole di un osservatore, fui impressionato dalla sua stazza. Era seduto dietro la scrivania dell’ufficio, in un palazzo del quartiere Prati, a Roma. L’ufficio era al secondo piano e, dopo averlo guardato, mi chiesi come riuscisse a entrare nell’ascensore, un vecchio modello in legno. Indossava un enorme vestito di lino bianco. Il lino gli piaceva. «Mi tiene fresco» diceva. Ne aveva una decina, di tutti i colori e, scoprii in seguito, se li faceva confezionare da un sarto di Napoli che, una volta al mese, saliva sul treno a Mergellina e veniva a Roma per prendergli le misure.
Mimì non si alzò quando io e mio padre entrammo, al seguito della sua segretaria. E neanche ci porse la mano.
«Non è scortesia» ci spiegò dopo che ci fummo accomodati, «ma stando acquattato qua dietro sembro più magro e poi mi sudano le mani. L’immagine è quasi tutto, lo dice anche lui, il mio idolo, che è tale anche se non mi fa invitare ai suoi programmi sportivi perché dice che sono troppo grasso.»
E indicò una foto di Silvio Berlusconi che teneva in cornice sulla scrivania.
Io non ero un ragazzo timido e neppure ignorante. Ormai i calciatori si conquistavano tutti – chi più, chi meno – un minimo di istruzione. Facevo il penultimo anno del liceo scientifico e non ero l’ultimo della classe. Studiavo e leggevo, qualche libro, i giornali, non solo quelli sportivi. Sapevo chi era Silvio Berlusconi, naturalmente, ed ero abbastanza smaliziato da farmi venire dei dubbi su un tizio che si teneva la sua fotografia sulla scrivania, come fosse un parente. Non per motivi politici però, se avessi visto quella di Prodi, i dubbi mi sarebbero venuti allo stesso modo.
Mimì se la rise, osservando la mia espressione.
«Tranquillo, guagliò, non sono fesso e neanche ricchione, ma questo di calcio ne capisce. Quasi come me. Lo tengo per questo.»
Rimasi con Mimì quattro anni, poi lo mollai. Lui non se la prese, se l’aspettava. Gli piaceva lavorare con i giovani, portarli alle soglie del successo.
«Io lo so, tu mi lascera…» canticchiava ogni tanto.
Aveva una bella voce, tonda, piena, intonata. Conosceva centinaia di canzoni a memoria, sosteneva di avere un repertorio da “Rabagliati minore”. Io ero un ragazzo di fine millennio e non sapevo chi era Rabagliati così, ogni volta che lo citava, per prenderlo in giro, gli chiedevo: «Ma chi, il terzino del Mantova?».
Mimì mi mandava a quel paese.
Io ero nato in un piccolo paese del Lazio, proprio al confine con la Campania. E l’accento dalle nostre parti era già decisamente campano. Il mio paese non ha un bel nome, quindi non mi piace ricordarlo, ma da quando ho segnato il gol decisivo nella finale tutti lo conoscono e mia nonna mi racconta che adesso vengono pure i turisti e si fermano a fotografare il cartello spelacchiato che s’incontra sulla provinciale.
Perché mi è venuto in mente Mimì?
Perché ogni tanto mi piace ricordare un bel periodo della mia vita, quando ero un ragazzo e giocavo ancora a pallone per divertirmi. Certo, con Mimì lasciai la squadretta di dilettanti dove stavo ed esordii in serie B, con l’Ascoli, a diciassette anni. Da lì ne ho fatta di strada.
No, non è vero che mi piace ricordare. Mimì mi viene sempre in mente perché, in questa storia, c’è una sua battuta che mi ronza in testa, una delle sue frasi a effetto, una delle sue sentenze inappellabili. Questa, tra tutte, mi pare la più esatta che sia stata detta su di me.
Mi ricordo anche quando la disse: una sera che avevo fatto lo scemo ed ero scappato dal ritiro. Venne lui a recuperarmi nella casa al mare della ragazza di Giulianova con cui stavo allora. Stare? Via, ci si divertiva e basta. Io ero un calciatore e lei una ragazza di provincia che cercava un’opportunità e un bel ragazzo. Non era bellissima, ma sessualmente era fuori dal comune. O almeno io la vedevo così. Per questo quella notte ero scappato. L’allenatore, un veneto pignolo che faceva controlli a sorpresa girando con la pila nei corridoi dell’albergo, mi aveva scoperto. Però si trattenne dal cacciarmi dalla squadra perché l’indomani avevamo una partita importante e lui mi voleva a tutti i costi in campo. Perciò chiamò Mimì e gli disse di recuperarmi, ovunque fossi, prima che scoppiasse il caso. E Mimì partì da Roma con la sua Mercedes bianca degli anni Sessanta, un diesel che faceva un rumore d’inferno e inquinava più di una petroliera alla deriva, e mi beccò mentre mi rotolavo con la ragazza sulla spiaggia. Era giugno, il campionato era alla penultima giornata. Una leggera brezza marina rendeva il caldo sopportabile. Avevamo fatto il bagno nudi e mentre ero abbracciato a lei sulla sabbia, mi sentii afferrare per un orecchio e trascinare via, di peso, nudo com’ero. Mi sentii un verme. Una volta in macchina, Mimì tirò giù il finestrino e si accese un Partagas. Io me ne stavo con gli occhi chiusi, pieno di rabbia e vergogna.
«Guagliò, mi hai fatto venire fin qui da Roma e non va bene. Io tengo o core ’ngrato, nel senso che mi fa male se lo sforzo.»
«Mi dispiace Mimì…»
«Sta’ zitto. Ti dico solo questo: tu sei forte, hai talento, sei un’ala destra di quelle che qui non se ne fanno più. Hai scatto, dribbling, tiro, visione di gioco. Rispetto ai tuoi colleghi, hai pure uno straccio di cultura. Puoi diventare qualcuno. Non ti buttare via. E poi ti dico un’altra cosa: è inutile che fai il fesso con queste zoccole. Primo, perché di queste quando sarai famoso ne avrai a quintali, e poi perché io ti conosco, io ti vedo» e cominciò a fare la voce strascicata da mago mentre con le mani faceva finta di guardare in una sfera di cristallo, uno dei suoi numeri preferiti, «tu, da questo punto di vista, non stai nei canoni del calciatore medio.»
Canoni? Ancora adesso mi ricordo lo stupore per quei vocaboli che Mimì, a sorpresa, estraeva come conigli bianchi da un cilindro.
«Ah no?»
«No, tu sei uno di quei fessi che s’innamora. Potrai farti tutte le aspiranti miss che vuoi, ma alla fine ti troverai una al cui confronto tutto il resto ti sembrerà fuffa. Quindi, dammi retta, lascia stare, cancella la fuffa da subito.»
Gli ho dato retta solo in parte.
Ma quella sera e le sue parole mi sono tornate in mente ogni volta che Anna non rispondeva ai miei messaggi, alle mie telefonate. Ogni volta che tutto quello che ero, tutto quello che avevo, senza di lei mi sembrava fuffa.
![]()
«È lei il calciatore?»
Pur non essendo una bestia come gran parte dei miei compagni di squadra, c’erano degli aspetti della mia carriera in cui mi comportavo come loro. Uno di questi riguardava l’obbligo del rapporto con la gente, i doveri del personaggio pubblico. Potrà sembrare strano, ma a me di avere uno stuolo di fan intorno è sempre interessato poco. Una volta giocavo per divertirmi, poi per divertirmi con i soldi che guadagnavo. In questo non ero cambiato. Da ragazzino, al mio paese, mi bastavano un prato, un avversario, qualcosa simile a una porta dove depositare la palla al termine dell’azione. Da adulto mi interessava la stessa cosa, solo che prima era un fatto fine a se stesso, adesso, al termine dell’azione, c’era un mucchio di soldi da spendere come meglio credevo. In fondo, era sempre una questione di piacere personale.
In ogni caso, una volta c’era solo da rendere felici i tifosi, poi siamo entrati nell’era del politicamente corretto, della bontà istituzionale e non c’è squadra o calciatore, che non debba versare l’obolo e “mostrarsi” mentre si impegna in varie attività di beneficenza. La mia società aveva aderito a un progetto di sostegno e avvio allo sport dei ragazzini nelle periferie milanesi.
Quando il direttore sportivo cominciò a parlarmene, quel giorno in sede, misi automaticamente la mano nella tasca della giacca e tirai fuori il libretto degli assegni.
«Quanto devo dare?»
Lui scosse la testa.
«Non hai capito, i soldi li mettiamo noi e gli sponsor, tu e i tuoi compagni ci dovete mettere la faccia.»
«Ah no, io non metto la mia faccia da nessuna parte. Se vuoi ti do il 5 per mille, l’8 per mille del mio stipendio. Sul 740 o come cavolo si chiama faccio già un versamento alla Chiesa cattolica. Loro si accontentano dei soldi, anche se a messa non ci vado più da anni. Perché non fate lo stesso anche voi?» gli dissi con tutta l’aria strafottente di cui ero capace.
Il direttore sportivo non mi era simpatico, ma non era uno squalo. Io ne ho conosciuti di squali e lui non apparteneva alla categoria. Non s’arrabbiava mai e qualcuno di noi (io compreso) spesso se ne approfittava. Pensavo di fare la stessa cosa in quell’occasione, di cavarmela con poco, ma sul suo viso vidi una trasformazione che mi inquietò. Il direttore sportivo divenne rosso e perse di colpo la sua mitezza.
«Tu lo fai e lo fanno i tuoi compagni, perché si tratta di bambini e il solo fatto che tu non voglia essere coinvolto direttamente mi manda in bestia. E pensare che ti facevo diverso. Mi sembravi in gamba, invece sei solo un egoista, un egoista col cervello, quindi peggiore degli altri.»
Si alzò dalla poltroncina della sala riunioni del club e mi indicò la porta.
«Non me ne frega niente se sei una delle star della squadra. Non azzardarti a svicolare, come fai di solito. Questa volta te la faccio pagare» e mi cacciò.
In seguito, ricordando come è cominciata la storia con Anna, ho ripensato spesso al colloquio con il direttore sportivo e alla sua reazione. Quando uno s’innamora succede così, va a cercare i segni, le sfumature, le premonizioni. Vuole che i suoi sentimenti abbiano qualcosa di speciale, di unico e appaiano come predestinati. Poi ho iniziato a fare così anch’io e mi appare davvero sorprendente che tutto sia nato da una cosa che non volevo fare.
Quella volta, in preda alla rabbia, chiamai il mio procuratore (non era più Mimì, ma un vero squalo, di quelli che l’otto per mille se lo intascava lui e che rubava le caramelle ai bambini) e gli dissi che volevo cambiare squadra, al più presto.
Lui era squalo ma non stupido.
«Senti, facciamo che non ho sentito niente. Tu sei al top, nel momento migliore della tua carriera. Datti una calmata, fai un bel respiro profondo e vai a sorridere mezz’ora ai bambini. Firma qualche autografo, mettiti in posa per qualche foto e vieni via. Fammi il piacere, eh, che io ho dei veri grattacapi e non posso perdere tempo dietro a queste fregnacce.»
Mi trovai così a guidare verso una chiesa che era oltre piazzale Cuoco. Ogni tanto, andando a prendere l’Autosole, ci passavo accanto. C’era un parco, e uno spiazzo su cui si sistemavano i tendoni dei circhi. Una volta, sul ponte che superava la ferrovia, il tale alla guida dell’auto accanto alla mia mi aveva riconosciuto e aveva cominciato a strombazzare e a gesticolare. Ero corso subito alla concessionaria dove avevo acquistato quel costosissimo fuoristrada per farmi mettere i vetri oscurati.
Quel pomeriggio però avevo preso la 207 cabrio. Mi sembrava esagerato andare con le altre auto. E poi, a dirla tutta, avevo un po’ di timore che, in quello che giudicavo un postaccio, qualcuno rigasse, o peggio, le mie vetture più preziose. Mentre guidavo nel traffico milanese pensai che, beneficenza a parte, il direttore sportivo mi aveva colpito con quel discorso sull’egoista. Me l’aveva già fatto mia nonna, quando avevo smesso di tornare con regolarità a trovare lei e gli altri parenti.
Arrivai davanti al cancello della chiesa e, mentre cercavo di capire dove poter parcheggiare, sentii picchiettare sul vetro oscurato (li avevo fatti mettere su tutte le tre auto che possedevo). Era un prete. Insomma, non sembrava proprio un prete come quello del mio paese, con la sottana, però non potevo sbagliarmi. Indossava un paio di pantaloni neri stazzonati, una camicia bianca e un pullover blu con la cerniera. Quel giorno non faceva freddo, c’era un’avvisaglia di primavera. Schifosa come può esserlo a Milano, ma pur sempre primavera.
Abbassai il finestrino. Lui infilò dentro la mano.
«Sono don Pietro, piacere, lei dev’essere Marco.»
«Sì, sono io. Buongiorno. Anzi, buonasera. Dove posso mettere la macchina?»
Il prete mi fece un cenno: «Di là. Venga, venga, le apro il cancello. È puntuale, bravo, così non perdiamo tempo».
Entrai in una specie di cortile e parcheggiai accanto a un vecchio pulmino bianco e arrugginito, con il nome della parrocchia mezzo scolorito. Da una portiera scendeva il pezzo di gomma di una guarnizione che qualcuno aveva tentato, vanamente, di riattaccare con lo scotch. Ero fermo lì davanti, a guardare quel vecchio arnese, quando udii una voce alle mie spalle.
«È lei il calciatore?»
Dopo, per molto tempo, ho pensato a quell’istante, a come l’intonazione della voce e il senso della domanda mi avessero irritato. E penso ancora adesso a come l’irritazione svanì quando mi trovai davanti una donna che mi guardava con due occhi chiari, assolutamente privi di malizia e di quel disprezzo che, all’inizio, avevo pensato di cogliere nelle parole che aveva pronunciato.
Vorrei descrivere Anna, ma prima è necessario che io parli un po’ di me stesso.