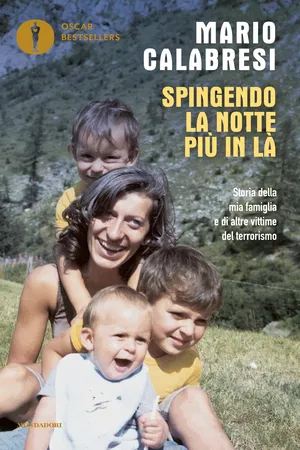![]()
XIV
Le scuse
Sotto i portici di via Valdonica, nel centro di Bologna, i passanti parlano a bassa voce. Mi viene istintivo trattenere il respiro. L’aria è densa, tutto sembra immobile. La via è stretta ed è come se quel dolore così forte, quel gesto così insensato fossero ancora lì, intrappolati tra i muri stretti, incastrati sotto la volta, incapaci di cominciare a mescolarsi con il cielo. E lì non riesci a non cercare con gli occhi la bicicletta del professore. Di Marco Biagi, a cui spararono il 19 marzo 2002. Camminare su questa pietra sembra quasi un sacrilegio, ma ogni giorno lo fanno coraggiosamente sua moglie e i suoi figli, che qui sono rimasti. Non sono scappati. Nonostante le polemiche, gli sfregi e le incomprensioni.
La storia dell’omicidio di Marco Biagi è una storia di follia ma è anche un apologo sul linguaggio. Sull’uso leggero, poi disinvolto, infine irresponsabile delle parole. Sulle gabbie che si possono costruire, capaci di incastrare la vita di una persona, annodando insinuazioni, battute, scritti, scritte, volantini, frasi taglienti e anche silenzi ostentati. Non c’è bisogno di un regista, il risultato finale è dato dalla stratificazione dei piccoli comportamenti, apparentemente senza colpa, di molti.
E così l’identità di un professore di centrosinistra può essere stravolta a tal punto da farne il simbolo negativo di un governo di centrodestra.
Marina Orlandi Biagi ha compreso con lucidità, insieme al marito, cosa stava succedendo e insieme hanno cercato un modo per sfuggire alla gabbia, per rompere il meccanismo: hanno pianto, urlato, chiesto protezione. Ma è noto come abbiano trovato disinteresse, porte chiuse e perfino gelida sopportazione. Così come è noto il finale.
«Marco, il giorno in cui è stato ucciso D’Antona, era a Roma, lavorava anche lui con l’allora ministro del Lavoro Antonio Bassolino, era il governo di Massimo D’Alema.» Marina ricorda ogni momento. E io con lei. Caterina, che sarebbe diventata mia moglie, allora era la portavoce di Bassolino. La sera mi parlava di Massimo D’Antona che stava scrivendo la riforma del lavoro, dei plichi di appunti che andava a prendere a casa sua in via Salaria, dell’ultima volta che lo videro al ministero. Poi ricordo quella mattina, la sensazione immediata che i mostri fossero tornati, per colpire nel centro di Roma. Poco distante da via Salaria, in via Po, c’era la sede dell’«Espresso». Chiamai lì e subito dissi a Giampaolo Pansa: «È successo di nuovo, sono tornati, è qualcosa che abbiamo già visto». Lui mi rispose solo con poche parole: «Ho la stessa sensazione».
La pioggia alla commemorazione e sensazioni già a me troppo note: gli uomini in divisa armati che ogni mattina e ogni sera aspettavano che Caterina accendesse il motorino o lo parcheggiasse sotto casa. Poi lei mi parlava di Marco Biagi, che completò il lavoro di D’Antona nei giorni successivi all’omicidio, per portarlo a Bruxelles. Nei tempi che erano stati previsti. Omaggio postumo al lavoro di una vita.
«Mio marito mi telefonò» racconta Marina Orlandi «e mi disse: “Non torno a Bologna oggi, ci vediamo venerdì”. Era mercoledì. Io l’ho supplicato di tornare a casa subito, piangevo, urlavo. Lui mi disse di no, mi disse che doveva finire di preparare il documento, che volevano presentarlo alla conferenza stampa. Non c’era niente da fare. Allora gli chiesi almeno di non partecipare alla conferenza stampa, non volevo lo vedessero. Lui rispettò la mia richiesta, almeno in questo acconsentì. Ricordo l’angoscia che cominciò in quel momento. La notte mi alzavo e guardavo dalle finestre. Per alcuni giorni sotto casa vidi un furgone bianco parcheggiato nella piazzetta. Diventò il simbolo della mia paura, della nostra fragilità.»
Ma le precauzioni furono inutili, superate di gran lunga da un odio ideologico che ancora inquina il dibattito sulle regole del mondo del lavoro.
«Mio marito non era un uomo di destra, era un socialista, ma scelse di continuare a lavorare al ministero, anche quando cambiò il governo, rimase con Roberto Maroni. Da quel momento la sua vita diventò sempre più difficile, venne a poco a poco isolato: lavorava per il nemico. Vivere a Bologna diventò difficile. La sofferenza atroce di Marco, negli ultimi mesi di vita, gli derivava dall’essere dipinto come una persona diversa da quella che era. Diceva: “mi hanno fatto un cordone sanitario intorno”.»
Marina Orlandi abita in una casa piena di piante, memoria e stampe cinesi. Non ha voglia di fare nomi, elenchi, liste di buoni e cattivi. Preferisce guardare avanti, e sperare che proprio la Fondazione Marco Biagi possa essere un luogo «in cui si privilegiano il dialogo e il confronto costruttivo, lo studio approfondito e senza pregiudizi». Così come lo immaginò lei stessa, assieme al marito, la sera prima che lo ammazzassero: «Parlammo a lungo di quel che stava facendo per tutelare il più possibile i giovani, le donne, le fasce meno protette del mercato del lavoro che, già difficile, era destinato a diventarlo sempre più. Voleva andare avanti, con l’entusiasmo di un ragazzo, benché si sentisse isolato e in pericolo. Ventiquattro ore dopo venne ucciso. Quella sera decisi con tutta me stessa che i suoi assassini, dopo averne annientato la vita, non dovevano riuscire anche ad annientarne le idee». Nel logo della Fondazione c’è una bicicletta: ha il fanale acceso, che illumina la strada.
Nell’autunno del 2006 Marina Orlandi ha avuto paura di nuovo, la sua sensibilità l’ha messa in allarme, gli slogan di alcuni cortei sul precariato avevano un sapore fin troppo noto. Allora si è fatta violenza, ha rotto il suo silenzio assordante e ha scritto un messaggio per l’inaugurazione della nuova sede della Fondazione, all’università di Modena: «Ogni giorno ci troviamo, in materia di lavoro, di fronte a una conflittualità esacerbata, che porta a una degenerazione del dibattito che non è solo sterile ma, come purtroppo ben sappiamo, anche estremamente pericolosa». Il suo impegno per difendere la memoria del marito è continuo, anche se lo fa in silenzio e senza apparire. Non si fa fotografare, difende la privacy sua e dei suoi figli, perché vuole continuare a camminare per Bologna liberamente.
Le calunnie, ripetute con insistenza, sono capaci di costruire una biografia. Non posso non tornare a pensare a mio padre e al personaggio che venne costruito tra il 1969 e il 1972, con la collaborazione di giornali, pièce teatrali, film, volantini e scritte sui muri, che in parte mi sembra sopravviva al passare del tempo, alle smentite, alle evidenze. Ma ci sono cliché inaffondabili. Così tocca leggere ancora oggi che Luigi Calabresi era stato addestrato in America, che era uomo della Cia, che nel 1966 fece da accompagnatore ufficiale al generale americano Edwin A. Walker, e che fu lui a presentarlo al generale Giovanni De Lorenzo. Eppure basterebbe tanto poco, un briciolo d’intelligenza, di curiosità, un minimo riscontro: mio padre non parlava una parola d’inglese e non ebbe mai prima le possibilità, poi il tempo per viaggiare. L’unico timbro sul suo passaporto è stato messo a Barcellona il 31 maggio 1969. Primo giorno del viaggio di nozze che portò i miei genitori a Granada e Siviglia, dove mi concepirono. Poi, per lavoro, andò in Svizzera. Da nessun’altra parte. Mai oltreoceano. Ma potrebbe essere tutto opinabile, vai a sapere la dietrologia, se non fosse per un piccolo particolare: l’anagrafe. Si era laureato nel 1965, aveva fatto il concorso per diventare vicecommissario e nel 1966 partecipò al corso di formazione della scuola di Polizia. Che la Cia si affidasse a Roma a un neolaureato, che poi gli avesse dato l’incarico di fare da guida a Roma a un generale e che un allievo della scuola di Polizia fosse il tramite tra gli americani e un golpista italiano è quasi divertente a immaginarsi, tanto è incredibile. Oggi con Google tutto è più facile e così sono andato a curiosare su chi fosse questo Walker: era un generale americano che aveva combattuto in Italia nella Seconda guerra mondiale e poi in Corea; aveva idee molto di destra, tanto che il segretario alla Difesa di Kennedy, Robert McNamara, lo sollevò dall’incarico e lui se ne andò dall’esercito. Nel 1961.
Mio padre querelò «Lotta Continua» per l’accusa di essere l’assassino di Pinelli e per tutte le leggende «americane» che aveva creato, concedendo ampia facoltà di prova nella speranza di dimostrare che quelle contro di lui erano calunnie. Una querela a cui mia madre si oppose fino all’ultimo, «così fai il loro gioco», ma mio padre spiegò che glielo aveva chiesto il ministero dell’Interno. Fu tutto inutile e il processo si ritorse contro di lui, perdendo di vista l’oggetto della querela. Alla fine il giudice venne ricusato e il processo venne sospeso e assegnato ad altri giudici; si sarebbe concluso solo quattro anni dopo la sua morte con la condanna dell’allora direttore responsabile di «Lotta Continua».
Dopo la ricusazione furono ottocento gli intellettuali che firmarono un documento, pubblicato sull’«Espresso» il 13 giugno 1971, in cui mio padre veniva definito «commissario torturatore» e «responsabile della fine di Pinelli». L’elenco è sterminato, decine di coloro che firmarono li ho incontrati negli anni, anche se ho parlato di quel documento solo con Lucio Colletti. Lo incontravo a Montecitorio quando, non più marxista da tempo, era parlamentare di Forza Italia. Io pagavo il caffè alla buvette, lui mi offriva una di quelle sigarettine sottili che fumava in continuazione e poi mi regalava una battuta per il pezzo. Nel 2001, mentre si preparavano le liste elettorali, gli feci un’intervista spassosa in cui prendeva di mira il partito, parlando di vili e rammolliti. Preferiva andare ai giardinetti a fare il pensionato. Lo presero in parola e lo cancellarono dall’elenco dei candidati. Mi chiamò la mattina dopo un po’ affranto e mi disse: «Mi hai rovinato, sai che non resisto al gusto della battuta e mi hai fregato. Ma cosa ti posso dire, e poi verso di te sento un debito. Pazienza, vorrà dire che cercherò una panchina al sole». Quel pomeriggio vidi Berlusconi nel Transatlantico a Montecitorio, lo inseguii e gli dissi: «Ma non vorrete mica fare gli stalinisti che cacciate uno per una battuta, e poi la colpa è mia, Colletti scherzava». Alla fine tornò in lista, pronto a ricominciare a sfottere il Cavaliere e i suoi colonnelli.
Paolo Mieli risponde ai lettori sul «Corriere della Sera» del 3 luglio 2002, nella rubrica delle lettere. Si parla di università e di lauree specialistiche, ma l’allora ex direttore del quotidiano di via Solferino – tornerà a guidarlo nel dicembre del 2004 – prende al volo l’occasione di un lungo elenco di firme in calce alla lettera per dire qualcosa che pare con evidenza stargli a cuore da tempo. Il titolo della sua risposta è: Attenti alle firme in calce agli appelli e ai manifesti. Il ritaglio del «Corriere» è in una grande busta nel cassettone centrale di un comò del Seicento comprato a un’asta alla Certosa di Pavia nel 1969: era il pezzo forte della casa dei miei in via Cherubini. Sulla sinistra ci sono migliaia di lettere raccolte in cartelline colorate, a destra questa busta con le missive o le pagine di giornale che hanno un significato particolare. «Dissento, con il dovuto rispetto, dalla forma della vostra protesta. Ho in grande antipatia» scrive Mieli «i pubblici appelli, ogni genere di appello. Perché li considero, nella migliore delle ipotesi, inutili, talvolta ridicoli, quasi sempre appestati da ben individuabili manifestazioni di esibizionismo. Firmare quel genere di carte non costa niente, assolutamente niente. A dispetto dei toni gladiatorii che abbondano in quelle petizioni, non è necessario alcun coraggio per aderire. Anzi. Ma c’è dell’altro: molti anni fa la mia firma capitò (me colpevole) in calce a uno di questi manifesti; nelle intenzioni dei promotori – e mia – quell’appello avrebbe dovuto essere a favore della libertà di stampa; ma, per una riprovevole ambiguità della formulazione, pareva che quel testo difendesse la lotta armata e incitasse al linciaggio di Luigi Calabresi. Poco dopo il commissario fu ucciso e io, a distanza di trent’anni, provo ancora vergogna per quella coincidenza. Come, credo (o quantomeno mi auguro), tutti coloro il cui nome comparve in fondo a quel foglio. E vergogna è dir poco: qualsiasi parola di scuse nei confronti di moglie e figli di Luigi Calabresi mi appare ancor’oggi inadeguata alla gravità dell’episodio. So bene, dicevo, come le firme finiscono su quel genere di appelli. Talvolta si è consultati frettolosamente al telefono. Ma spesso gli interessati non ne sanno alcunché. Lo scrittore greco Vassilis Vassilikos – autore del libro da cui fu tratto il film Z, in cui si rievocavano le premesse del colpo di Stato dei colonnelli ad Atene – ha raccontato che nel 1967, qualche giorno dopo il golpe, lesse su «Le Monde» la petizione di settanta intellettuali francesi che chiedevano la sua immediata liberazione. “Io stavo bevendo un espresso in un bar all’aperto sotto il sole di Roma e mi agitai” ricorda Vassilikos. “Telefonai subito a Gallimard, il mio editore, per dirgli che ero in salvo all’estero e che presto sarei andato a Parigi”. Ma la sorpresa non fu tutta qui. Due mesi dopo, quando arrivò nella capitale francese, lo scrittore greco prese contatto con alcuni di coloro che avevano firmato l’appello e scoprì che nessuno sapeva di esser stato tra i firmatari. “Fino a che Marguerite Duras mi sciolse ogni dubbio: in sostanza tutti loro avevano lasciato una delega in bianco alla coppia Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Quando Sartre e consorte decidevano di protestare per qualcosa, il loro intervento era seguito, automaticamente, dalle firme degli altri sessantotto. Vassilikos, almeno, ha avuto il coraggio di raccontarlo e l’onestà di scherzarci su.»
Dalla busta tiro fuori anche una lettera di Folco Quilici e un’inserzione a pagamento pubblicata il 18 maggio 1997 sul «Manifesto». Nella lettera, scritta nel 1991, lo scrittore e documentarista, famoso per le sue opere sul mare, racconta di aver appena scoperto la sua firma tra quelle degli ottocento: «Cara Signora, ci tengo a dirle che non sono io, ho la sensazione che si tratti di qualcun altro o che sia stata apposta la mia firma senza interpellarmi. Anzi, vorrei che lei mi credesse, mi addolorai molto per l’assassinio di un uomo di coraggio». Il ritaglio di giornale invece arriva da chi stava sull’altro fronte: è un breve comunicato preparato in occasione del venticinquesimo anniversario della morte di mio padre. In fondo ci sono undici firme, tutte di ex esponenti di primo piano di Lotta Continua.
«Nell’anniversario di quel delitto per cui i nostri amici Adriano Sofri, Ovidio Bompressi e Giorgio Pietrostefani, che sappiamo innocenti, sono detenuti, noi – che con loro abbiamo in passato condiviso idee, parole e comportamenti – sentiamo il dovere di riconoscere che Luigi Calabresi, prima di essere ucciso, è stato oggetto di una campagna politica e di stampa che ha travalicato i limiti di una pur decisa contestazione e che ha suscitato verso di lui sentimenti di odio, contribuendo a creare un clima che ha portato al suo assassinio. Quella campagna e quei sentimenti non possono essere giustificati, né oggi né allora, nemmeno dal doveroso impegno, nostro e di altri, teso a denunciare gli abusi compiuti nelle indagini sulla strage di piazza Fontana e a pretendere la verità sulla morte di Giuseppe Pinelli. Non ha scusanti l’atteggiamento con cui, da molti di noi, fu accolta la notizia dell’uccisione di Luigi Calabresi: non fu spesa una parola sul valore della vita umana, anche di un avversario, né sulla gravissima violenza che l’uccisione di un uomo arreca alla vita dei suoi familiari.» Tra le firme ci sono quelle di Marco Fossati, Franca Fossati, Guido Viale e di Nini Briglia, che oggi è direttore della divisione periodici della Mondadori. Non ci siamo mai incontrati, ma gli telefono per sapere come nacque l’idea. «È stato un percorso faticoso, cominciato» mi racconta «con alcune riunioni tra persone che non si vedevano più da anni: all’inizio eravamo in molti, ma in fondo arrivammo solo in undici. L’iniziativa era figlia della volontà di fare un passo avanti, di metterci in discussione e guardare in faccia la tragica realtà di quegli anni. Nello stesso tempo, però, un vincolo formidabile ci spingeva a non danneggiare la linea difensiva dei nostri amici. Ci furono infinite mediazioni linguistiche, chi voleva andare più avanti e chi frenava. Ne venne fuori un ibrido, a mio parere insoddisfacente. Ma era un passo avanti e fu meglio di niente.» È nella cartellina del cassettone del comò del Seicento. Vuol dire che era meglio di niente.
La nonna di Caterina, Natalia Ginzburg, firmò l’appello, ma per me è sempre stata l’autrice del libro Lessico famigliare, che la maestra delle elementari leggeva in classe ad alta voce. Suo zio Carlo ha scritto uno dei più noti pamphlet in difesa di Adriano Sofri: Il giudice e lo storico. La seconda volta che siamo usciti assieme, un pomeriggio d’estate a Roma, quasi all’unisono ci siamo chiesti: «A te la cosa crea problemi o imbarazzi?». «No, proprio no» ci siamo risposti contemporaneamente. Una sera, prima del nostro matrimonio, Vittorio Foa e sua moglie Sesa ci hanno invitati da loro. Avevano preparato gnocchi al pomodoro, come si usava a casa Ginzburg, e Vittorio ha detto: «Questa cena avrebbe potuto prepararla tua nonna. In bocca al lupo». Oggi abbiamo due bambine, gemelle, sono nate a New York e hanno il doppio cognome: si chiamano Emma e Irene Calabresi Ginzburg. Il loro passaporto con due nomi che sono diventati uno solo mi mostra con chiarezza che appartengono a un altro secolo.
Molte volte la sera, quando il giornale era ormai impostato, alla fine della riunione, mi sono fermato nella stanza di Ezio Mauro, il direttore di «Repubblica». Abbiamo parlato per ore degli anni Settanta, del terrorismo, e lui mi ha sempre colpito per la chiarezza delle sue posizioni: «Aver fatto il cronista a Torino nei primi anni del terrorismo mi ha permesso di capire delle cose a cui forse con l’intelligenza sarei arrivato solo più tardi: me le sono viste squadernate davanti. Bastava andare a casa di una guardia carceraria a cui avevano sparato e incontrare la moglie giovanissima con il figlio in braccio: anche un cretino avrebbe capito che le Brigate Rosse andavano fermate. Ricordo Antonio Cocozzello, maestro elementare e consigliere comunale della Dc, venuto a Torino dalla Basilicata. Gli spararono alle gambe alla fermata del tram nell’autunno del 1977. Scivolò a terra lungo il palo dell’insegna e vi rimase per parecchio tempo in attesa dell’ambulanza. Ho avuto tempo per osservarlo e vedere i vestiti di un uomo del popolo e per terra una cartellina di plastica con le pratiche del patronato Cisl: assisteva gente che chiedeva la pensione. Sono tornato alla “Gazzetta del Popolo” e ho trovato la rivendicazione dei terroristi: “Abbiamo azzoppato un uomo del potere Dc”. Sapevo bene cos’era il potere democristiano e non mi piaceva per niente, ma lì ho capito in un momento che Cocozzello non c’entrava niente e che le Brigate Rosse non stavano dalla parte del popolo e della povera gente. Tornai a casa e scrissi sessanta pagine per i miei amici, che ho ritrovato qualche anno fa. C’era la polemica sullo Stato, definito un guscio vuoto e dicevo: “Ma se salta il guscio, che sono le istituzioni democratiche, poi che cosa ci resta?”».
A sparare a Cocozzello fu Patrizio Peci, che diventò poi il primo pentito delle Brigate Rosse. Ero con Ezio, un pomeriggio, nei primi giorni di settembre del 2002, quando chiamò Peppe D’Avanzo che stava intervistando Peci, a vent’anni dalla morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, per fargli raccontare come il generale lo convinse a pentirsi e come riuscì a mettere in ginocchio le Br. Peppe gli passò Peci che esordì: «Direttore, ce l’ha ancora la Renault arancione?». Ezio rimase stupito, rispose di no, e quel giorno scoprì che era stato pedinato a lungo ed era stato un obiettivo alternativo a Carlo Casalegno. Era molto più giovane e meno importante, ma scriveva editoriali sul terrorismo e non aveva la scorta.
I suoi racconti sulla città e la Fiat sono pieni di passione civile: «Come diceva l’avvocato Agnelli, chi non ha vissuto a Torino non può capire cosa sia stato il terrorismo: per l’intensità delle cose. La sera non si usciva più, poi la mattina accendevi la radio per sentire a chi avevano sparato. L’unica volta che ho pianto è stato per Tobagi, ero davanti alla televisione nello stanzone della cronaca. Fin dall’inizio, in nuce...