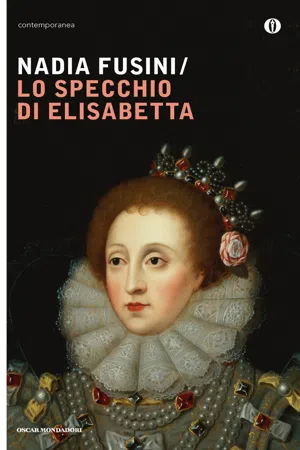
- 280 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Lo specchio di Elisabetta
Informazioni su questo libro
Elisabetta, la grande sovrana, è in punto di morte e convoca a corte l'adorato figlioccio, boy Jack. Sta per chiudersi un'epoca, quarantaquattro anni di regno durante i quali la regina vergine ha reso l'Inghilterra grande e famosa: un'isola di pace al centro del mondo in guerra, unica, incomparabile, sola. Come la sua regina. Che ora, davanti al figlioccio silenzioso e fedele come uno specchio, si abbandona ai ricordi e rievoca le tante, tormentate passioni di chi per ragioni di Stato non può concedersi all'amore. Con spietato senso della verità Elisabetta giudica se stessa e il mondo. Affresco storico e confessione di un'anima, Lo specchio di Elisabetta è soprattutto la narrazione della straordinaria vicenda umana di una donna sola.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Lo specchio di Elisabetta di Nadia Fusini in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804595564eBook ISBN
9788852013249La lepre fantasma
«Ecco, tra poco sarò cenere anch’io» sussurra. Poi sgomenta per il gesto che ha fatto, si volge al caro Jack e gli confida: «Muoiono tutti intorno a me, girano l’angolo e non li vedo più, scompaiono. È uno strano gioco, una specie di nascondino. Ma li rincontreremo, vero? Vero, Jack? tu lo credi?».
Jack annuisce. Nella stanza entrano le dame, spostano i candelabri, li spengono, aprono una tenda e la luce naturale entra con un fiotto irruento e colpisce un arazzo. La Regina si scherma il volto con la mano, ma ha piacere per quella inattesa visita.
«Dopo Dudley, fu la volta di Hatton, poi s’ammalò lord Burghley e lo curai con tenerezza materna. Non sono stata madre, ma mi inventai di essere nutrice e consolatrice del vecchio ministro William Cecil, il quale non aveva parole per ringraziarmi e s’augurava di poter continuare a servirmi in paradiso, come in terra. Morì il quattro agosto di tre anni fa, avendomi servita per quasi quarant’anni. Lo conoscevo da sempre, era amico di Katherine Ashley, la governante che ho amato come una madre. Lo assunsi perché seguisse i miei interessi a sedici anni, quando ero lady Elizabeth, un giorno legittima, un giorno illegittima, a seconda degli umori del padre. E da Regina il mio primo atto fu di nominarlo Segretario di Stato. Serio, onesto, temperato, equilibrato, industrioso e giusto è stato un ministro eccellente, che mi ha sempre spiegato gli affari di Stato in modo fluente e chiaro. Per mesi solo a sentire il suo nome mi venivano le lacrime agli occhi. A settembre dello stesso anno morì anche Filippo II. Una malattia ripugnante gli aveva ricoperto il corpo di piaghe, una squadra di chirurghi lo tormentò fino all’ultimo respiro per fargli scoppiare una ad una le bolle; soffriva indicibilmente. E mentre quelli coi loro strumenti affilati lo perseguitavano, il suo frate Diego gli leggeva ad alta voce la Passione secondo Matteo. Coperto di piaghe come Giobbe, gonfio di idropisia si disfaceva nella sua putredine, si consumava nello strazio della sua carne, divenuta immonda. Il fetore richiamò all’Escorial, dove s’era murato, tutti gli insetti dell’estate castigliana. Morì da fanatico com’era vissuto, gli occhi fissi al crocefisso. “Voglio parlare con Dio” diceva: così si immaginava la morte, come un incontro tra principi.
Dalla finestra della camera dove languiva, che si era fatto costruire in modo da avere di fronte la cappella, spiava l’altare, sopra il quale ardevano i ceri, appestando l’aria di fumo.
Non posso dire di averlo proprio pianto, ma con la sua scomparsa un altro anello col passato si è rotto. Avrei potuto sposarlo; dopo la morte di mia sorella Maria mi corteggiò, mi avrebbe voluta in moglie. Il matrimonio tra nobili è una forma di scambio, ha sempre un significato politico, ma in questo caso, Dio mio, mi dissi, si sarebbe ripetuta a rovescio la storia di mio padre e della sua prima Regina! Mi rifiutai, sapeva troppo di incesto.
L’incesto era la mela che continuava a pendermi davanti alle labbra; non volli morderla. Con ispanica munificenza Filippo non mi richiese indietro i gioielli che aveva regalato a Maria. Al tempo del fidanzamento aveva addirittura spedito a Londra un gioielliere italiano, Jacopo da Trezzo, carico d’ori e di pietre preziose e spille e ciondoli e anelli, perché lei potesse scegliere. Ma Maria era così austera. Amava soltanto la croce.
Di tutto il tesoro, comunque, Filippo rivolle indietro soltanto un enorme diamante; il resto era per me, disse, me lo potevo tenere. Non me lo feci dire due volte. Filippo era davvero un caro fratello, risposi; sapeva come ingraziarsi una donna. Ma, per quanto mi riguarda, non ci cascai. Sapevo benissimo che faceva regali anche alla Stuarda; oscillava tra me e lei, incerto su chi era meglio che sposasse. Ai suoi occhi io e Maria eravamo entrambe appetibili: condividevamo il potere di un’isola che gli faceva gola, eravamo una specie di Eteocle e Polinice, mentre lui era Creonte, aspettava a vedere se ci azzannavamo. È vero che l’equilibrio tra noi era delicato e cambiò più volte. Quando le nacque il figlio Giacomo, Maria diventò più forte di me; si era assicurata il futuro. Mentre io tenevo sulla testa una corona sterile.
Poi, in un battere d’occhio, tutto si rovesciò: Maria perse ogni cosa – il regno, il figlio, la patria... Il figlio glielo crebbero contro e lui non poté che tradirla. Giacomo non ha mai veramente difeso la madre naturale, perché riaverla in patria avrebbe significato ridarle la corona... Ha scelto invece me come madrina; io sono diventata la madre spirituale, la madre politica di Giacomo. È bastato fargli brillare davanti agli occhi il miraggio della successione e non ha mosso un dito per salvare la madre. La tragedia insegna: le passioni che allignano nelle viscere dei rapporti di genitura sono l’odio, la rivalità, più che l’amore.»
Elisabetta si interrompe. Mistress Bonne, che tiene in ordine le sue gorgiere, è entrata piano nella stanza, e ha aperto il grande stipo dove deposita con cura il fardello di trine inamidate. Jack tace. Distratta, Elisabetta segue i movimenti della sua cara Bonne, e nella camera cala il silenzio, e in quell’attimo vuoto Jack si accorge che non vede l’ora che Elisabetta riprenda a parlare: non c’è niente che desideri di più che sentire la sua voce.
Dopo un breve intervallo la voce riprende: «Ho amato poco la giovinezza, un’epoca malsicura, un’età fuggevole. Vedi, ora pensano che fossi nata per comandare, ma non è così. Io non volevo che una cosa: sopravvivere, la mia vita era in pericolo, e non volevo morire. C’è nella giovinezza questa ostinazione di attaccamento alla vita. In più, dicessero pure che ero bastarda, ma se mia sorella Maria fosse morta senza eredi, sarei salita io sul trono. Non mi era dovuto, ma sarebbe stato mio, e la corona lo stesso; mi brillava davanti agli occhi come una visione, un fantasma, che significava la vita per me – se l’avessi avuta, voleva dire che non sarei morta. Perché, se veniva meno Maria, chi sarebbero andati a ripescare per mettergli in mano l’orbe e lo scettro Tudor? i discendenti della sorella maggiore di Enrico? o di quella minore? Maschi non ce n’erano, così poteva ben essere che sarei stata io – l’eretica, la bastarda – a salire sul trono, perché ero pur sempre la figlia di Enrico: ero nata qui, gli somigliavo. L’ebbi vinta. Ma non tramai, non feci nulla. Fu come dissi quando vennero a darmi l’annunzio: è una cosa voluta da Dio, meravigliosa ai nostri occhi.
La meraviglia sarebbe continuata negli anni, avrei continuato a stupire regnando. E il giorno della mia incoronazione volli che la Corte recitasse in piena gloria lo spettacolo della sovranità. Nella processione il moto lento e solenne dei corpi dei nobili rivestiti di oro e brillanti e perle e granati e spinelli e turchesi e zirconi e zaffiri e rubini e opali e corniole e crisopazi e agate rischiarò l’aria, il cielo si illuminò benché fosse gennaio e nevicasse. Era una luce irreale, che confuse per un attimo i tempi e le stagioni, non era gennaio, non era notte, né giorno. Allo sguardo del mio popolo si presentò lo spettacolo del puro artificio – non è questa l’essenza del potere regale? E lo ammaliò.
Lo splendore regale era l’ossessione dei Tudor. Ad ammassare un’ingente quantità di gioielli cominciò mio nonno Enrico VII, in genere tanto più frugale del figlio. Molti ne portò con sé Caterina d’Aragona quando giunse sposa del suo primo figlio Artù in Inghilterra; sopratutto meravigliose granate color rosso cupo – la melagrana di Granada era il suo simbolo araldico. Tra il popolo ancora oggi si racconta come di un atto di particolare ferocia da parte di Enrico il fatto che, quando la ripudiò, oltre alla corona, le tolse tutti i gioielli; le pietre preziose e le gemme rare che Caterina s’era portata dalla Spagna furono smontate e rimontate per la Bolena».
Elisabetta si interrompe. Cerca qualcosa con gli occhi, poi indica a Jack lo scrigno là, sul tavolo. «Jack, fruga ancora lì, in fondo allo scrigno, ci troverai un anello che raramente ho portato, ma senza che nessuno lo sapesse, l’ho sempre tenuto vicino. Lo vedi? Sì, quello. Aprilo, e sotto il diamante incastonato tra la madreperla e i rubini, tra le due iniziali – E per Elisabetta e R per Regina – ti appariranno il busto a smalto mio e della Bolena; io di profilo, lei di fronte.»
Jack obbedisce e piano, per paura di danneggiare il prezioso oggetto, fa come la Regina gli ordina. Il fragile meccanismo risponde alla pressione delle dita e cede l’immagine di due volti femminili. Che occhi neri brillanti ha la Bolena, e che massa di capelli corvini lucenti. La carnagione però è olivastra, per il gusto di allora inquietante. Un incarnato così era tipico delle streghe. In più, aveva un neo sul collo, che nella miniatura le viene risparmiato, ma i suoi nemici lo descrivevano come un’enorme tumescenza che, insieme a un’unghia incarnita, una specie di sesto dito accanto al mignolo, altro segno diabolico, altra imperfezione, confermava la sua natura di strega. Invece era una donna colta, aveva letto Erasmo e Colet e Ruggero Bacone e Grossatesta.
«Dicevano che avesse stregato mio padre» dice Elisabetta. «In realtà, lo tenne sulla corda, e questo va a suo merito, dimostra che aveva del coraggio. Non è facile rifiutarsi a un Re, caro Jack, e lei lo fece. Gli disse non sarò la tua amante: o Regina, o niente. Già sua sorella era stata l’amante di Enrico e che ci aveva guadagnato? Anna voleva contare. Aveva le sue idee riguardo al governo del nostro paese. Pensa, Jack, lei, la figlia di un nobile fra tanti – che guadagnò i più importanti incarichi politici a Corte grazie alla sapiente manipolazione della figlia, e alla fine non fece un passo per salvarla – aveva le sue idee sulla religione, sulla politica. Era d’accordo con Enrico che il matrimonio con Caterina d’Aragona era da considerarsi illegittimo, secondo la Bibbia. Lessero e rilessero insieme quel passo del Levitico che giudicava incestuosa l’unione del fratello con la cognata. Enrico si piccava di essere teologo e Anna gli diede da leggere i libri giusti, i libri della cultura riformata, l’Obbedienza del cristiano di Tyndale, ad esempio; in cui apertamente si sosteneva che i principi devono obbedienza a Dio, e non al Papa. A Enrico dovette piacere quel passo in cui si affermava che chi resiste al Re, resiste a Dio. O che qualcuno di lì a poco arrivasse a dire, come ho sentito io con le mie orecchie, che il Dio vivente è il Dio inglese. Non ebbe scrupoli a dichiarare che da Dio lui aveva avuto il mandato di curarsi non solo dei corpi, ma delle anime dei suoi sudditi. Né a fare e disfare la legge civile per i propri interessi. Sollecitò e passò al vaglio le università di tutta Europa perché gli dessero il responso che gli serviva, e comunque era pronto a manipolare ogni verdetto, finché non trovò Thomas Cranmer – glielo presentò sempre Anna. Era il teologo che faceva al caso suo. O meglio, loro.
Enrico si proponeva come una specie di Edipo inconsapevole, intrappolato in un oracolo falso; Giulio II, non la Sfinge, l’aveva ingannato, aveva concesso la dispensa a favore del suo matrimonio con la cognata Caterina, in aperta violazione del Levitico – altro segno che alla Corte papale si faceva non solo traffico di indulgenze, ma anche di dispense matrimoniali. I riformatori lo presero sul serio, e anche Anna. Anna non lo seguiva nei suoi deliri, quando si accaniva sulla propria colpa, e diceva che, avendo sposato Caterina, che gli era cognata, Dio lo puniva con quell’imbarazzante collezione di aborti e infanti cadaveri in cui s’era trasformata la scena del coito regale. Ma quando urlava che gli ci voleva un’altra moglie, qui Anna gli dava ragione. Anna era una donna politica, i suoi motivi non erano affatto sentimentali, ma patriottici: dopo Enrico l’Inghilterra non doveva avere una Regina, per di più figlia di una spagnola cattolica e reazionaria, la quale avrebbe portato l’isola nel cono d’ombra del potere imperiale. Semmai, Anna amava la Francia, e comunque voleva l’indipendenza dell’isola. E questa non la garantiva Maria Tudor, ma un figlio maschio, sì. Lei l’avrebbe dato a Enrico.»
Elisabetta adagia la testa sui cuscini. Jack si fa più vicino, stregato dal racconto. La voce di lei gli giunge chiara e vicina, solo un po’ stanca.
«Come sono intricati i legami tra nobili, Jack! Pensa, sulla stessa riva, alla partenza da Dover, ad accompagnare la sorella Mary Tudor c’erano Enrico VIII con la sua Regina spagnola, Caterina d’Aragona, e mia madre, Anna Bolena. Anna era una bambina, avrà avuto dieci anni, forse dodici – anche la sua data di nascita si è fatta misteriosa, quanto impronunciabile il suo nome. Nessuno la notò, ma lei senz’altro ammirò il giovane principe, il magnifico sovrano di ventitré anni, accanto alla regale sovrana, più grande di età, bella, solenne. Caterina era figlia di re antichi, in ogni gesto era regale. Proprio per questo Enrico VII l’aveva voluta come sposa del primo figlio Artù, perché i Tudor entrassero anche loro nell’élite dei sovrani d’Europa. E quando Artù morì, fu un espediente anche economico sposarla al secondo figlio, a Enrico, anche lui sedotto da tanta regalità. Inosservata, tanto meglio Anna poté godere dello spettacolo sovrano, ammirare Caterina e compiangere la povera Mary, che a diciotto anni andava sposa a un vecchio di cinquantadue, coi denti cariati che gli cadevano in bocca e l’alito puzzolente. Mary non andava di sua volontà tra le braccia di Luigi XII; in cambio, però, aveva ottenuto che il prossimo matrimonio – a lungo questo non poteva durare – avrebbe fatto di testa sua. Ebbe fortuna, l’anno dopo era già vedova, tornò in patria e sposò l’uomo che amava, Charles Brandon, duca di Suffolk. La Bolena invece rimase in Francia, alla Corte di Claude, moglie di Francesco I, una corte modello, come quella della madre Anna di Bretagna, forse un po’ troppo castigata, un po’ troppo solenne, non fosse stato per l’influenza della duchessa di Alençon, più tardi Regina di Navarra, che di Claude era cognata. Più che una corte, Claude sembrava che dirigesse un convento; come, del resto, qui da noi Caterina d’Aragona.
Anna era vivace, ambiziosa, a lei piaceva immensamente Marguerite, una femme d’esprit, un genere di donna che non aveva equivalenti nella nostra isola. A quella Corte Anna imparò modi squisiti, da perfetta cortigiana. Lì l’arte era di casa, Leonardo disegnava per il divertimento dei principi spettacoli meravigliosi. Sì che quando tornò, che altro poteva fare, se non servire la Regina? Fu dama di Caterina d’Aragona, ma la Corte inglese le dovette sembrare barbarica al paragone di quella di Francia. Benché Enrico amasse lo splendore, lo ricercava al modo dei despoti d’Asia e d’Africa, a chili d’oro, come quella catena che portava sul petto – tre chili d’oro tempestato di sedici enormi spinelli, sedici ottaedri rosei e vinati.
Enrico la notò, e cominciò a corteggiarla. Le fece fare una collana d’oro di lettere maiuscole, la H e la S si alternavano a maglie a forma di colonna con la B come ciondolo. Dietro sua richiesta Holbein inventò molti gioielli per divertire i due amanti sempre con le iniziali H e A, o HISA, che significava Henry Immuable Serviteur Anne. Hilliard eseguiva il gioiello. Anna ed Enrico si corteggiarono così, inviandosi anelli, spille, medaglioni: “siccome non posso esser con te, ti mando la mia immagine montata in oro” scriveva lui; “tienila dove ti piace”. Lei a sua volta gli rimandava una spilla che raffigurava una donna pazza di dolore tutta sola su una nave in tempesta. Voleva così significare la sua difficile condizione di donna che amava un uomo ammogliato.
I gioielli sono stati l’orgoglio, il vanto del Regno, l’hanno fatto brillare più di altri. E li indossavano tutti, non soltanto i nobili, ma bancarottieri, giocatori d’azzardo, tagliaborse, ladri, scassinatori andavano abbigliati da gentiluomini. Tutta la nazione fu presa dalla stessa passione dell’ostentazione e dell’eleganza. C’era chi diceva che gli inglesi erano più sontuosi dei persiani, più vanitosi dei francesi e degli italiani, e tutti, proprio tutti, contadini, artigiani e cittadini comuni spendevano fortune in anelli, in vere nuziali, e anelli con lo stemma per il mignolo. Nello sfarzo generale non c’era differenza di grado e di rango; io feci, in verità, varie leggi contro questa babilonia, ma vuoi perché i mercanti mettevano in conto le multe, vuoi perché i magistrati non punivano, non servì a nulla. Perché i gioielli, vedi, non sono soltanto strumento di ostentazione di classe e di rango; in certi casi dichiarano l’intimo slancio amoroso, in altri affermano lealtà politiche, credenze religiose. In questo senso, sopratutto, li amavo anch’io.
Tra i tanti che possedevo, più di ogni altro amavo una collana a maglie d’oro a forma di alpha e di omega che al centro stringevano le parole gemma pretiosior intus. Non è così, Jack? La gemma più preziosa non è forse dentro? Non è l’anima? Proprio perché la superficie è vile, la decoriamo, la rivestiamo di gemme, volendo donarle una luce che gli occhi sappiano cogliere. L’aura della sovranità di che cos’altro è fatta? I gioielli sono il corredo del nostro mestiere di attori impegnati a far credere all’illusione che il bello e il bene si sposino in forme armoniose ed eterne. Ma rivelano anche un’altra verità del nostro mondo: come i gioielli, che sono effimeri e non durano – le pietre si staccano, lo smalto si sbrecca, le maglie della catena si allentano, gemme e orecchini si perdono – così è la vita. Se io mi ricoprivo di perle, come nel ritratto che mi fece Marcus Gheeraerts il giovane, in piedi sulla mappa dell’Inghilterra, era perché credevo nei simboli. In quel ritratto all’orecchio sinistro porto la sfera armillare, che mi era cara, perché era cara alla Bolena, che l’associava alla nuova scienza. Io la ripresi da lei: mi piaceva la sfera, era un invito a pensieri alti, mi trasportava a pensieri infiniti. È un paradosso interessante, ma può accadere che si affidi all’oggetto effimero il pensiero dell’eterno.
T’ho detto, Jack, da tempo penso e ripenso a mia madre. Dicono che c’è qualcosa nel volto della madre che non c’è in nessun altro, qualcosa che ho desiderato e sognato da bambina, qualcosa che ho cercato nelle governanti che mi hanno cresciuto, nelle Regine che mio padre via via sposava, ma non l’ho trovato, Jack. Però a volte ho l’impressione di ricordare la voce di Anna, chiara, cristallina, con una leggera inflessione straniera, per via degli anni passati in Francia. Se avevo tanta voglia di conoscere la Stuarda, era per questo; come mia madre, anche lei era vissuta in Francia, e parlava con una inflessione francese. Pare che fosse molto elegante. Se non volevo condannarla era anche perché mi riportava alla mente mia madre. Per la seconda volta nella storia del nostro paese si processava una Regina: perché Anna, come Maria Stuarda, era Regina. Con la differenza che Anna non aveva commesso nessuna delle colpe che le imputavano, lo sapevano tutti, in particolare chi l’accusava, quei funzionari solerti della corona, molti dei quali erano suoi parenti, saliti a quei gradi e incarichi grazie a lei. Tutti sapevano che Anna non era un’adultera, non aveva tradito in quel senso Enrico.
Quando il duca di Norfolk, suo zio e Gran Ministro della Real Casa, pronunciò la sentenza di morte, lei lo guardò negli occhi e disse: “Certamente altre devono essere le accuse, perché queste non stanno in piedi, non avete un briciolo di prova”. Era scossa, ma non riusciva a credere che non fosse una commedia, e presto sarebbe finita. Invece era una farsa e finì in tragedia.
Mi sono fatta raccontare più volte il modo in cui morì e mi sono convinta che fino alla fine non ci credette. Pensò che Enrico le avrebbe offerto una via d’uscita.
La sventura, Jack, è tremenda e spaventoso l’attaccamento alla vita. È proprio quando la vittima sale sul patibolo, che la vita messa a nudo grida di non voler cedere. Fu così anche per la lucida, la calcolatrice, l’idealista Anna Bolena, che aveva grandi progetti per sé e per il Regno; anche nel suo caso ci fu quell’attimo in cui in lei parlò la volontà di vita nuda e cruda, e dovette provarne orrore. Si accorse che desiderava la vita, la pura, nuda vita; sarebbe andata ad Anversa, avrebbe vissuto là, io sarei cresciuta. Non voleva morire, voleva vivere. Questo scoprì nelle prime ore dell’alba nel giorno che la portò al patibolo. Si illuse che Enrico l’avrebbe salvata. Se avesse davvero riflettuto, avrebbe capito che non poteva andare altrimenti da come andò, ma i miseri non hanno altra medicina che la speranza, il miracolo è la speranza degli sventurati. Ma non ci furono miracoli. E allora Anna si ricordò che qualche giorno prima che la portassero alla Torre era morto Little Purkey, lo spaniel che adorava. Anna amava i cani, aveva anche un bellissimo bracco italiano, Urien, ma Little Purkey era il suo favorito. Interpretò quella morte come un triste presagio.
Ti domanderai come so queste cose, Jack? Me le sono fatte raccontare, da chi la servì fino all’ultimo istante; una donna, di cui non ti dirò il nome, perché lei non avrebbe voluto, e poi non importa, ormai è morta, è soltanto un nome su una lapide, nient’altro. La Bolena le affidò l’incarico di sorvegliarmi e di seguire la mia educazione e lei non mi perse d’occhio, mi è stata sempre accanto senza rivelarsi, se non quando si sentì vicina alla fine, allora mi disse chi era e allora io volli sapere tutto di Anna e lei mi raccontò tutto per filo e per segno. Le era legata fin dall’infanzia, erano amiche, capisci? si volevano bene. L’aveva vista salire al trono, la seguì sul patibolo, l’accompagnò fin negli ultimi giorni e comprese ogni cosa.
Già prima non credeva ai suoi occhi, quando Enrico la nominò marchesa di Pembroke... Ci pensi, le diceva: da niente a marchesa! Non sei felice? Ma Anna scuoteva la testa: non è la corona in sé che voglio, diceva; voglio il bene dell’isola. Sai che cosa scelse come stemma? Un falcone con in mano uno scettro che s’alzava da una corona rovesciata, non è uno strano messaggio? Quando si celebrò la sua incoronazione, il silenzio nella grande abbazia pare fosse raggelante. Per un funerale, non sarebbe stato diverso. Secondo l’etichetta, Anna si mosse dalla Torre, risalendo il fiume su una barca meravigliosa, che era stata di Caterina d’Aragona. Fu il suo primo capriccio, volle proprio quella, e Caterina, che era ancora viva, impazzì di dolore. Ma ormai da tempo a Corte comandava Mademoiselle Anne. La grande nave, il fiabesco vascello risalì la corrente, le rive erano affollate di gente che guardava e taceva. Era il popolo d’Inghilterra, attonito. Faceva eco al loro silenzio, quello costernato degli uomini e delle donne di Corte. Nessun saluto, niente fazzoletti, neppure per asciugarsi le lacrime. Tanto più violento e a sproposito risuonò lo strepito delle fanfare, delle trombe, dei tamburi, dei cannoni che sparavano a salve; tutti suoni profani che spezzavano il sacro silenzio. Non meno spaventosamente vuoto risuonò lo spazio solenne di Westminster.
È strano, Jack, ma forse perché la memoria di Anna non è per me diretta, ma passa attraverso il racconto di un’altra donna, ho sempre avuto un senso penoso di irrealtà al riguardo. Era mia madre, mi avrà abbracciato, prima ancora mi aveva tenuto nel grembo; ma quel contatto non ha potuto farsi storia, parola. Tra me e lei c’è sempre stata una lama di vetro, è come se la vedessi al di là, sempre al di là del vetro, come forse l’an...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Colophon
- Personaggi principali
- Memorare novissima
- Sweet Mall
- L’imene impenetrabile
- L’amore
- La lepre fantasma
- Regina per nove giorni
- Che gli importa alla volpe?
- Il Fante e la Regina
- L’isola
- Chi eviterà la frusta?
- Il simbolo spezzato
- Aeterna Puella
- Lo specchio di Elisabetta
- Il paggio e la lattaia
- I sogni della Regina
- Elisabetta a teatro
- A cena da Cecil
- Nel segno della Vergine
- Jack e John
- Sic transit gloria mundi
- La mela matura
- Il docile agnello
- Indice