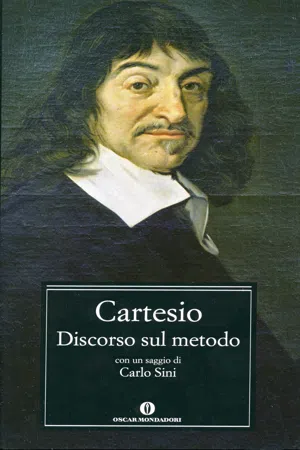
- 128 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Discorso sul metodo
Informazioni su questo libro
L'opera in cui René Descartes (1596-1650) teorizza il nuovo orientamento nel campo del sapere fondato sulla razionalità. Il manifesto della filosofia moderna, il nuovo metodo "per condurre la propria ragione e ricercare la verità nelle scienze".
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Discorso sul metodo di Cartesio, Marcella Renzoni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophy History & Theory. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Note
Parte prima
1. «Buon senso» è, come precisa subito Cartesio «la facoltà… di distinguere il vero dal falso.» Il buon senso quindi, si identifica con il «lume naturale» o ragione. In quanto proprietà essenziale della natura umana, che solo per il buon senso o ragione si distingue da tutti gli altri esseri della natura, il buon senso è uguale in tutti gli uomini. È questa una questione di diritto, perché di fatto gli uomini sono ben lontani dall’applicare come si deve questa facoltà. Ed è proprio all’applicazione del buon senso, cioè alla formulazione dei singoli giudizi, che si rivolge il metodo di Cartesio. La natura umana – spiega infatti Cartesio – non è solo «mente», ma è mente o anima unita a un corpo, e da questa unità sostanziale di anima e corpo dipendono le differenze di «immaginazione», di «memoria», di «attenzione», di «prontezza» che di fatto distinguono gli ingegni umani (esprits) gli uni dagli altri.←
2. Traduciamo, di solito, con «ingegno» il termine francese «esprit», richiamandoci (come sempre si è fatto) alla traduzione latina del Discorso sul metodo dovuta a Etienne de Courcelles, ma rivista e approvata da Cartesio. Tuttavia il termine francese «esprit» presenta uno spettro di significati che non coincidono costantemente con il termine «ingegno», quindi la necessità di tradurlo, talvolta, in maniera diversa: «anima», «mente». ecc. ←
3. «Accidenti», «forme», «individui» sono tutti termini scolastici. La forma è ciò che costituisce l’essenza necessaria di un essere, ciò che lo costituisce in quello che esso è; l’accidente è invece ciò che non appartiene all’essenza necessaria di un essere, e se per la forma gli individui sono tutti eguali, per gli accidenti essi invece si distinguono gli uni dagli altri.←
4. Nelle Regulae ad directionem ingenii (precisamente nella quarta) Cartesio aveva dato la seguente definizione di «metodo»: «Per metodo intendo delle regole certe e facili, grazie alle quali tutti coloro che le osservano esattamente, non prenderanno mai per vero ciò che è falso, e arriveranno senza alcuno sforzo inutile, ma accrescendo sempre il loro sapere, alla vera conoscenza di tutte quelle cose di cui sono capaci».←
5. Traduco in tal modo l’espressione francese «hommes purement hommes» con la quale Cartesio intende gli uomini considerati solo secondo le loro naturali capacità di esseri razionali, e non assistiti da un sovrannaturale soccorso della grazia divina.←
6. Nel 1637, data della pubblicazione del Discorso, Cartesio ha già definito nel Mondo il sistema generale della sua fisica; pubblica la Diottrica, le Meteore e la Geometria, e nella quarta parte del Discorso enuncia i princìpi della sua metafisica. La forte speranza che nutre per il futuro è di raggiungere pari conoscenze anche per quanto riguarda la medicina (cfr. la Parte sesta del Discorso).←
7. Il collegio di La Flèche, nell’Angiò, fondato dai gesuiti nel 1603. Cartesio probabilmente vi entrò nel 1606, per terminarvi il suo corso di studi nel 1614.←
8. Nel XVII secolo venivano di solito chiamate «curiose», le scienze che oggi si chiamano occulte: astrologia, chiromanzia, magia ecc.←
9. Il latino e il greco.←
10. Le arti tecniche. «Le matematiche inoltre appagano i curiosi.» Cartesio vuole qui alludere al modo, assai diffuso alla sua epoca, di presentare i problemi matematici sotto forma di enigmi.←
11. L’insegnamento della matematica nei collegi tenuti dai gesuiti aveva un orientamento prevalentemente pratico. Cartesio non sottovaluterà mai le applicazioni della matematica alle arti meccaniche, ma, come è evidente da questa riflessione, le «matematiche» hanno per lui una fondazione e una giustificazione puramente teorica.←
12. Chiaro riferimento alla morale degli stoici, che Cartesio aveva sicuramente appreso fin dagli anni del collegio, soprattutto attraverso la lettura di Seneca. Le critiche che qui Cartesio rivolge alla morale stoica sono quelle tradizionalmente codificate in ambienti cristiani per svalutare qualsiasi «virtù» che non derivasse i propri princìpi dalla fede in Cristo. Si noti però, nella Parte terza di questo stesso Discorso, una ben diversa valutazione da parte di Cartesio, della morale stoica.←
13. Passo ambiguo con trasparenti venature di ironia. Vi si può leggere un netto rifiuto della teologia in genere, o anche, in un senso meno forte, soltanto una critica della teologia scolastica, considerando che Cartesio, in seguito, non escluderà la possibilità di una teologia fondata sui suoi princìpi filosofici, da lui considerati come gli unici suscettibili di accordo con la fede cristiana. Qui, comunque, il testo afferma espressamente solo che la fede non può avere come giudice la semplice ragione.←
14. Questa affermazione sulla diversità delle opinioni filosofiche e sulle dispute alle quali esse danno luogo, non è soltanto una riflessione generica, ma si riferisce anche al modo con il quale la filosofia veniva svolta nelle scuole, in particolare in quelle tenute dai gesuiti, dove la disputa aveva una parte essenziale nell’insegnamento filosofico.←
15. La famiglia di Cartesio apparteneva alla piccola nobiltà di provincia. Il suo patrimonio, sicuramente modesto, gli assicurò tuttavia una rendita sufficiente per poter vivere in modo del tutto indipendente, senza doversi piegare ad accettare impieghi o cariche, che gli assicurassero altre fonti di guadagno.←
16. «Studiare così nel libro del mondo», luogo comune ormai consolidatosi fin dal Rinascimento come manifestazione di insofferenza verso un sapere che si nutriva di soli libri e non affondava direttamente lo sguardo su ciò che è reale: la natura o la vita concreta degli uomini. D’altra parte i viaggi di Cartesio per i vari paesi di Europa, come il suo arruolarsi negli eserciti di Maurizio di Nassau o in quelli imperiali, per partecipare alle prime campagne della guerra dei Trent’anni, corrispondono al tipico apprendistato di ogni gentiluomo francese dell’epoca, così come lo erano stati anche gli anni di studio trascorsi in collegio.←
Parte seconda
1. La guerra dei Trent’anni che, scoppiata nel 1618, si concluderà soltanto nel 1648. Nel mese di aprile del 1619 Cartesio aveva lasciato Amsterdam per recarsi in Danimarca e quindi, secondo il suo progetto, in Polonia e in Ungheria. Tuttavia è poco probabile che egli possa aver visitato anche questi due ultimi paesi se già nel luglio si trovava in Germania per assistere a Francoforte all’incoronazione imperiale di Ferdinando re di Boemia e di Ungheria.←
2. Probabilmente in un villaggio presso la città di Ulma. L’esercito cui fa cenno Cartesio è quello di Massimiliano di Baviera, che si accingeva a combattere Federico, principe palatino.←
3. In questo e nei seguenti capoversi Cartesio sostiene l’unità delle scienze, riportandosi al momento della sua vita, il 1619, quando per la prima volta concepì questa idea. Il biografo di Cartesio, Baillet (Vie de M. Descartes, 1691), ci ha tramandato, traendola da alcuni manoscritti giovanili del filosofo ai quali egli poteva ancora attingere, la narrazione che lo stesso Cartesio ci ha lasciato di questo avvenimento rimasto fondamentale nella sua vita. Si tratta del resoconto di tre sogni che Cartesio afferma di avere avuto la notte dell’11 novembre 1619 («XI novembris coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis»):
«Egli stesso ci dice (CART. Olymp. init. ms.) che il 10 novembre 1619, essendo andato a letto “tutto pieno del suo entusiasmo” e tutto preso dal pensiero “di aver trovato quel giorno i fondamenti di una scienza meravigliosa”, ebbe tre sogni di seguito in una sola notte, che immaginò non potessero esser venuti che dall’alto. Dopo essersi addormentato, la sua immaginazione si sentì colpita da taluni fantasmi che gli si presentarono e lo spaventarono in modo tale che, credendo di camminar per le strade, era obbligato a poggiarsi tutto sul fianco sinistro per andare dove voleva, perché aveva una grande debolezza al lato destro, e non poteva reggersi. Si vergognava di camminare a quel modo, e fece uno sforzo per raddrizzarsi; ma sentì un vento impetuoso che trascinandolo in una specie di turbine lo fece girare tre o quattro volte sul piede sinistro. Ma non fu questo che lo spaventò. La difficoltà che provava a trascinarsi, faceva sì che gli sembrasse di cadere a ogni passo, finché, avendo visto un collegio aperto sulla sua strada, vi entrò per trovare un rifugio e un rimedio al proprio male. Cercò di raggiungere la chiesa del collegio, dove era suo primo pensiero andare a pregare; ma si accorse di aver sorpassato una persona di sua conoscenza senza salutarla, e volle tornare sui propri passi per farle omaggio; il vento però lo respinse con violenza soffiando contro la chiesa. Nello stesso tempo vide in mezzo al cortile del collegio un’altra persona che lo chiamò per nome in termi...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione di Carlo Sini
- Bibliografia
- Discorso sul metodo
- Avvertenza
- Parte prima
- Parte seconda
- Parte terza
- Parte quarta
- Parte quinta
- Parte sesta
- Note
- Copyright