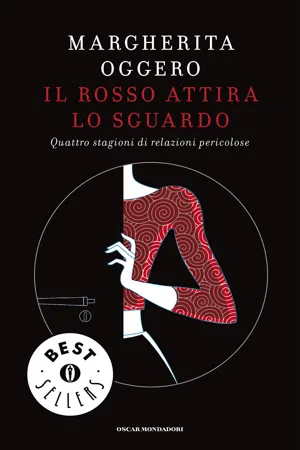![]()
AUTORIPARAZIONI ALLIEVI: così stava e sta ancora scritto nell’insegna sulla porta dell’officina. Allievi, Oreste Allievi, era il proprietario e il mio boss: nell’officina ci lavoravo da quasi un anno, cioè da quando avevo mollato il liceo, perché studiare non è mai stato il mio pane. Cioè: andare a scuola mi piaceva e non mi annoiavo ad ascoltare i professori, ma il brutto arrivava dopo, quando dovevo mettermi a fare versioni, esercizi, riassunti e a studiare le lezioni. Invece i motori mi erano sempre piaciuti e mi piacciono, li capisco subito senza faticare, insomma ho l’orecchio giusto per scoprire dove hanno la magagna. E Oreste, che non era scemo, dopo avermi preso in prova mi aveva tenuto, perché un altro come me aveva ancora da trovarlo. Non per vantarmi, ma neppure Loris, l’aiutante di prima, ce ne capiva altrettanto, anche se era un draghetto e Oreste aveva quasi pianto quando si era licenziato. Ma a Loris gli era convenuto, dato che aveva sposato una di Rivarolo che i suoi avevano un autosalone, e andando a fare il meccanico preparatore da loro avrebbe guadagnato di più.
Oreste era grande e grosso, una montagna, parlava solo quando serve e non rompeva l’anima se smettevo due minuti per fumarmi in pace una sigaretta, e neppure se arrivavo un po’ in ritardo, perché sapeva benissimo che il tempo delle sigarette e del ritardo lo recuperavo sempre, e alla sera non mollavo il lavoro quattro a zero quando l’orologio della Michelin sopra il bancone degli attrezzi segnava le sette. Invece lui all’una meno venti era come se gli piantassero un punteruolo nel sedere: mollava tutto, si lavava le mani, saltava in macchina e filava a casa, perché sua moglie Teresa voleva mangiare all’una spaccata e non c’era santo che tenesse. Mai capite certe donne, quelle che cade il mondo se entri in casa con le scarpe bagnate, se fai le briciole sotto il tavolo, se lasci le ditate sui vetri o sugli specchi: va bene che a pulire tocca a loro, però ci sono cose più serie su cui incistarsi. Oppure le loro sono ossessioni in cui sfogano la malattia della vita. Comunque Oreste non si lamentava, si vede che gli andava bene così.
Di fronte all’officina c’era e c’è la scuola media statale MARIA GIUSTA CATELLA – SCRITTRICE, e a me faceva ridere l’idea di allievi che in teoria potessero autoripararsi, ma in pratica no, perché quando arrivavano al mattino eravamo ancora chiusi e quando uscivano all’una io stavo tirando giù la serranda e mi guardavo le ragazze di terza che erano già appetitose. Non tutte, però: ce n’erano certe brufolose e culone che si davano le arie da dure e invece si capiva subito che ci pativano un casino per le pustole e la ciccia; c’erano quelle che si credevano fighette e se la tiravano da dive anche se bisognava essere di bocca buona per trovarle passabili; e c’erano anche quelle – ma poche – che non erano ancora né carne né pesce e non si capiva come avrebbero buttato da femmine vere.
Ma le guardavo solo così per curiosità, per far lavorare gli occhi, dato che io una ragazza ce l’avevo e stavamo insieme da più di due anni. Lei, Lorella, di anni ne aveva diciassette come me, dopo le medie aveva fatto la scuola di Hair Stylist e a quei tempi lavorava nel salone di un parrucchiere di grido, che però anche se lei aveva il diploma, non le lasciava fare il taglio alle clienti. Così Lorella se n’era poi venuta via ed era andata a lavorare da Liliana Acconciature, che era un negozio un po’ da tamarre, ma dove la padrona l’aveva lasciata subito tagliare e fare pratica vera da pettinatrice, non solo lavare le teste, mettere i bigodini o asciugare col fon. Io a Lorella volevo bene, ma era una cosa tranquilla, e non mi andava di incontrarci tutte le sere, perché mi piaceva anche stare con i miei amici, andare a vedere le partite della Canavese che giocava in C2 e siccome in squadra c’era uno che conoscevo avevo i biglietti gratis. E qualche volta che ero andato in discoteca senza dirlo a Lorella, e avevo anche rimorchiato, dopo non è che avessi avuto dei rimorsi, perché pensavo che era giusto che mi facessi le mie esperienze dato che non eravamo fidanzati-fidanzati con l’anello. Lei, però, quando andavamo a passeggio in via Garibaldi, si fermava sempre davanti ai negozi di vestiti da sposa, mi chiedeva se sarebbe stata bene con questo o con quello e non è che ci volesse un genio per capire che era un modo di dirmi che tirava al matrimonio, magari con l’abito bianco, anche se a letto insieme ci andavamo già da un bel pezzo, di nascosto dai suoi, si capisce, perché i padri e le madri delle ragazze credono sempre che due che stanno insieme aspettino la notte di nozze per fare sesso. Oppure fingono di crederlo per stare tranquilli.
Era il quindici di aprile e avevo compiuto diciotto anni da tre giorni. La patente ce l’avevo già – non proprio la patente, ma l’autorizzazione a guidare –, la macchina non ancora. Di soldi ne avevo messi da parte un bel po’, ma si capisce che non bastavano e i miei avevano promesso di aiutarmi, però si era messo di mezzo Oreste, dicendo che la prima macchina va sempre presa di seconda mano, perché uno può essere in gamba finché si vuole, ma un po’ la strapazza sempre. Così si era incaponito che la macchina doveva trovarmela lui a un prezzo stracciato e con la carrozzeria a posto, dato che al motore ci avremmo pensato noi. Io avrei voluto un’Alfetta ma lui aveva scosso la testa, borbottando che era meglio che pisciassi più corto e non facessi troppo il gadano.
Così quel quindici aprile all’una avevo tirato giù la serranda, stavo in sella al Ciao e prima di metterlo in moto ripassavo con gli occhi le ragazze, caso mai nelle vacanze di Pasqua qualcuna fosse sgusciata dall’uovo diversa da prima. Invece no, erano sempre uguali, di diverso c’era solo che avevano smesso giubbotti e bomber e stavano più sul leggero, qualcuna aveva anche giubilato i jeans e inaugurato la minigonna, ma di gambe da minigonna non ce n’erano proprio, tutte tracagnotte o con polpacci da ciclista, insomma la MARIA GIUSTA CATELLA – SCRITTRICE non era un vivaio di pin-up. Intanto se n’era venuto via anche il grosso delle prof, cioè la brigata menopausa, poi erano sciamate le supplenti giovani, tutte con l’aria stremata da maratonete prima degli ultimi cento metri, e dopo ancora la Fragolona, una quarantenne oversize sempre vestita di rosso e straripante dai vestiti. Il rosso è un colore che acchiappa subito lo sguardo, e una come lei avrebbe fatto bene a usarlo con maggiore discrezione.
Poi, quasi per ultima, è uscita dal portone una ragazza nuova, mai vista prima. E su di lei mi sono incantato. Alta, ma non troppo, sottile, ma non troppo. Né jeans né minigonna, ma un vestito leggero color lilla chiaro e sopra un golfino sempre lilla ma più scuro. Uno zainetto bianco e piccolo le penzolava dalla mano sinistra, scarpe basse, di vernice nera col cinghietto, scarpe da bambina, ma lei non era una bambina. O meglio, lo era e insieme era qualcos’altro, che non sapevo definire. Non intruppata con le compagne, ma senza l’aria spaesata, anzi. Quando i nostri sguardi si sono incontrati, a me il cuore è andato a mille, a lei devo essere sembrato un pezzo di arredo stradale. Sempre da sola, ha svoltato l’angolo e si è diretta alla fermata del bus. Che, come per un miracolo a rovescio, è arrivato subito e se l’è portata via.
Non ho seguito il bus, me ne sono andato a casa a mangiare. Mia mamma lavorava in una focacceria ligure, orario part time dalle dieci alle quindici, e prima di uscire mi preparava la tavola e il pranzo. Mio padre faceva l’impiegato amministrativo delle ferrovie e pranzava in mensa. A me non dispiaceva mangiare da solo: mi scaldavo la minestra, la carne e la verdura, qualche volta un pezzo di pizza o di focaccia del giorno prima, ascoltavo musica, mi scolavo una birretta piccola e pensavo ai fatti miei. Quel giorno ho pensato alla ragazzina in lilla quasi senza interruzione. E alla sera, quando sono andato al cine con Lorella non ci stavo con la testa e il film non riuscivo neppure a seguirlo. Lei a un certo punto se n’è accorta, mi ha chiesto cos’avevo e io le ho risposto niente, vorrei solo che Oreste si sbrigasse a trovarmi la macchina.
Il giorno dopo, all’una, ero di nuovo a cavallo del motorino ad aspettare che la ragazza in lilla uscisse. E lei è uscita proprio per ultima, mentre il bidello stava già chiudendo a metà il portone e io cominciavo a temere che non l’avrei mai più vista. Le altre e gli altri si erano già allontanati, la strada era sgombra. Ho messo in moto con l’intenzione… non ricordo bene, forse avevo solo l’intenzione di avvicinarmi per vederla meglio, e lei, quando i nostri occhi si sono di nuovo incrociati, ha fatto un piccolo sorriso, ha sollevato il braccio destro, quello da cui non pendeva lo zainetto, ha portato la mano davanti al viso, ha scosso l’indice nel segno del no e ha tirato dritto.
No cosa? no, che non mi vuoi parlare; no, che non vuoi salire sul motorino? ma il piccolo sorriso allora cosa c’entra? perché l’hai fatto? Non era un sorriso di commiserazione, di rifiuto totale e senza appello, era un sorriso gentile, un po’ divertito, ma non contro di me, quasi un sorriso di complicità, come se facesse parte di un gioco.
È andata avanti così per una settimana, io sul motorino, lei che usciva sempre per ultima, mi guardava e l’unica variante era che il no lo faceva scuotendo appena la testa, un no piccolo piccolo, quasi impercettibile. Ma io nel frattempo avevo braccato Mimmo Mollino, che era l’allievo più tenace della MARIA GIUSTA CATELLA, in pratica una cozza, che ripeteva la terza e aveva già ripetuto la prima e la seconda. Quell’anno lì gli avrebbero poi dato la licenza per toglierselo dai piedi, anche se non dava fastidio né ai compagni né ai professori, ma insomma era un primato negativo che uno ci mettesse sei anni a fare le medie. Una volta gli avevo chiesto se non era noioso sentire sempre per due volte le stesse cose, e lui aveva risposto di no, che era come quando uno si vede la cassetta di un film due volte e la seconda gli piace di più perché si ricorda qualcosa.
«Mimmo» gli ho chiesto intercettandolo ai giardinetti, «ne sai qualcosa di quella ragazza nuova, quella coi capelli biondo scuri?»
«Quella della seconda C?»
«Quella che ogni tanto mette un vestito lilla chiaro.»
«Fighetta, eh? Ma sta troppo sulle sue. La chiamano ice-queen.»
«Spiritosi! E il nome vero?»
«Perché, vuoi provarci?»
«Che ti frega? Il nome lo sai o no?»
«Nadia Bonelli.»
«E come mai è arrivata solo adesso?»
«Trasferita.»
«Da dove?»
«Non lo so. Non lo sa nessuno. Le bidelle dicono solo trasferita da altra scuola.»
Mimmo con le bidelle aveva un rapporto privilegiato. Quando era stufo di stare in classe, usciva in corridoio a chiacchierare, a prendere il caffè, a leggere “Novella 2000” con loro, o a fare le parole incrociate, scrivendo a matita leggero leggero perché si potessero cancellare e rifare. Non riusciva mai a finirle, perché sbagliava le definizioni e quindi le caselle non quadravano. Però sapeva sempre un mucchio di cose sugli altri ragazzi e...