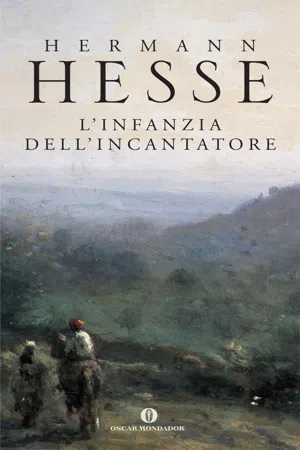![]() L’infanzia dell’incantatore
L’infanzia dell’incantatore![]()
L’infanzia dell’incantatore1
Sempre risalgo alla tua fonte,
Cara leggenda di un tempo passato;
Odo l’aureo tuo canto di lontano,
Come ride, e poi sogna, e piange piano.
Ammonitrice nasce dal profondo
Sussurrando la magica parola;
Sento come fossi ebbro, e dormendo
Ti sentissi chiamarmi ancora e ancora.
Non solo da genitori e maestri io venni educato, ma anche da più alte, misteriose e segrete potenze, e fra esse ci fu pure il dio Pan che stava in un armadio a vetri di mio nonno nella figura di un piccolo idolo indiano danzante. Questa e altre divinità si sono prese cura della mia infanzia, e, ben prima ch’io imparassi a leggere e a scrivere, mi hanno talmente riempito di antichissime immagini e pensieri d’Oriente, che in seguito ogni incontro coi saggi indiani e cinesi mi è parso un ritrovamento, un ritorno. Eppure sono europeo, nato perfino sotto il segno attivo del sagittario, e ho praticato bravamente per tutta la vita le virtù occidentali dell’azione, della bramosia e dell’insaziabile curiosità. Per fortuna, come la maggior parte dei bambini, ho imparato già prima della scuola tutto ciò che per la vita è più prezioso e indispensabile; ero stato ammaestrato dai meli, dalla pioggia e dal sole, dal fiume e dai boschi, dalle api e dagli scarabei; ero stato ammaestrato dal dio Pan, l’idolo danzante nella camera dei tesori del nonno. Ne sapevo abbastanza del mondo, m’intrattenevo senza paura con gli animali e con le stelle, mi ritrovavo nei frutteti e nell’acqua coi pesci, e sapevo già cantare un buon numero di canzoni. Sapevo anche fare incantesimi, cosa che purtroppo disimparai presto e solo in età più avanzata dovetti di nuovo mettermi ad apprendere; e disponevo di tutta la favolosa saggezza dell’età infantile.
Poi vi si aggiunsero le materie scolastiche, che mi riuscirono facili e mi divertirono. La scuola era abbastanza assennata da non occuparsi di quelle preparazioni serie che sono indispensabili per la vita, bensì prevalentemente di giocondi e simpatici passatempi in cui trovavo spesso piacere; e mi impartì nozioni, che in parte mi sono rimaste fedeli per tutta la vita; così so ancora oggi molte belle e spiritose parole latine, e versi e proverbi, come anche il numero degli abitanti di parecchie città in tutte le parti del mondo; naturalmente non quelli di oggi, ma dell’epoca intorno al 1880.
Fino al tredicesimo anno non mi sono mai seriamente preoccupato di che cosa dovessi diventare, quale mestiere dovessi imparare. Come tutti i ragazzi ammiravo e invidiavo certe attività: il cacciatore, il battelliere, il barrocciaio, il funambolo, l’esploratore polare. Ma di gran lunga avrei preferito diventare un incantatore. Questa era la direzione più profonda e più intimamente sentita dei miei istinti: una certa scontentezza di ciò che si chiamava “realtà” e che a volte mi sembrava soltanto una stupida convenzione degli adulti. Un certo grado di rifiuto ora ansioso ora ironico di tale realtà mi fu ben presto familiare, e insieme l’ardente desiderio di incantarla, di trasformarla, di intensificarla. Nell’infanzia quel desiderio di magia si volgeva a scopi esteriori e puerili: avrei voluto far crescere mele d’inverno, colmare per incanto il mio borsellino d’oro e d’argento; sognavo di paralizzare i miei nemici con una formula magica e poi di confonderli con la mia magnanimità, per essere infine proclamato vincitore e re; volevo estrarre tesori seppelliti, risuscitare morti e rendermi invisibile. Specialmente il diventare invisibili era un’arte della quale facevo gran conto e a cui aspiravo dal profondo del cuore. Quel desiderio, anzi quello di possedere tutti i poteri d’un mago, mi accompagnò per tutta la vita sotto diverse forme, che talvolta io stesso non sapevo subito riconoscere. Così fu che più tardi, quando ormai adulto esercitavo la professione di letterato, mi accadde spesso di tentar di scomparire dietro le mie opere, di ribattezzarmi, di nascondermi dietro pseudonimi scherzosi e significativi... esperimenti che dai colleghi, con mio stupore, sono stati spesso male accolti e interpretati. Se guardo indietro, vedo la mia vita intera sotto il segno di questo desiderio di magica potenza; vedo come se ne sono mutati col tempo gli scopi, come gradatamente li ho sottratti al mondo esterno per assorbirli in me, come a poco a poco ho preso a non più voler mutare le cose ma me stesso e ho imparato a cercar di sostituire alla goffa invisibilità del manto fatato quella del sapiente, che comprendendo sempre rimane incompreso... e questo in fondo è il contenuto dell’intera mia biografia.
Ero un ragazzo vivace e felice, giocavo col mio bel mondo multicolore, e mi sentivo a posto ovunque, non meno con gli animali e le piante che nella foresta vergine della mia stessa fantasia e dei miei sogni; lieto delle mie forze e delle mie capacità, e più estasiato che consumato dagli ardenti desideri. Un po’ d’arte magica allora la praticavo, senza saperlo, assai più compiutamente di quanto mi sia mai riuscito in seguito. Con facilità mi attiravo simpatia, con facilità acquistavo ascendente sugli altri, e mi trovavo ad essere il capo, quello che è corteggiato e avvolto di mistero. Compagni e parenti di me più giovani per anni si piegarono a credere reverentemente a un mio effettivo potere magico, alla mia signoria sui demoni, al mio diritto a tesori o a corone nascoste. Vissi a lungo nel paradiso, sebbene i miei genitori mi abbiano fatto conoscere per tempo il serpente. A lungo durò il mio sogno infantile; il mondo mi apparteneva, tutto era presente, tutto bene disposto intorno per il bel gioco. Se a volte nasceva in me un senso di insoddisfazione e di nostalgia, se appena il mondo gioioso mi appariva adombrato e dubbio, ecco che trovavo facilmente la strada per rifugiarmi nel regno della fantasia, più libero e privo di resistenze; e ritornandone ritrovavo il mondo esterno nuovamente amabile e caro. A lungo vissi nel paradiso.
C’era un recinto, nel piccolo giardino di mio padre, in cui tenevo conigli e un corvo addomesticato. Lì io dimoravo per ore infinitamente lunghe, lunghe come ere, nel tepore e nella gioia del possesso: i conigli odoravano di erba e di latte, di sangue e di procreazione, e il corvo aveva nel duro occhio nero un lampo di vita eterna. Lì ancora mi soffermavo lunghissimi momenti di sera, con un resto di candela accesa, accanto alle calde bestie sonnolente, solo o con un amico, intento a far piani per il ritrovamento di immensi tesori, per la conquista della radice di mandragola o per vittoriose cavalcate attraverso il mondo da riscattare: condannavo i briganti, redimevo gli infelici, liberavo i prigionieri, distruggevo col fuoco i castelli dei predoni, facevo crocifiggere i traditori, perdonavo vassalli infedeli, conquistavo figlie di re e comprendevo il linguaggio delle fiere.
C’era un grossissimo e pesante volume nella vasta biblioteca di mio nonno, in cui spesso frugavo e leggevo. In quel libro inesauribile si trovavano delle vecchie bizzarre illustrazioni, e a volte mi venivano subito incontro chiare e invitanti al primo aprire e sfogliare, a volte le cercavo invano: erano scomparse, per magia, come se non ci fossero mai state. Vi era narrata una storia che leggevo spesso, infinitamente bella e incomprensibile. Anche quella non si poteva trovare sempre, occorreva che il momento fosse favorevole: ora era sparita e si teneva nascosta, ora sembrava aver cambiato posto; certe volte era alla lettura stranamente cordiale e pressoché comprensibile, certe altre appariva oscura e chiusa come la porta della soffitta dietro la quale si sentivano nell’oscurità gli spiriti che ridacchiavano e gemevano. Tutto era reale, e tutto era incantato; realtà e incantesimo prosperavano fiduciosi l’uno accanto all’altra, e tutt’e due mi appartenevano.
Anche il danzante dio indiano che stava nell’armadio dei tesori del nonno non era sempre lo stesso idolo, non sempre aveva lo stesso volto, non danzava sempre la stessa danza. A volte era un idolo, una figura insolita e un po’ stravagante, come ne venivano fatte e venerate in lontani inimmaginabili paesi da popoli stranieri e inimmaginabili. In altri momenti era un oggetto stregato, pieno di significati e indicibilmente sinistro, bramoso di vittime, malvagio, severo, infido, ironico, che sembrava invitarmi a ridere di lui per potersene vendicare. Mutava direzione al suo sguardo, sebbene fosse di metallo giallo; a volte era strabico. Altre volte ancora era solo un simbolo, né brutto né bello, né buono né cattivo, né ridicolo né tremendo, ma semplice, vecchio e imperscrutabile come una runa, come una chiazza di muschio sulla roccia, come un disegno su una selce; e dietro la sua forma, dietro il suo volto e la sua immagine, abitava Dio, dimorava quell’infinito che allora, ragazzo, conoscevo e onoravo, pur senza dargli un nome, non meno di quando in seguito lo chiamai Shiva, Visnu, oppure Dio, Vita, Brahma, Atman, Tao, o eterna Madre. Era padre e madre, era uomo e donna, sole e luna.
Nei pressi dell’idolo, nella vetrina e in altri armadi del nonno, stavano appesi o posati molti altri esseri e oggetti: collane di grani di legno come rosari, rotoli di foglie di palma incisi col graffito di una antica scrittura indiana, tartarughe tagliate nella steatite verde, figurine di dèi fatte di legno, di vetro, di quarzo, di argilla, stoffe di seta o di lino ricamate, coppe e chicchere di ottone; e tutto ciò veniva dall’India e da Ceylon, l’isola paradisiaca con le felci giganti e le rive orlate di palmeti e i dolci singalesi dagli occhi di gazzella; veniva dal Siam e dalla Birmania, e tutto odorava di mare, di spezie e di lontananza, di cannella e di legno di sandalo, tutto era passato per mani brune e gialle, bagnato dalla pioggia dei tropici e dall’acqua del Gange, prosciugato dal sole dell’equatore, ombreggiato dalla foresta vergine. Tutte queste cose appartenevano al nonno, e lui, il vecchio, il nobile, il possente, con la sua gran barba bianca, era onnisciente, era più importante che papà e mamma, ed era in possesso di ben altri tesori e potenze: suo era non soltanto il dio-giocattolo indiano e tutta quella roba intagliata e dipinta e consacrata magicamente, calici di noce di cocco e cassapanche di legno di sandalo, sala e biblioteca, ma egli stesso era un mago, un sapiente, un saggio. Conosceva tutte le lingue umane, più di trenta, fors’anche quella degli dèi, fors’anche quella delle stelle; sapeva scrivere e parlare in pali e in sanscrito, sapeva cantare canti canaresi, bengalesi, indostani, singalesi, conosceva i riti dei maomettani e dei buddisti, sebbene fosse cristiano e credesse al Dio uno e trino; era stato per anni e per decenni nei caldi e pericolosi paesi dell’Oriente, aveva viaggiato su battelli e su carri tirati da buoi, su cavalli e su muli, nessuno sapeva così bene come lui che la nostra città e la nostra terra erano solo una piccolissima parte del mondo, che mille milioni di uomini avevano una religione diversa dalla nostra, altri costumi, altre lingue, altro colore di pelle, altri dèi, altre virtù e altri vizi che noi. Era lui che io amavo, veneravo e temevo, da lui aspettavo tutto, lo credevo capace di qualsiasi cosa; da lui e dal suo dio Pan camuffato da idolo imparavo incessantemente. Quest’uomo, il padre di mia madre, era avvolto nel mistero come la sua faccia era circondata dal bianco boschetto della barba; dagli occhi fluivano alternandosi il lutto universale e la serena saggezza, solitaria sapienza e divina birichineria; lo conoscevano, lo veneravano e venivano a visitarlo uomini di molti paesi, parlavano con lui inglese, francese, indiano, italiano, malese, e dopo lunghi colloqui se ne ritornavano via senza lasciar traccia, forse amici suoi, o forse suoi messi, o servi incaricati. Sapevo che da lui, l’immenso, aveva origine anche il mistero che circondava mia madre, il nascosto antichissimo mistero; anche lei era stata a lungo in India, parlava e cantava in malese e in canarese, e scambiava col padre canuto parole e motti in magici idiomi stranieri. E come lui anch’essa aveva il sorriso distaccato, il sorriso velato della saggezza.
Diverso era mio padre. Egli era solo. Non apparteneva né al mondo degli idoli del nonno né alla banale vita di tutti, egli stava in disparte, solo, un sofferente e un ricercatore, erudito e benigno, senza falsità e pieno di zelo al servizio del vero, ma ben lontano da ogni sorriso, nobile e dolce, ma limpido, senza alcun segreto. Non lo abbandonavano mai né la bontà né l’intelligenza, ma neppure egli scompariva mai nella magica nuvola del nonno, il suo volto non si perdeva mai in quell’espressione infantile e divina, la cui mimica appariva ora come dolore, ora come fine ironia, ora come la maschera di un dio silenziosamente concentrato in se stesso. Mio padre non parlava con mia madre in dialetto indiano, bensì in inglese e in un puro, limpido e bel tedesco lievemente tinto di baltico. Fu con questa parlata che egli mi attirò a sé, mi conquistò e mi istruì; io mi sforzavo a volte, pieno di ammirazione e di entusiasmo, di giungere al suo livello, addirittura con un eccesso di zelo, benché sapessi che le mie radici erano più profondamente piantate nel terreno di mia madre, nei suoi occhi scuri e nel suo mistero. Mia madre era piena di musica, mio padre no, non sapeva cantare.
Accanto a me crescevano delle sorelle e due fratelli maggiori: fratelli gr...