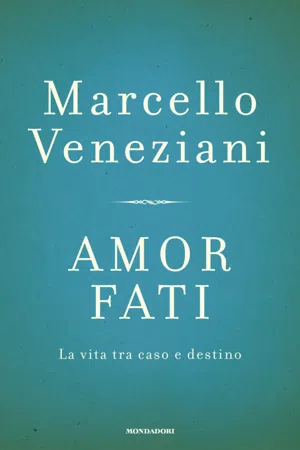![]()
X
Solitudo et plenitudo
Soli, cioè in compagnia del destino
La solitudine della vecchiaia. Che dire di un uomo di novantacinque anni trovato nella notte nel suo letto abbracciato a una ragazza di trent’anni, che lo assiste? Che non merita ironie e rimproveri, ma sguardi delicati e tenere carezze, perché salutava la vita e l’amore prima di offrirsi alla sorte. Parlo di un uomo che sente e vede la sua vita sempre meno e non solo per l’udito sordo e la cecità incipiente, ma perché l’avverte allontanarsi giorno dopo giorno e compie a senso alterno i suoi esorcismi e le sue rese. E una notte, la temuta notte, lo trovano avvinghiato alla più giovane, alla più avvenente delle sue badanti. Lei che spiega con disagio e meraviglia: non so cosa gli ha preso stanotte, non l’aveva mai fatto; lui scoperto dalla figlia che finge sorpresa e mostra torpore, o forse il contrario. Di solito la notte si lamenta, dà voce per avere voce, come una sentinella sull’orlo del nulla che vede ombre di tartari all’orizzonte; chiede più volte di orinare, sarà la prostata, sarà il terrore della solitudine notturna; si alza, sospira, chiama la figlia, poi la badante, infine chiama la morte. Vive la sua morte ogni giorno, la invoca e la teme, spavaldo per spavento. Vuol provare la sua presenza con la petulanza, vuole scacciare l’assenza, farsi vivo. Allestisce cerimonie notturne di egoismo per dimostrare che esiste, e vuol essere al centro del suo piccolo universo. Ma quella era una notte tiepida d’agosto, c’era la luna piena, l’aria era calda e leggera e la sua dolcezza non escludeva nessuno, neanche i vecchi. E così le ha chiesto di entrare nel suo letto matrimoniale, di mettersi al suo fianco, e l’ha cinta in un abbraccio, ha cercato pure la sua bocca. Il giorno dopo diceva di non voler più avere come badante quella ragazza, come se fosse stato molestato lui o si vergognasse per l’accaduto e volesse cancellare la prova vivente del misfatto; o forse no, quella richiesta è un capriccio e una vendetta, s’aspettava qualcosa in più da lei, un bacio, una carezza, un soffio di complicità.
Facile sorridere, facile deprecare. Si è bevuto il cervello, che figura. Invece io ti capisco, padre, ti capisco. Non oso spiegare con la demenza senile il tuo fittizio disperato amplesso, quel sussulto di giovinezza misto a carenza antica di maternità. In quell’abbraccio c’era il ragazzo di una volta, c’era l’uomo, ma c’era anche il bambino. Si cumulavano in quel gesto tante età. C’erano i vent’anni dei suoi primi amori, c’erano i settant’anni dei suoi ultimi amplessi, c’erano gli abbracci infantili dei tre anni. E c’era la somma esatta di quelle età, che tutte le abbracciava, insieme alle loro pulsioni e al loro ricordo sfatto. Quel bisogno di sentirsi ancora un corpo e non una malattia, di sentire la vita e non solo la sua evanescenza. Una vita che sbiadisce e cerca occasioni estreme e furtive, come ladri nella notte. Forse c’è la rivalsa involontaria contro la gioventù; tu nipote esci quando io vado a letto, per una volta torni a notte fonda e mi trovi sveglio che abbraccio una donna, perché la vita riguarda pure me, non vegeto soltanto. Nella vita ho ancora permesso di soggiorno e so che il letto non serve solo per il sonno e l’infermità.
Però fa male vedere la dignità di un uomo ridotta in vecchiaia a mendicare un bacio. Ti trattano come un ingombro, occasionali badanti ti danno del tu e ti riducono a pacco, bimbo demente; ti scansano i più giovani. Come finisce male una vita longeva, in quale imbuto. Una vita sobria e rispettata che termina nei gesti estremi del suo mangiare con la testa nel piatto, nel suo digerire senza riguardi, nel suo spogliarsi senza ritegno davanti a chiunque. Lo capisco quando se la prende col suo medico che col pacemaker gli ha prolungato una vita che reputa ormai di troppo. Vorrei finire anch’io prima della notte; capisco le sue invocazioni di congedi, la vita sarà un valore, ma se vissuta con dignità. Altrimenti è sopravvivenza animale che cancella in un’appendice vergognosa biografie operose e decorose.
E pure l’ho immaginato quella notte nella sua vecchia camera da letto, con i morti tutti a vegliare sul comò, madri, padri, moglie e santi, con un lumino acceso moltiplicato per tre volte da altrettanti specchi e un letto matrimoniale da tempo dimezzato, abitato da un ingombrante vuoto. L’ho immaginato lì, tra le sue lenzuola sfatte, i suoi orinali intorno, qualche feticcio estremo di vita, come la radio, la sveglia sul comodino e le caramelle d’orzo, e un Sacro Cuore che esplode sul suo letto, un Cristo che si sporge con la testa e con la mano benedicente, e si affaccia quasi a curiosare. L’ho immaginato lì, a far l’amore con la vita, a salutare il passato con l’ultimo sorso rimasto nel presente, a far capire alla badante che lui non è vecchio da sempre; ma fu ragazzo e anche bel ragazzo, amò e fu amato. Voleva lasciar traccia di sé e cercava trasfusioni estreme di vita da una ragazza florida. Trovo commovente quell’abbraccio di una persona che reclama dell’amore non il frutto ma almeno il torsolo, per arginare la solitudine. Tenera è la notte, tenerissima per un vecchio in cerca di resistere alla notte del destino.
La solitudine come destino. È una percezione diffusa, solitamente melanconica, che accompagna la cittadinanza globale e il suo pozzo nero della misantropia, l’abisso delle relazioni sociali e il deserto di orizzonti ulteriori. Si infittisce la rete dei collegamenti e si diradano i rapporti, i mezzi per comunicare crescono mentre decresce la conversazione. L’epoca della comunicazione globale è abitata da incomunicanti; c’è più relazione umana nel villaggio che nella megalopoli, si conoscono più persone nel giro ristretto di una piccola comunità che nei grandi centri, si partecipa di più alla vita e alla morte di ciascuno. Destinati a vivere e morire in solitudine, nonostante l’agiatezza; o forse a causa di questa.
Infierisce la solitudine nell’assenza di destino. Perché non concede prospettiva al dispatrio o anche solo al sentirsi in disparte. Se la famiglia, la comunità e le tradizioni decadono al rango di convenzioni provvisorie o consorzi occasionali, non offrono più tracce o consolazioni di immortalità terrena attraverso il loro perdurare oltre la vita del singolo. Ma anche l’aspettativa della gloria, tramite l’arte, l’opera, l’impresa storica o eroica, che dava alla solitudine una proiezione di divinità nel tempo e nello spazio, si accartoccia nell’indifferenza di una società di solitudini reciproche; scivola fuori da ogni tempo e da ogni spazio, limitandosi al più alla sua sincope precaria, la celebrità. Niente resterà e nessuno ti riconoscerà niente nell’universo labile e smemorato. La solitudine non ha scampo in vita né speranza di redenzione post mortem.
Eppure esiste una solitudine come virtù, come raccoglimento d’essere e resistenza al disvenire, una solitudine come Amor fati che fonda la comunità più di ogni socialità estroversa. Non è la kantiana socievole insocievolezza, che può giovare alla competizione del mercato e può fondare la legge e il contratto sociale ma oltre non può aspirare; è una solitudine che precorre la comunità perché ne scopre le radici e il senso. Delle due solitudini, l’una optima e l’altra perniciosa, ora trattiamo.
È possibile teorizzare la comunità e praticare la solitudine? Non solo è possibile ma forse è necessario, comunque è inevitabile. Si teorizza la comunità quando viene a mancare. Così accade per l’aria, di cui ci accorgiamo solo quando ci viene a mancare. Quando è presente, una comunità non ha bisogno di costituire un quadro teorico, allestire una rete di significati e perorazioni. Basta la sua esistenza. La solitudine è il punto di partenza per cercare la comunità. Si ama la comunità e se ne coglie appieno il senso solo nel distacco e nella distanza. La comunità, o la vivi insieme o la pensi in solitudine.
Nell’epoca spaesata, la comunità esiste come residuo possente che dà sostegno alla vita reale, è presente come lutto e orfanità ma anche come aspirazione comune. La famiglia, il gruppo, la città, l’associazione, la rete, la patria, l’ecclesia, benché in crisi, sono gli unici contesti in cui si esprime la vita, senza dei quali non avrebbe senso né sostegno la persona. Si è persona in relazione all’altro, perché persona – lo dice il suo stesso etimo – esige qualcuno che ci osservi. Siamo persone rispetto a qualcuno. Persona indica un carattere, una modalità specifica di presentarsi, perfino una maschera, che ha senso solo in rapporto col mondo; altrimenti non si è persone, ma solo individui. La persona esige relazione e la vita esige legame sociale. L’io prende corpo e misura rispetto a un tu, si qualifica e si definisce rispetto a un tu, e dentro un noi. E tuttavia, l’orizzonte comunitario sembra retrocedere al passato, sfumare nelle superstiti isole dell’ideologia, fino a diventare la proiezione onirica di solitudini a disagio. La famiglia è vissuta come luogo di evacuazione e tempo di smobilitazione, le associazioni sopravvivono se diventano occasionali e laterali luoghi di socializzazione o di rappresentanza degli interessi singoli; le città e le nazioni si riducono a sfondi paesaggistici, display o location; le religioni sono ricacciate nel privato come sette recintate, separate dal vivere civile e comune.
Una vera comunità non può essere sconfinata, universale, coincidente con l’umanità, perché la comunità delimita un noi e lo distingue dal resto; ma non può essere neanche il suo rovescio, una setta, una tribù, un circuito chiuso. Se è comunità esige sia una separazione sia un’apertura, è sempre un essere-con ma a viso scoperto, a cielo aperto. La comunità ha un territorio, delinea un confine e può avere anche un suo cuore segreto, ma non ha cinte murarie entro cui barricarsi. La comunità designa un’appartenenza, ma non preclude alla differenza. Altrimenti è una fortezza che si reputa assediata, non è un luogo di primaria esperienza del mondo ma una cittadella di reclusi, ostile al mondo. Comunità è comunicare. Si può essere congrega di asceti e ordine di cavalieri, ma non si può essere comunità civica chiusa all’esterno. La comunità è delimitata ma aperta. Se non subisce assedi, non può murarsi dentro.
La comunità non esclude al suo interno la solitudine, come l’essere in società non scongiura l’isolamento. Essenziale è la distinzione tra solitudine e isolamento, come ben distinse Hannah Arendt. La solitudine può essere un’indole, un’esigenza, una scelta, una conquista, perfino una beatitudine (Beata solitudo, sola beatitudo); l’isolamento è invece una perdita del mondo e una sconfitta, un impoverimento e un’emarginazione, un’inadeguatezza, una condanna e una sofferenza. L’isolamento non è la solitudine involontaria di cui scriveva Hume, perché non è sempre né solo inflitta dalla società. È una solitudine sgraziata, a volte subita a volte interiore, cioè covata nel proprio seno, irriducibile all’emarginazione e all’ingiustizia sociale.
In una comunità è possibile la solitudine ma non l’isolamento, perché isolarsi presuppone la fuoruscita, la perdita, l’esclusione dalla comunità. In una società si può essere soli ma anche isolati; in una comunità invece si può essere soli ma non isolati, perché se si è veramente isolati si è già fuori dalla comunità. In una società è possibile distinguere una sfera pubblica e una sfera privata, anzi la società sorge su quella distinzione; una società malata non distingue, non tutela o addirittura inverte i rispettivi spazi che attengono alla vita pubblica e privata. In una comunità, invece, l’orizzonte privato tende a collimare con l’orizzonte pubblico, o quantomeno ad armonizzarsi e a riconoscere uno spazio comune in cui confluiscono e interagiscono il pubblico e il privato.
Prodotto tipico e contagioso dell’isolamento è l’insicurezza, che tende a espandersi. Le società prive di destino e di comunità pullulano di singoli isolati, sono abitate da milioni di eremiti – diceva Montale – che vivono il loro isolamento in piena folla. L’isolamento produce paura, genera domanda di sicurezza. Si tratta di domande di origine metafisica e psicologica, prima che sociale e militare, che investono il senso e l’identità, l’incertezza dell’esistenza in un orizzonte labile e l’incedere del vuoto e del nulla; ma il gigantesco, capillare sradicamento di ogni domanda in rapporto al destino costringe a dirottare le domande d’insicurezze sul controllo delle risposte e a circoscriverle nell’ambito della pubblica sicurezza. Accade allora che l’insicurezza si riduca a incolumità, la metafisica a ordine pubblico e l’incertezza della vita in rapporto al destino si trasfiguri, fingendo di assumere concretezza, in paura sociale dello straniero, del criminale, del pedofilo, in generale del disordine e dell’anomia. In un percorso inverso e paradossale rispetto alla critica alla religione degli illuministi e poi di Feuerbach, accade che si proietti in terra un bisogno di cielo, e si invochi il vigilante in luogo dell’angelo custode, si installi una ronda o una postazione di pubblica sicurezza laddove manca un’edicola sacra e protettiva; si risponda con l’ordine poliziesco a una domanda di ordine esistenziale e si prometta tutela dei singoli da ogni prossimità inquietante mentre la domanda da cui sorgeva l’insicurezza era incentrata sul bisogno di comunità. Non è l’estraneo che spaventa, ma è il venir meno di quel che è nostrano a disorientare.
Le comunità soffrono meno di queste paure rispetto alle società spaesate perché sono rassicuranti, familiari e calde; l’insicurezza si accompagna all’isolamento. L’assenza degli dei, del fato e della comunità viene compensata con il raddoppio della vigilanza. La perdita d’identità è risarcita con l’aumento dei controlli.
L’estensione della società al pianeta, lo sconfinamento del locale nel mondiale e la rete globale di relazioni telematiche rendono sempre più evanescente l’appartenenza stessa a una società. Più la società si estende e più perde ogni traccia di contorno, fino a realizzare l’idea popperiana che la società sia solo un’astrazione platonica e che esistano soltanto gli individui con le loro dirette e occasionali relazioni. Se la società è un concetto astratto, il mondo non è fondato sui legami ma è regolato da leggi e contratti, le consonanze si fanno solo sincronie, perché sono fondate soltanto sul temporaneo convergere di interessi e apprensioni; le relazioni non prevedono comunanza ma tecnologia. È la tecnica a rapportarci al mondo; le comunanze al più consentono di stabilire rapporti sentimentali nell’ambito dell’affettività privata.
page_no="204" A uno sguardo più attento, potrebbe perfino modificarsi la considerazione da cui siamo partiti circa il tramonto della comunità; a tramontare sembra essere piuttosto la società che cede il passo a una frammentazione di meteoriti individuali o tribù microsociali e di solitudini globali, mentre la comunità resiste almeno in tre ambiti: come nostalgia del passato, come prospettiva del futuro e come sentimento intenso nel presente. La comunità abita in interiore homine, come vuoto e come attesa, ma anche come percezione di legami elettivi e naturali che sentiamo come fondativi della nostra vita e del suo senso. Per questo, la comunità oggi acquista vigore proprio nella solitudine, come invocazione, memoria e pre-sentimento. Viceversa diventano pericolose, quanto artificiose, le pseudocomunità che sorgono dall’isolamento perché sono agglomerati ringhiosi di risentimenti ed emarginazioni che armano le frustrazioni fino a renderle militanti. Tanto sono aggressive le pseudocomunità di clan, di club o di quartiere quanto sono fittizie e interiormente vuote. Possono attenere tanto a un villaggio quanto a un branco o a un collettivo. Reti effimere, occasionali, hobbystiche, orgiastiche, emozionali, virali… La comunità sorge da un’esigenza naturale che si costituisce in orizzonte culturale. Entrambi la radicano nel tempo e nello spazio. Il nesso tra natura e cultura è l’orlo del destino.
Intimista. Autistico. Solipsista. Sono i tratti salienti del pensiero che cede al narcisismo della mente. Il pensiero è spinto alla solitudine, perché la sfera pubblica, ideale, civile e perfino funzionale si è ritirata. Cresce nel pensiero la propensione intimista e solipsista. Ogni autore tende a scoprirsi autistico, perde il mondo e ripiega su sé, narra di sé e interrompe il dialogo. Ma chiudendosi in sé, istiga anche il suo lettore e interlocutore a fare altrettanto, a chiudersi in sé, a farsi idiota e dunque a rinunciare alla stessa lettura e interlocuzione. Perché seguire la parabola di un altro io che si espone? Seguo direttamente il mio io, per mio conto. La solitudine dell’autore è ricambiata dalla solitudine del lettore, nel reciproco ripiegare in se stesso. La soggettività raggiunge il suo punto estremo di rottura: la letteratura, il dialogo e il pensiero rischiano di morire di autoreferenzialità.
Certo, è impossibile pensare senza gli altri, ogni pensiero è un noi, un dia...