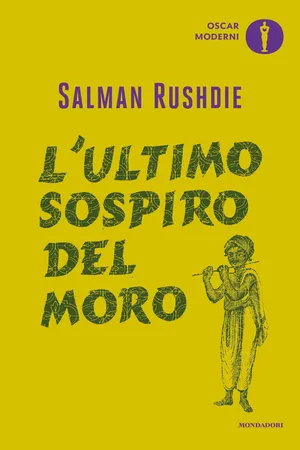
- 490 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'ultimo sospiro del Moro
Informazioni su questo libro
Il Moro è l'unico erede maschio della ricchissima dinastia dei Gama-Zogoiby. Una casata che in India ha, da sempre, il monopolio del commercio delle spezie. E, da sempre, è segnata dal carattere forte delle sue donne. Il Moro lo sa fin troppo bene, lo ha sperimentato da quando Aurora, sua madre, l'ha costretto all'esilio. Aurora che, nei suoi imperscrutabili furori, svela attraverso magici dipinti i segreti della sua famiglia e del suo tempo, di un mondo che sta per sparire. Il racconto del Moro è quasi un testamento. È l'ultimo inno a una famiglia che non sa amare i suoi figli senza distruggerli, e a un paese che non sa amare il suo popolo senza soffocarlo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a L'ultimo sospiro del Moro di Salman Rushdie, Vincenzo Mantovani in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Letteratura generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
LetteraturaCategoria
Letteratura generaleII
MASALA DEL MALABAR
9
Una volta all’anno a mia madre Aurora Zogoiby piaceva, ballando, saltare più in alto degli dei. Una volta l’anno gli dei venivano a Chowpatty Beach a fare il bagno in quel mare sporco: idoli panciuti a migliaia, effigi in cartapesta della divinità con la testa di elefante Ganesha o Ganpati Bappa, che sciamavano verso l’acqua a cavalcioni di topi di cartapesta: perché i topi indiani, com’è noto, portano non soltanto pestilenze, ma anche gli dei. Alcune di queste coppie munite di zanne e di coda erano abbastanza piccole per poter essere portate da un uomo in braccio o sulle spalle; altre erano grandi come case, e venivano trasportate su carri di legno dalle grandi ruote trainati da centinaia di discepoli. C’erano, poi, molti Ganesha Danzanti, ed era con questi Ganpati dalle anche sussultanti, con rotoli di grasso sui fianchi e il ventre tondeggiante, che Aurora gareggiava, ponendo le proprie profane piroette a confronto con l’allegro balletto del dio pluririprodotto. Una volta all’anno i cieli erano pieni di nuvole in technicolor: rosee e violette, cremisi e vermiglie, verdi e giallo zafferano, queste nuvole di polvere, sprizzate da schizzetti per insetticidi riadattati o plananti sulla terra da qualche grappolo di palloni scoppiati mentre volavano in mezzo al cielo, rimanevano sospese in aria sopra le divinità “come un’aurora non boreale ma bombayale”, per usare le parole del pittore Vasco Miranda. Altissima anche lei sopra le folle e gli dei, un anno dopo l’altro – per quarantun anni in tutto – impavida sui ripidi bastioni del nostro bungalow di Malabar Hill, che in uno spirito di ironica monelleria o malvagità aveva insistito per chiamare Elephanta, volteggiava la figura quasi divina della nostra personale Aurora Bombayale, strizzata in una serie di mise dai colori abbacinanti costellati di specchietti, battendo in eleganza anche il cielo festivo e i suoi giardini pensili di polveri colorate. Con i bianchi capelli svolazzanti intorno a lei in lunghe e sciolte esclamazioni (O profetici capelli prematuramente bianchi dei miei avi!), col ventre in mostra, non grasso come quello di un vecchio pipistrello ma piatto come quello di un gatto in piena forma, con i piedi nudi che pestavano il suolo, con le caviglie che tintinnavano di argentei cerchi di campanellini jhunjhunna, piegando il collo a destra e a manca, facendo incomprensibili discorsi con le mani, la grande pittrice danzava la sua sfida, danzava il suo disprezzo per la malvagità del genere umano, che spingeva queste folle immense a rischiare di morire schiacciate “solo per buttare in mare i loro bambolotti”, come amava con aria incredula, e alzando ripetutamente gli occhi al cielo, e torcendo beffardamente la bocca, dileggiare.
«La malvagità umana è più grande dell’eroismo» – dlin-dlen! – «o della codardia» – tu-tu-tum! – «o dell’arte» declamava, danzando, mia madre. «Perché queste cose hanno limiti, perché ci sono punti oltre i quali in loro nome non andremmo; mentre non c’è limite alla malvagità, non c’è frontiera che qualcuno abbia scoperto. Qualunque sia l’eccesso di oggi, domani sarà peggio.»
Come per dimostrare la propria fede nel potere polimorfo del malvagio, la danzante Aurora diventò, col passare degli anni, una delle attrazioni principali dell’evento che disprezzava, una parte di ciò contro cui aveva danzato. Le folle dei devoti – erroneamente ma incorreggibilmente – videro la propria devozione specchiarsi nelle sue gonne vorticanti (e infedeli); e ne trassero la conclusione che anche lei rendeva omaggio al dio. Ganpati Bappa morya, cantavano, ballando, tra lo strepito delle trombe da quattro soldi e delle conchiglie gigantesche e i colpi di maglio dei tamburini inebetiti dalla droga con gli occhi stralunati e la bocca piena delle grate banconote dei fedeli, e più sdegnosamente la dama leggendaria danzava sul suo alto parapetto, più al di sopra di tutto questo le pareva di essere, più avidamente le folle la risucchiavano giù verso di loro, vedendola non come una ribelle ma come la danzatrice di un tempio: non il flagello ma, piuttosto, la tifosa degli dei.
(Abramo Zogoiby, come vedremo, faceva un uso diverso di queste danzatrici.)
Una volta, durante una lite in famiglia, le ricordai rabbiosamente i molti articoli di giornale che l’assimilavano alla festa. A quell’epoca Ganesha Chaturthi era diventata, per bande di giovani teppisti con una benda color zafferano sulla fronte che stringevano i pugni e li agitavano sotto il naso della gente, l’occasione per dare una dimostrazione di trionfalismo fondamentalista indù, aizzato dagli urlanti attivisti del partito “Asse di Mumbai” e da demagoghi come Raman Fielding, alias Mainduck (“Rana”). «Ormai non sei più solo uno spettacolo turistico» la schernii. «Sei un manifesto del Programma di Abbellimento.» Il piano dell’AM, con quel nome così attraente, prevedeva, per dirla nel modo più semplice, la rimozione dei poveri dalle strade cittadine; ma la corazza di Aurora Zogoiby era troppo robusta per lasciarsi perforare da una botta così maldestra.
«Credi forse che possano schiacciarmi le pressioni della stampa prezzolata?» gridò, con un’alzata di spalle. «Credi che io possa essere sporcata dalla tua lingua nera? Che m’importa delle scempiaggini di quell’allocca di Mumbai! Io sono alle prese con un grande avversario: Shiva Nataraja in persona, sì, e con quel ciccione nasuto del suo figlio ballerino: per anni, a furia di ballare, li ho costretti a fuggire tra le quinte. Bada, muso nero. Forse un giorno anche tu imparerai a suscitare una tromba d’aria, a scatenare un uragano: sì! A provocare una tempesta, a furia di ballare.» Il tuono, proprio al momento giusto, rombò sopra la nostra testa. Presto una pioggia scrosciante avrebbe cominciato a cadere dal cielo.
Quarantun anni di danze alla festa di Ganpati: danzava senza darsi il minimo pensiero per il rischio che correva, senza degnare di un’occhiata quegli scogli pazienti e incrostati di cirripedi che là sotto di lei digrignavano i denti neri. La primissima volta che emerse da Elephanta in pompa magna e diede inizio alle sue piroette sull’orlo dell’abisso, Jawaharlal Nehru in persona la pregò di desistere. Questo accadde non molto tempo dopo che lo sciopero antibritannico della marina nel porto di Bombay, e la chiusura dei negozi cittadini, l’hartal, attuato in segno di solidarietà, erano cessati su richiesta di Gandhiji e Vallabhbhai Patel, e anche allora Aurora non mancò di scagliare la sua frecciatina. «Panditji, il Congresso china sempre la testa davanti ai gesti radicali. Non si faranno scelte morbide, da queste parti.» E quando lui continuò a supplicarla, lei gli propose di pagare un pegno, dicendo che sarebbe scesa solo se Nehru avesse recitato a memoria tutto Il tricheco e il carpentiere; cosa che lui fece, tra l’ammirazione generale. Mentre l’aiutava a scendere dalla sua vertiginosa balaustra, Nehru disse: «Lo sciopero è stato una faccenda complicata».
«Lo so già cosa penso dello sciopero» ribattè lei. «Parlami della poesia.» Al che Nehru diventò paonazzo e deglutì.
«È una poesia triste» disse dopo un attimo, «perché le ostriche sono così giovani; una poesia, si potrebbe dire, sul fatto che si mangiano i bambini.»
«Tutti noi mangiamo i bambini» replicò mia madre. Questo accadeva dieci anni prima che io nascessi. «Se non quelli degli altri, i nostri.»
Ebbe quattro figli. Ina, Minnie, Mynah, il Moro; un pasto di quattro portate con magiche proprietà perché, per quanto mangiasse, spesso e di buon appetito, il cibo sembrava non mancare mai.
Per quarant’anni mangiò fino a scoppiare. Poi, danzando la danza di Ganpati per la quarantaduesima volta all’età di sessantatré anni, cadde. Un’onda magra che pareva di saliva coprì il suo corpo, mentre le nere fauci si mettevano al lavoro. Ma in quel momento, anche se lei era ancora mia madre, io non ero più suo figlio.
Sul cancello di Elephanta stava un uomo con una gamba di legno, appoggiato a una stampella. Se chiudo gli occhi, è ancora facile evocarlo: quel semplice Pietro sulla soglia di un paradiso terrestre, che diventò il mio personale Virgilio a prezzo ridotto, portandomi giù all’inferno; nella grande città infernale, Pandemonio, la gemella cattiva, dal lato buio che c’è dentro lo specchio, della mia città d’oro: non la Decente, ma l’Indecente Bombay. Adorato guardiano monopede! I genitori, con la loro abitudine di storpiare i nomi, lo chiamavano Lambajan Chandiwala. (Pare che Aires avesse attaccato loro la sua mania di dare nomignoli al mondo.) A quei tempi le persone che avrebbero capito il gioco di parole erano molte di più: lamba, long (lungo); jan, che suona come John; chandi, silver (argento). Long John Silverfellow, terribilmente irsuto ma letteralmente e metaforicamente sdentato come il giorno in cui era venuto al mondo, che macinava paan tra le gengive rosse di betel o di sangue. «Il nostro pirata privato» lo chiamava Aurora; e sì, la definizione era azzeccata, perché di solito, appollaiato sulla spalla, aveva un Totah verde con le ali tagliate che strillava oscenità. Era stata mia madre, perfezionista in tutte le cose, a trovargli quell’uccello; nulla di meno l’avrebbe accontentata.
«Che senso ha un pirata se manca il pappagallo?» chiedeva, aggrottando le sopracciglia e girando la mano destra come se stringesse l’invisibile maniglia di una porta; per poi soggiungere spensieratamente, e scandalosamente (perché non stava bene scherzare sul Mahatma): «Tanto varrebbe aver preso quell’ometto senza perizoma». Ce la mise tutta per insegnare al pappagallo a parlare come un pirata, ma era un vecchio e cocciuto uccello di Bombay. «Pezzi da otto! Miei prodi!» gridava mia madre, ma il suo allievo manteneva un silenzio da ammutinato. Tuttavia, dopo anni di questa persecuzione, Totah cedette e sbottò, irritatissimo, in un «Peesay… saféd… hathi!» Questa singolare dichiarazione, che si sarebbe potuta tradurre all’incirca con purè di elefanti bianchi, diventò l’invettiva preferita del nostro lessico familiare. Io non ero presente in occasione dell’ultima danza di Aurora Zogoiby, ma molti in seguito testimoniarono che la splendida imprecazione del pappagallo la seguì, diminuendo, mentre precipitava verso il suo tragico destino: «Ohhh… Purè di elefanti bianchi» urlò mia madre prima di schiantarsi sugli scogli. Accanto al suo corpo, portata verso di lei dalla marea, c’era l’effigie fracassata di un Ganesha Danzante. Ma non era affatto questo che aveva inteso dire.
La frase di Totah ebbe un profondo effetto anche su Lambajan Chandiwala, che era – come tanti di noi – un uomo con gli elefanti nel cervello; dopo che il pappagallo ebbe detto la sua, Lamba riconobbe di avere sulla spalla un’anima gemella, e da allora aprì il suo cuore a quell’uccello, intermittentemente oracolare, ma più spesso taciturno e (se vogliamo proprio dire la verità) irascibile e maledettamente brutto.
Quali isole del tesoro sognava il nostro pirata con pappagallo? Soprattutto e il più delle volte parlava della vera Elephanta. Per i piccoli Zogoiby, la cui educazione non prevedeva la possibilità di avere delle visioni, l’isola di Elephanta era nulla, un pezzo di terra collinosa nel porto. Prima dell’indipendenza – prima di Ina, Minnie e Mynah – la gente poteva andarci solo se disponeva di una barca ed era pronta ad affrontare serpenti e compagnia; quando arrivai io, però, l’isola era stata addomesticata da un pezzo, e c’erano regolari escursioni in motolancia dalla Porta dell’India. Le mie tre sorelle maggiori si annoiavano, in quel posto. Così, per il bambino che ero, accovacciato accanto a Lambajan nell’afa pomeridiana, Elephanta era tutt’altro che un’isola fantastica; ma per Lambajan, a sentirglielo dire, era la terra stessa del latte e del miele.
«Una volta in quel posto c’erano dei re elefanti, baba» mi confidava. «Perché credi che il dio Ganesha sia tanto popolare nella città di Bombay? È perché ai tempi prima degli uomini erano gli elefanti a sedere sui troni e a discutere di filosofia, ed erano le scimmie che gli facevano da servitori. Si dice che quando gli uomini arrivarono per la prima volta sull’isola di Elephanta nei giorni successivi alla caduta degli elefanti trovarono delle statue di mammut più alte del Qutb Minar di Delhi, ed ebbero tanta paura che spaccarono tutto. Sì, gli uomini hanno cancellato il ricordo dei grandi elefanti, ma non tutti noi abbiamo ancora dimenticato. Là sui monti di Elephanta c’è il posto dove seppellivano i loro morti. No? Scuoti la testa? Vedi, Totah? Non ci crede. Okay, baba. Corrughi la fronte? Allora guarda questo!»
E qui, con molto strepito pappagallesco, tirò fuori – che altro, che altro, o cuore mio nostalgico? – una pallottola di carta dozzinale di cui persino il Moro bambino avrebbe potuto contestare l’antichità. Si trattava, naturalmente, di una mappa.
«Un grande elefante, forse il Grande Elefante, si nasconde ancora lassù, baba. Io ho visto quello che ho visto! Chi altro credi che mi abbia staccato la gamba con un morso? E poi, nella sua magnanimità e nel suo disprezzo, mi lasciò strisciare sanguinando nella giungla giù per la collina e salire sulla mia barchetta. Cos’ho visto! Cos’ho visto! Le gemme alle quali fa la guardia, baba, un tesoro più grande del khazana del Nizam di Hyderabad in persona.»
Lambajan si era adattato alla piratesca fantasia che avevamo costruito su di lui – perché naturalmente mia madre la grande chiarificatrice si era accertata che capisse il suo nomignolo – e così facendo aveva edificato un sogno tutto suo, un’Elephanta per Elephanta, in cui, col passare degli anni, sembrava credere sempre più profondamente. Senza saperlo, si ricollegava alle leggende dei da Gama-Zogoiby, nelle quali i tesori nascosti erano un elemento di rilievo. E così il masala della costa del Malabar trovò la sua ancor più favolosa controparte su Malabar Hill, come forse era inevitabile, perché, quali che avessero potuto essere, o fossero stati gli avvenimenti relativi al pepe e alle spezie di Cochin, questa nostra grande cosmopoli era ed è il grande crocevia di tutto questo tamasha, e le storie più scottanti, le più succose e maligne, i romanzacci non da due soldi ma da due paisa più spettacolosi e pittoreschi, sono quelli che battono le nostre strade. A Bombay vivi schiacciato da questa folla straripante, sei assordato dalle sue tonanti cornucopie, e – come le figure dei parenti nell’affresco di Aurora sull’isola di Cabral – la tua storia deve farsi largo nella ressa. Il che andava benissimo, per Aurora Zogoiby; non avendo mai amato la tranquillità, aspirava a pieni polmoni i caldi miasmi della città, ne leccava avidamente le salse piccanti, ne divorava i piatti in un boccone. Aurora arrivò a considerarsi una specie di corsaro, la regina dei fuorilegge della città. «In questa casa è la bandiera dei pirati che facciamo sventolare» dichiarò ripetutamente, tra l’imbarazzo e il fastidio dei suoi figli. Ne fece veramente fare una dal suo sarto e la consegnò al chowkidar. «Su, presto, signor Lambajan! La issi sul pennone e vediamo chi la saluta.»
Quanto a me, non salutai il teschio e le tibie incrociate di Aurora; non ero affatto, a quei tempi, il tipo del pirata. Inoltre, sapevo come Lambajan aveva perso veramente la sua gamba.
Il primo punto da notare è che a quei tempi gli arti delle persone si staccavano più facilmente. Le bandiere della dominazione inglese ondeggiavano sopra il paese come strisce di carta moschicida e, nel tentativo di scollarci da quei vessilli fatali, noi mosche – se posso usare il “noi” per riferirmi a un’epoca precedente la mia nascita – spesso ci lasciavamo dietro gambe o ali, preferendo la libertà alla completezza. Naturalmente, ora che quella carta appiccicosa è storia antica, troviamo la maniera di perdere le nostre membra nella lotta contro altre insegne di nostra invenzione, altrettanto letali, altrettanto antiquate, altrettanto adesive. Basta, basta; piantala lì! Stacca questo altoparlante e fermati, dito mio che ti agiti in segno di rimprovero! Per continuare: la seconda notizia essenziale a proposito della gamba di Lambajan riguarda le tendine di mia madre; il fatto, volevo dire, che c’erano delle tende verdi e oro, tenute sempre chiuse, sul lunotto e sui finestrini posteriori della sua automobile americana…
Nel febbraio 1946, quando Bombay, quel superepico film di una città, fu trasformata dalla sera alla mattina in un immobile tableau dai grandi scioperi di terra e di mare – quando le navi non salpavano, l’acciaio non veniva lavorato, i telai delle industrie tessili non ordivano né tramavano e negli studi cinematografici non si girava né si montava nulla – la ventunenne Aurora prese a sfrecciare qua e là per la città paralizzata nella sua famosa Buick con le tendine, ordinando all’autista Hanuman di raggiungere il cuore dell’azione, o meglio di tutta quella grande inazione, facendosi scaricare davanti agli ingressi di fabbriche e arsenali, avventurandosi sola soletta negli slum di Dharavi, nelle bettole di Dhobi Talao e negli sfavillanti locali notturni di Falkland Road, armata solo di uno sgabello pieghevole di legno e di un album per gli schizzi. Aprendoli entrambi, si accingeva a catturare la storia col carboncino. «Fate finta che io non ci sia» intimava agli scioperanti a bocca aperta intanto che schizzava a tutta velocità mentre picchettavano, bevevano e andavano a puttane. «Sono qui proprio così; come una lucertola sul muro; o dite pure che sono una larva di formicaleone.»14
«Matta» diceva Abramo Zogoiby, mostrando la propria meraviglia ancora molti anni dopo. «Tua madre, ragazzo mio. Matta come una scimmia su un’araucaria. Solo Dio sa cos’aveva in testa. Anche a Bombay non è cosa da poco per le signore non accompagnate sedersi nella pubblica via e guardare gli uomini in faccia, entrare nelle bische dei quartieri malfamati e tirar fuori un album da ritratti. E la larva di formicaleone, ricordi? Era una bomba.»
Non era una cosa da poco. Atticciati stivatori con i denti d’oro l’accusavano di volergli rubar l’anima strappandogliela letteralmente dal corpo, e bellissimi uomini d’acciaio sospettavano che, sotto un’altra identità segreta, potesse essere un’informatrice della polizia. La pura e semplice stranezza dell’attività artistica la rendeva una figura discutibile; come accade dappertutto; com’è sempre accaduto e forse sempre accadrà. Tutti questi ostacoli Aurora sormontò, questi e altri: alle spinte, alla minaccia sessuale, alle intimidazioni fisiche guardò sempre dall’alto della sua aria sicura e irremovibile. Mia madre, mentre svolgeva il suo lavoro, ha sempre posseduto l’occulto potere di rendersi invisibile. Con i lunghi capelli bianchi raccolti in uno chignon, in un dozzinale vestito a fiorami comprato al Crawford Market, tutti i giorni tornava, serena e indomabile, alle scene preferite, e a poco a poco la magia cominciava a funzionare, la gente smetteva di notarla; dimenticavano che era una gran dama scesa da una macchina grande come una casa che aveva addirittura le tende ai finestrini, e lasciavano che la verità della loro vita tornasse sul loro viso; ed era per questo che il carboncino stretto tra le dita frettolose era capace di catturarne tanta, gli scambi di sberle dei bambini nudi davanti alla fontanella di una casa popolare, la grigia disperazione degli operai in ozio che fumavano bidi sui gradini delle farmacie chiuse, le fabbriche mute, la sensazione che il sangue salito agli occhi degli uomini stesse per sgorgarne e inondare le strade, la durezza delle donne col sari tirato sopra la testa, accovacciate davanti a fornelletti nelle capanne di stracci degli abitanti dei marciapiedi mentre cercavano di ricavare un pasto dall’aria che respiravano, il panico negli occhi dei poliziotti che caricavano a colpi di lathi ma che temevano che un giorno, presto, quando fosse arrivata la libertà, sarebbero stati visti come i difensori dell’oppressione, la tensione esaltata dei marinai in sciopero sui cancelli dei cantieri navali, la fierezza da bambini colti in fallo sui loro volti ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- I. UNA CASA DIVISA
- II. MASALA DEL MALABAR
- III. BOMBAY CENTRAL
- IV. “L’ULTIMO SOSPIRO DEL MORO”
- Copyright