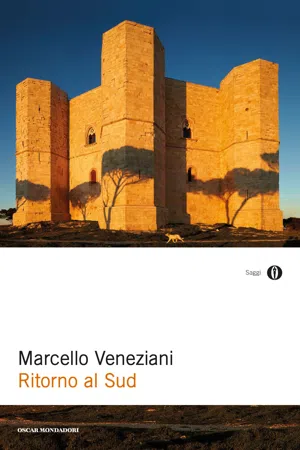![]()
![]()
Ogni tanto la preistoria personale viene a trovarci. Tu ricordi vagamente il soggiorno di casa tua da bambino, tuo padre accanto a un gran bestione di radio, tu e i tuoi fratelli raccolti a sentire le partite di calcio, «Se la squadra del vostro cuore ha perso consolatevi con Stock 84». Ricordi lo stupore del quadrante acceso, gremito di nomi esotici, la sorpresa di quelle linee luminose che si spostavano con la manopola e le voci promiscue che cambiavano rapidamente, dall’inglese al russo all’arabo. Il Lontano entrava in casa. Poi, la domenica radiosa, le canzoni riempivano la casa insieme all’odore di ragù.
Pensi che sia un mondo sepolto o solo sognato, tanto pallido e stinto è il ricordo. Ma poi un pomeriggio di questi, alla controra, ti arrampichi sulla soffitta della casa paterna e ritrovi lacerti del passato che giacciono inerti ma alludono a una preistoria favolosa e affettiva. Al tempo dell’infanzia parlavano le cose, cantavano gli oggetti, tutto era vivente. Ritrovi con gli scampoli della preistoria domestica quelle stanze, quelle voci, quei volti, quelle abitudini di casa. Riemerge da quell’Atlantide familiare la carcassa di un prezioso animale domestico, la radiona Clariton in radica di noce col suo quadrante verde gremito di località favolose, che irradiava il soggiorno. Con qualche espediente si rianima, dà segnali di vita, emette rumori, suoni… L’incanto di quel tempo si risveglia. Vorresti riascoltare le parole e le voci di quel tempo e rivedere al suo fianco quella poltrona occupata. Ma poi ti accontenti d’aver ritrovato la macchina del tempo e t’ipnotizza il suo fervore di luci. Non sai come festeggiare la sua ricomparsa ma, mentre ci pensi, ti accorgi che lo stai già facendo. Si riaccendono i ricordi, va in onda il passato.
Mi elettrizzava da bambino l’avvento del buio per un improvviso collasso della luce artificiale. Mi piaceva il ritorno primordiale della notte e la restituzione delle cose al mistero delle origini, finalmente sottratte alla banalità dell’evidenza; mi intrigava la magia delle stanze oscure, la riconquista delle ombre, il ridursi delle presenze domestiche a sagome, il caricarsi denso delle parole separate dalle immagini, la percezione acuta dei rumori e dei fruscii, il disporsi delle candele, il raccogliersi intorno a poche, intense fonti di luce tremolante che disegnavano i volti e gli sguardi di una segreta animazione, sconosciuta alla luce profana. La vita indaffarata si fermava, assaporavi il piacere misterioso dell’invisibile. Entravi in gruppo nel regno buio dell’interiorità, una gita di anime, denudate dai loro corpi ma non dai loro respiri. Il gergo della vita bisbigliava nell’oscurità. Soprattutto era bella l’euforia dell’attesa. La luce tornerà, così i grandi rassicuravano i bambini, e se non tornerà quella elettrica verrà poi quella del giorno. Coricarsi con quella promessa nutriva la notte d’incanto. La bellezza del mondo si prendeva il suo congedo, ritirandosi agli sguardi e facendosi più preziosa nell’assenza e nel presagio del suo trionfale rientro. Nel ricordo della luce che si faceva promessa di tornare, trovavo l’essenza profumata della vita, il senso del mondo e del divino, la morte e la rinascita. Vedrai, la luce tornerà.
Giugno in terrazza. Nuotavo tra le fila di lenzuola bianche distese ad asciugare, in canottiera, mutandine, sandali blu con occhi a mandorla aperti sulle dita dei piedi; il battipanni per chitarra. E una voce femminile senza volto, ora materna, ora bambina, vanamente inseguita nel biancore della luce e dei panni. Labili indizi alcune dita spuntate dai panni e presto sparite. L’azzurro confinava col blu. Aspettativa felice di vita, poi andremo a mare…
In principio fu l’Asino. Incontrare un asino per strada non è più cosa di tutti i giorni. Al tempo della mia infanzia ce n’erano tanti, ora sono rarità. Animale primordiale, l’umile cavallo per la classe economica va sparendo, per crisi demografica, perché manovalanza tecnologicamente arretrata e assai grezza nelle rifiniture, perché ambasciatore molesto dell’antichità, della miseria e del passato più scomodo. Da noi, quando a scuola non sapevamo rispondere, ci dicevano: siete come gli asinelli di Martina Franca. Adesso provate a cercare un asino a Martina Franca. Se ci sarà, vivrà sotto falso nome e mentite spoglie, sarà un trans o avrà conquistato fattezze umane. Il ciuccio, nome più affabilmente terrone di asino, non è scomparso per vertigine di possibilità, come il mitico asino di Buridano, incerto tra il bere o il mangiare, ma perché è tagliato fuori dai percorsi della modernità, è andato fuori corso, come la lira. Perciò trovarne uno è un piacere da collezionista, provi la commozione di vedere un vecchio amico o parente che avevi dato per estinto.
L’ultimo con cui ebbi una storia lacerante fu in Grecia e stava per concludersi in tragedia o in zuffa. Fu a Santorini, isola bianca dell’azzurra famiglia delle Cicladi. Per salire dal porto al borgo non c’era che un mezzo di locomozione, l’asino. Asini greci, per giunta: più antichi e più mitici degli altri, forse più astuti nella loro ottusità, e levantini. Così montai sull’asino, non senza qualche iniziale riluttanza che non dovette sfuggire al somaro. Faceva un caldo bestia e il povero animale non se la sentiva di salire ancora una volta lungo il tortuoso cammino. Allora decise di farmela pagare. Faceva le curve larghe, strisciando il parapetto. Quando c’era il precipizio le faceva radendo il burrone, con la chiara istigazione a suicidarmi o a farmi prendere dal panico. Quando il tornante volgeva nella pancia del monte, l’asino radeva il muro per farmi strusciare la gamba alla roccia e farmi raschiare dalle pietre ruvide. A nulla valevano i tentativi di raddrizzarlo con le briglie e con le esortazioni, le mazzate e i sussurri. Mi distrusse un pantalone grigio-asino e mi lacerò una gamba. Alla fine, quando smontai da lui, emise un raglio di felicità liberatoria, a cui feci eco anch’io, adeguandomi al suo idioma. Lui si vendicava così del ruolo di sottoposto, ingaggiava la sua lotta di classe bestiale e faceva pagare agli altri, odiati turisti, fruitori passeggeri di una sudata beatitudine, la soma della sua esistenza in salita, della sua irriconosciuta fatica al sole di milite ignaro del piacere. La sua gioia era solo l’assenza momentanea di sofferenza. Non chiedeva piacere, solo stasi. Gli asini, di notte, sognano altre notti.
Gli asini sono cavalli che non si sono montati la testa. Evocano dei, eros e natura. Ricordano Poppea che faceva il bagno nel latte d’asina e Gina Lollobrigida popputa sull’asinello in Pane amore e fantasia. Ricordano Zarathustra di Nietzsche, Pinocchio di Collodi e L’asino d’oro di Apuleio, ma anche l’arrivo di Gesù nel giorno delle Palme. Ricordano i cafoni della terra mia, di cui gli asini erano fratelli muti ma consorti. Gli asini portavano sul dorso i doni della terra. Ricordano le strade sterrate fuori dal mondo, gli alberi a cui si attaccavano per interminabile tempo, i silenzi della campagna divorata dal sole, appena scossi dal fluire del vento. Ricordano masserizie debordanti per mangiare, per bere, per scaldarsi. Rammentano i proverbi antichi, le puerili ironie sulla stupidità umana di cui furono la principale metafora vivente, ricorrono persino nei motti del colto Federico II che bollava a Sud intere città con le orecchie di ciuco (Gens bitontina tota asinina).
Gli asini ricordano il sesso in campagna, dove chi s’imboscava era «arrapato a ciuccio», come si diceva alludendo alle doti sessuali del medesimo, da esercitare all’aria aperta, come da prototipo. Ricordano gli dei, perché gli asini sono figure mitologiche, a cui la scomparsa dall’abitato ha donato la grazia ulteriore dell’invisibilità; portatori sani e ignari di una sapienza misteriosa che traspare dal loro sguardo ebete ma lungimirante. L’umiltà dell’asino è una virtù cristiana, e il suo fiato nella mangiatoia fu il primo climatizzatore della storia, servì da termosifone a Gesù Bambino e alla sua famiglia. L’asino fu il primo strumento tecnologico dell’umanità; oltre che da impianto di riscaldamento l’asino funzionava da carrello per la spesa, da portabagagli, da utilitaria per gli spostamenti, accessibile anche alle donne; era la scuola guida dei ragazzi prima di passare al cavallo, una specie di veicolo senza targa, di bassa cilindrata, di rozza carrozzeria, rispetto alla berlina equina che richiedeva una patente esperienza di strada. È stato l’animale più utile e più maltrattato dell’uomo, più prezioso e più vilipeso, insieme al maiale. Ridicolizzato sul piano non solo estetico ma anche etico e intellettuale. Confesso come una colpa edipica l’aver mangiato, in una masseria del Sud, brasciole d’asino, che poi sarebbero involtini per il resto d’Italia. Mi pareva di sbranare l’asino della mia infanzia, scempio di cadavere e cannibalismo. Una volta c’era il calcio dell’asino al leone morente, oggi c’è il morso dell’uomo all’asino morto.
L’asino incarnava soprattutto la pazienza cocciuta e la fedele sottomissione alla natura, alle sue leggi, ai suoi cicli. Quanta santa modestia in quelle orecchie lunghe e basse. Auribus demissis, dicevano i latini e il mio docente di lettere, professor Immediato. Forse per questo l’asino è scomparso. Perché rappresentava la tradizione allo stato più elementare, la realtà più dura, più tenera e più antica. Un animale conservatore, premoderno. Uno che non si aggiorna, notoriamente refrattario allo studio e alla flessibilità; che è out, che è reso superfluo e obsoleto, privo di marmitta catalitica e incline a fare i suoi bisogni strada facendo. Gli asini sono scomparsi dalla circolazione perché sono andati ad abitare in cielo. Ai bambini, quando andava una bevanda di traverso, le mamme dicevano per far sollevare loro la testa: vedi l’asino che vola? Volevano stupire con gli effetti speciali, e così salvare la creatura dal soffocamento, ma in fondo era vero. Per non soffocare, bisogna davvero alzare lo sguardo e pensare l’evento eccezionale. Gli asini volano davvero, quando non li vede nessuno. Avevano conoscenze altolocate per via del presepe e, ora che sono spariti dalla terra, se ne sono andati in cielo. Perché di loro che hanno patito in silenzio e servito in umiltà, sarà il Regno dei Cieli.
Perciò quando ho visto un asino per strada, in Sardegna, l’ho abbracciato. Come Nietzsche abbracciò un cavallo a Torino prima di diventare pazzo. Ognuno abbraccia secondo il suo rango. Ma l’asino è animale proustiano, perché consente di partire sul suo accessibile dorso alla ricerca del tempo perduto. Pur non essendo dotato di retromarcia, l’asino consente il viaggio a ritroso, nelle nostre origini mediterranee, ancestrali, dove riposa l’immenso granaio dell’infanzia. L’infanzia di una persona, di una generazione, del mondo. L’esercizio del ricordo, a bordo dell’asino, consente di frequentare l’unico aldilà davvero accessibile all’uomo, perché conosciuto: il mondo che fu, che c’era una volta. I paradisi perduti hanno l’odore dell’infanzia.
A volte mi manca l’odore di sansa e d’olive frante che avvolge il mio paese ed entra nelle narici come un nutriente fiato materno. Mi mancano gli odori del mare, quando il mare è più vero e severo, disabitato di gente, d’inverno. Mi mancano gli odori di salsa, misti all’odore di bucato della chianca insaponata, che le vecchie case seminavano tra le strade come viatici della domenica. Le belle cose che scriveremo, se avremo talento, diceva Proust, sono dentro di noi, indistinte, come il ricordo di un’aria che ci delizia senza che riusciamo a ritrovarne i contorni.
Noi siamo i fortunati abitanti di due mondi. Dico noi che siamo cresciuti nel millennio scorso e maturi approdammo al terzo millennio. Abbiamo infatti vissuto il raro privilegio di vivere un’infanzia antica, legata quasi alla preistoria del mondo, e poi la maturità postmoderna. È dolce perciò aprire quel prezioso scrigno di memorie che ci portiamo appresso dai millenni andati. Ricordare insieme è un esercizio salutare. Possiamo dire di appartenere a una generazione nata nella preistoria e cresciuta nella poststoria. La storia, forse, ce la siamo persa. Solo i colpi di coda, per restare all’asino. A cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, molti di noi – come primitivi – hanno vissuto un’infanzia senza la tv, senza l’automobile, senza frigorifero, senza telefono, senza termosifone. Abbiamo visto da bambini, soprattutto se abitanti nella provincia, le ultime tracce dell’antichità. Il braciere e il ferro da stiro con i carboni ardenti, la borsa calda a letto per scaldarsi i piedi e difendersi dai mitici geloni, i traini dei contadini con il cane a strascico e la testa penzolante per il sonno, le trottole in legno al posto del Game Boy.
E le fontane nelle notti sitibonde d’estate, assediate per riempire gli otri o per disputarsi tra ragazzi il getto stanco di un estremo zampillo. Le gloriose pompe ferrigne e arrugginite. A vederle umide intimamente gioivi, a vederle secche soffrivi come se fossero inanimate, regredite a rocce. Tutto il Sud antico dell’infanzia ruotava intorno al desiderio d’acqua: le incessanti arsure della sera, le infinite bevute a cannella, i secchi del pozzo versati sulla testa in una doccia primitiva, le file notturne alla fontana perché l’acqua si faceva pregare e arrivava come una star dopo la mezzanotte, il sollievo primordiale di una sciacquata che redimeva il sapore sporco di una fatica andata. Offrire acqua agli assetati era la clemenza del Sud, il galateo primordiale verso l’ospite, il garbo antico dei bar che te la danno anche non richiesta, in memoria dell’antica arsura, insieme al caffè. Le relazioni sociali fiorivano intorno alle fonti nel vecchio Sud dall’acqua condizionata.
A sette anni, cambiando casa, traslocai nella modernità. Con i primi elettrodomestici grandi potenti resistenti. Il frigorifero sembrava un forziere di Fort Knox, che s’apriva col pedale; ho passato ore da bambino a capire se la luce interna si accendeva al mio gesto di aprirlo o se continuava a illuminare l’abitacolo al chiuso, indipendentemente da noi. Non era solo curiosità bambina ed egocentrica; era il riverbero di una filosofia: se gli oggetti sono nostra volontà e rappresentazione, esistono in virtù nostra; o se, viceversa, esistono indipendentemente da noi. Congelava l’antico dilemma tra l’oggettività e il soggettivismo. Il primo frigorifero lo conobbi in prima elementare a casa di un amico. Mi colpì il suo lato barbaro e abominevole perché il mio amico apriva il frigo e tracannava – che schifo – da una bottiglia di plastica – che schifo – l’acqua frizzante – che schifo – direttamente dal frigo, senza nemmeno miscelarla. Mi parve allora una vergogna, pensavo che fosse lui il barbaro e io il civile. Poi diventò consuetudine universale e si scambiarono le parti.
Il televisore era un bestione obeso, oggetto di timorosa venerazione: vedete la tv a distanza di tre metri, raccomandavano, spegnete la luce nella stanza e lasciate solo un lume sull’apparecchio rivolto verso l’alto. Di solito erano odiosi cilindri che sembravano lampade votive per ingraziarsi la visione. Arrivò pure il registratore che riproduceva coi suoi nastroni le voci e le prime balbettanti fesserie, tra il divertito stupore di noi primitivi. Come un grosso topone in fase d’alpinismo c’era il telefono a muro, nero e squillante, dalle poche cifre e dal sordo roteare. In famiglia arrivò tardi pure la prima Seicento Fiat che sfiorava i cento orari, gonfia di famiglia, più zia nubile e bagagli. Era un bene di famiglia. La sua targa era come il nome di un altro fratello: BA 107449. La prima targa come il primo amore non si scorda mai.
Ma quello era già il passaggio d’epoca. Soffermiamoci invece su quel mondo residuale conosciuto poco prima. La preistoria. L’abisso che separa la generazione nata negli anni Cinquanta dai suoi figli è superiore a quello che separava noi dai bambini di duemila anni prima. C’era il boom economico, è vero, ma in provincia arrivava in differita, e al Sud in terza visione. Il progresso s’attardava a fare shopping in città, rallentando in curva e dimenticando la periferia. Cos’era il mondo prima della luna calpestata dagli astronauti, della nutella e della tv. Ho visto i contadini antichi, storti e legnosi come gli alberi di ulivo, che odoravano di terra e di campagna; ho visto le pecore e le galline vere, non in cartone animato. La provvista d’olio e di salsa come segni di ricchezza e di polizza contro l’ancestrale paura di carestie. L’acqua che si manteneva fresca nel ciccinato o nella quartara, l’otre. Era l’ultima generazione che curava gli ascessi dentali con gli impacchi di bietole, il catarro con le pezze calde sul petto e i vermi intestinali con l’aglio e le formule magiche; come quelle che usavano i pescatori per tagliare le trombe d’aria in alto mare. A tavola non era arrivata l’alimentazione light: si mangiavano cose pesanti, come lo sfricone, un soffritto di cipolle, e il sangicchio del porco (sanguinaccio di maiale, speziato e variamente arricchito). I segni di modernità erano la brillantina Linetti, il chinino, Olà, Spic & Span. E poi le partite di calcetto giocate persino con il tappo di bottiglia (da noi nota come chianella); le gare con la carriola in legno, il gioco della monetina lanciata contro il muro, una forma povera e antica di tennis mista a golf. Si vedevano ancora circolare per la casa con deferenza le coperte militari, le scarpe e i «bolli» di cioccolata distribuiti in caserma; roba ammirata e affidabile, perché allora tutto ciò che era statale era per definizione meglio di ciò che era commerciale. Fummo l’ultima generazione che vide in faccia i ragazzi del ’99 e gli ultimi vecchi dell’Ottocento, baffi in su, orologio a cipolla e colletto inamidato, poche parole e tanta dignità. Fummo gli ultimi bambini a uscire da soli la sera a otto anni, avevamo le chiavi di casa. Per noi Totò e Charlot erano due comici viventi e non due figure leggendarie. Leggevamo «Blek Macigno», «Tarzan», «Capitan Miki», e spiavamo la «Domenica del Corriere» e la «Tribuna illustrata» dei grandi, le figurine e gli album al posto della tv, del tablet e del pc. Fu l’ultima generazione che il venerdì non mangiava carne, la domenica sentiva la messa in latino, o addirittura la serviva, il 2 novembre non cantava per rispetto dei morti, a Natale lasciava la letterina sotto il piatto del babbo e il Venerdì santo vedeva piangere la gente alla Via Crucis, le mamme antiche vestite di nero che ricordavano il loro figlio, il loro sposo e il loro fratello – povero cristo morto in guerra.
Fummo la generazione che incontrava non solo gli asini per strada e i loro cugini muli, ma anche la capra che il vaccaio mungeva davanti ai tuoi occhi per una bevuta live; che frequentava in lunghe sedute il calzolaio, il sarto, l’arrotino e l’ombrellaio che riciclavano il passato – scarpe risuolate, giacche rivoltate, camicie con il colletto di ricambio, lame e lamette rigenerate – perché non si buttava niente. Il barbiere che ti dava i calendari profumati con le donne pettorute e faceva il gossip sul paese, parlando in modo impersonale, con quel «si» davanti che ne garantiva l’oggettività. Fu curioso da grande imbattermi in un filosofo astruso e oracolare, Martin Heidegger, che si soffermava anche lui come il barbiere sul «si» impersonale della chiacchiera. Quella fu l’ultima generazione «vaccinata» come le vacche, contro il vaiolo, oltre che contro la tbc e la poliomielite; che chiamava la mensa scolastica «refezione» e risparmiava le 5 e 10 lire nell’apposito maialino di creta.
Vedemmo in circolazione per un pelo anche la Madre di tutte le nostre finanze, divenuta poi la Nonna: la moneta da una lira, ormai piccola e impotente. Al mio tempo l’unica cosa che potevi comprare con una lira era un pesciolino di liquirizia. Era fuori corso ma esisteva ancora, come una vecchia in pensione che si godeva i nipoti, tra cui spiccava la lussuosa 500 lire in argento. Era bella, c’era persino chi la lucidava.
Fummo gli ultimi bambini che mangiavamo tanta frutta considerandola un premio e non una punizione; che masticavamo zippi dolci, ovvero radici di liquirizia, e lupini, principale oggetto di colluttazione al cinema per via delle bucce sputate sui sedili davanti; che ignoravamo la dieta dimagrante come le creature obese e ipernutrite dall’american life, e che portarono fino a tredici anni inoltrati i calzoni corti. L’ultima generazione che ha vissuto la domenica come giorno speciale, con la radio ad alto volume, l’odore di ragù per la casa e per le strade, il rito del bagno in tinozza (rispettando i turni famigliari); e poi il vestito buono della festa, la camicia bianca con le stecche dentro il collo, le scarpe lucide e olezzanti di cromatina. L’ultima generazione che ha visto la differenza di classe con i borghesi che si riunivano in una piazza o davanti al caffè e i contadini in un’altra, e così gli studenti da una parte e i lavoratori dall’altra. E il cappellaio che, quando vendeva un cappello a un borghese, dava un colpetto gentile sulla cima per dare il garbo al copricapo e curvare lievemente le falde; mentre, se lo vendeva a un contadino, dava un colpo rude all’interno per gonfiarlo sulla testa e abbassargli le falde, come s’addiceva al cafone. Finirono le classi quando chiuse quel negozio di cappelli. Era l’epoca in cui gli extracomunitari erano del posto e non spacciavano droga ma bibite nel secchio d’acqua fresca, noci di cocco e pelose.
A scuola i banchi erano di legno grezzo, le schegge ti entr...