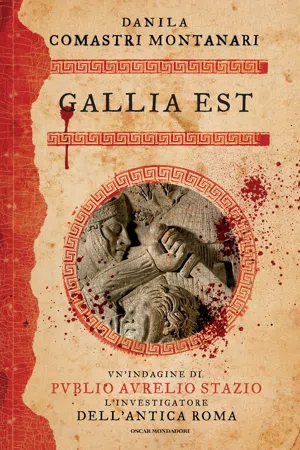![]()
Quarto giorno prima delle Idi di novembre
Alle porte della città si apriva la pingue campagna narbonese, fitta di vigne e frutteti. Il clima mite, la fertilità del suolo e l’irrigazione naturale offerta dai meandri del fiume rendevano il delta del Rodano la regione più ricca di tutta la Gallia: Arelate, Nemasus, Arausio, e più a nord la grande Lugdunum, erano soltanto i maggiori tra i centri urbani che fiorivano nella ricca provincia, città non meno prospere e romane di quelle ubicate al di là delle Alpi, come Augusta Praetoria, Augusta Taurinorum e Alba Pompeia.
Sebbene la residenza degli Elvii si trovasse fuori dalla vecchia cerchia muraria, distava dalla casa di Artige meno di mezzo miglio e sarebbe stata facilmente raggiungibile a piedi. Ciononostante, sapendo quanto contassero per gli ottimati i segni esteriori della nobilitas, Publio Aurelio aveva voluto presentarsi in pompa magna, con tanto di littori, lettighieri, guardie del corpo e persino flabelliferi provvisti di ventagli, del tutto superflui in Gallia, dove di vento ne tirava anche troppo.
Giunto al vasto piazzale, il senatore scese dalla portantina e si guardò attorno.
La villa di Marco Elvio Valente era una residenza di tutto rispetto, che trasudava potere e abbondanza da ogni mattone, dotata com’era di amplissimi spazi, impossibili da procacciarsi nel centro della città; a partire dalla casa, poi, si estendevano a perdita d’occhio i fertili campi della famiglia, in un’estesa proprietà terriera coltivata a vite che doveva rendere un vero patrimonio.
Al momento della conquista della Gallia Narbonese, infatti, gli accorti antenati di Valente erano stati i primi a partecipare alla spartizione del bottino, incamerandosi alcuni latifondi di enorme valore, ben più redditizi dei magri possedimenti aviti nel Sannio e nell’agro romano; da allora, ogni paterfamilias della stirpe trascorreva sulle sue terre sul Rodano abbastanza tempo da controllare che il flusso di denaro e derrate alimentari proveniente dalla Provincia non avesse a calare o a estinguersi.
«Benvenuto senatore!» lo accolse un giovane sulla soglia. Dunque, per la seconda volta il collega Valente non si era degnato di venire a riceverlo e aveva preferito delegare al suo posto il figlio Lucio, assieme alla sorella Elvia Valentina, che l’omicidio aveva appena reso precocemente vedova.
I due giovani si somigliavano moltissimo, tanto da sembrare quasi gemelli, anche se il maschio contava qualche anno in meno della primogenita. Entrambi erano ricchi, belli, biondi e con gli occhi tanto chiari da far dubitare della loro origine latina, osservò il patrizio, ricordando all’improvviso che la loro madre era stata una ricca matrona di Placentia, nata al di qua del fiume Padus, è vero, ma pur sempre nella Gallia Cisalpina.
«Nostro padre ti prega cortesemente di attenderlo finché non avrà finito di disporre le esequie» disse Lucio dopo i convenevoli d’uso.
«Devi trasferirti immediatamente da noi, senatore» intervenne la sorella, mentre si liberava con un gesto di malcelato fastidio dalla stola del lutto. «Non puoi alloggiare in casa dell’assassino di mio marito.»
«Non intendo disturbare il tuo dolore, nobile Valentina» si sottrasse abilmente il patrizio.
«Ti fai troppi scrupoli, Publio Aurelio» ridacchiò Lucio. «Mia sorella si era sposata soltanto per compiacere nostro padre, consolidando per tal via un’indispensabile alleanza politica. Irzio era un vecchio tedioso e bigotto, dubito che Elvia lo piangerà a lungo... non è vero, sorellina?»
«Modera la lingua» ribatté lei, seccata.
«Perché fingere?» insistette lui. «Il senatore Stazio è un uomo di mondo, non un bigotto come nostro padre o quel poveraccio che sta attraversando la palude Stigia sulla barca di Caronte: gente seriosa, priva di fantasia, assolutamente incapace di capire la voglia di vivere e di godere delle nuove generazioni.»
«Attento a quello che dici: siamo in Gallia, non a Roma, e qui la gente prende ancora terribilmente sul serio il matrimonio» lo redarguì Elvia Valentina prima di proseguire, rivolta all’ospite: «In verità mio fratello ha le sue ragioni. Tra me e Irzio c’era ben poco in comune, a cominciare dall’età: aveva sessantacinque anni, quattro in più di nostro padre, mentre io ne ho appena compiuti ventisei. Quarant’anni di differenza sono troppi perché tra due persone possa nascere, non dico un sentimento profondo, ma anche una semplice amicizia. Dunque, ci rapportavamo l’un l’altra come due estranei, uniti da un contratto d’affari che pesava a entrambi. Ma per quanto non lo amassi, Irzio era pur sempre mio marito, un valoroso soldato di Roma e un membro della Curia, per cui desidero vedere al più presto nelle mani del carnefice l’uomo che ha osato stroncare la sua vita. L’omicidio di un senatore romano è un delitto esecrando, un’infamia che...»
«... Che grida vendetta al cospetto degli Dei e deve essere punita con la massima severità» terminò Aurelio. «Per noi padri coscritti è di grande conforto sapere che la nostra eventuale eliminazione anzitempo susciterebbe tanto nobile sdegno.»
«Ah, ah!» gli batté la mano sulla spalla il giovane Elvio. «Hai sentito, sorellina, non è divertente?»
«Scusami, Lucio, ma in questo momento ho poca voglia di ridere.»
«Su, non abbatterti. Adesso che sei vedova, potremo di nuovo prenderci un po’ di svago senza che nessuno trovi da ridire: feste, balli, spettacoli, banchetti. A Roma, naturalmente, non certo in questo buco, dove tutto marcia al passo modesto della periferia: qualche corsa con aurighi di scarto, un paio di modesti ludi gladiatori, o la solita cena a casa dei pezzi grossi locali, le cui mogli si affrettano a ritirarsi pudicamente nei quartieri femminili non appena viene servito il vino. E non immagini nemmeno quanto siano orgogliosi delle loro conquiste, questi piccoli provinciali pieni di boria! Difendono le loro prerogative di nuovi arrivati con uno spirito di classe che nemmeno i più nobili tra i padri coscritti osano più esibire, per paura di passare da retrogradi. Dovresti vederli, con i loro mantelli di chiassosa porpora di Chio, comprata a cinquanta dracme alla spanna; è già molto che non ci lascino sopra il cartellino del prezzo, per mostrare a tutti che se lo possono permettere!»
«Lucio» lo riprese la sorella. «Il nostro ospite è venuto a porgerci le condoglianze, non a discutere i costumi pacchiani dei nativi.»
«In ogni caso non vedo l’ora di tornare nell’Urbe» mugugnò il giovane.
«A me lo dici?» ribatté la ragazza. «In questo maledetto paese le donne non vanno né al circo né all’arena, e raramente mettono piede in un teatro. Oh, non che sia proibito per legge, ma si reputa disdicevole. E se lo fai, tutti ti guardano di traverso» spiegò al senatore.
«Insomma, la Gallia ti sta stretta» concluse Aurelio.
«Eccome!» confermò Elvia. «Ciò non toglie che intenda restare fino a quando vedrò punito l’assassino di Irzio. Non tollero che quel celta rinnegato di Artige se la cavi a buon mercato; è lui il vero mandante dell’omicidio, il figlio ha agito per ordine suo, ne sono sicura.»
«Non dovrai attendere molto, sorellina» si intromise Lucio. «I nostri uomini sono già sulle tracce di Romolo. Pare che stia dirigendosi a Glanum, ma al suo arrivo troverà una brutta sorpresa: abbiamo disposto una trappola per catturarlo.»
«Come potete essere tanto certi di non sbagliarvi?» interloquì Aurelio. «Il vostro procurator può aver preso un abbaglio.»
«Perché quel lurido barbaro fuggirebbe come una lepre, se non fosse colpevole?» dichiarò Lucio. «D’altra parte, che cosa non ci si poteva aspettare dalla genia dei pezzenti italici arruolati da Mario nelle sue legioni?»
«Questi Artigi Galliani che adesso brigano per prendere il nostro posto in Curia» spiegò la sorella «sono semplici contadini che durante la rivolta di Massalia furono tanto accorti da mettersi dalla parte di Cesare, avendone in cambio la cittadinanza e un’assegnazione di terre. A mano a mano che Massalia, alleata con lo sconfitto Pompeo, perdeva i suoi possedimenti nell’entroterra, loro li incameravano.»
«Se non sbaglio, anche il vostro capostipite cominciò così» ribatté Aurelio, irriverente.
«Nobile Stazio, tu dimentichi che noi siamo veri romani!» protestò una voce alle sue spalle e Marco Elvio Valente, il paterfamilias, apparve sulla soglia, imponente nella toga bordata dal laticlavio.
Aurelio lo scrutò con malcelato interesse: il corpo energico e asciutto pareva a prima vista quello di un uomo ancora nel vigore degli anni, ma a guardarlo più attentamente vi si scorgevano l’estrema rigidità degli arti e il disagio a muoversi, penose conseguenze della malattia artritica che lo affliggeva da tempo. Il padre coscritto, tuttavia, sapeva ben simulare la sua intrinseca debolezza, atteggiando la bocca a una piega amara e nel contempo altezzosa, dura sotto un romanissimo naso pronunciato, ben diverso da quello, un po’ camuso, che i figli avevano ereditato dalla madre cisalpina.
«Ave, Marco Elvio Valente!» lo salutò il senatore levando la mano.
«Ave, Publio Aurelio Stazio!» rispose l’altro con fredda cordialità e subito aggiunse: «So che cosa sei venuto a fare in Gallia. Quell’insipiente di Claudio Cesare intende spazzar via gli ultimi residui dell’antica aristocrazia, come se non avessero già provveduto a decimarla le guerre civili e i suoi sanguinari predecessori! E dobbiamo pure ringraziarlo, perché, al contrario del pazzo Caligola, ci usa cortesia di lasciarci la testa sul collo, dopo averci escluso dalla gestione della cosa pubblica in favore di una puttana da trivio e di un paio di ex schiavi ellenici!».
Aurelio tacque: nemmeno a lui garbava l’ingerenza negli affari di Stato dell’imperatrice Messalina, bella come Afrodite e altrettanto invereconda, e lo strapotere dei liberti imperiali Pallante e Narciso, ministri degli Esteri e delle Finanze...
«La Curia è ridotta ormai a un salotto di comari litigiose, pronte ad accapigliarsi per ottenere la precedenza alla processione di Giunone Lucina!» tuonò Valente, indignato. «Mentre i padri coscritti dissertano dottamente su argomenti quali i giorni fausti e infausti, gli ingredienti della mola salsa delle vestali, le interiora del toro sacrificato a Giove Capitolino o la stoffa della laena del flamen Dialis, una combriccola di servi corrotti manovra le vere leve del potere, ovvero i soldi! Oggi, persino nelle province senatorie gli incaricati della Curia non riescono più a riscuotere le tasse senza l’assistenza dei procuratores imperiali, che rispondono direttamente al liberto Pallante, anziché all’assemblea dei togati. Ma il nostro magnanimo imperatore, non pago di avere rimesso il governo di Roma ai suoi domestici, medita ora di porre i barbari della Gallia Comata alla pari coi quiriti di antica schiatta. E per spianare la strada alla sua sciagurata riforma ha mandato in avanscoperta te, l’unico uomo di tutto l’impero che gli era già amico quando coloro che oggi si prosternano davanti a lui non lo chiamavano ancora divino Cesare, bensì Claudio l’idiota o Claudio il babbeo!»
«L’Urbe non è più un piccolo borgo sul Tevere, cinto da mura di mattoni» gli rispose il patrizio, sforzandosi di mandar giù l’offesa arrecata al suo imperatore e amico. «Quella che chiamiamo Roma, oggi si estende dalla Britannia alla Mauritania e dall’Armenia alla Pannonia. Le colonie dei veterani sono dappertutto e gli ex legionari si mescolano inevitabilmente con la popolazione del luogo: che senso avrebbe considerare gli abitanti di Arelate, Lugdunum, o persino della nordica Lutetia, diversi da quelli delle città padane? Hai forse scordato la sciagura che si abbatté su di noi ai tempi della Repubblica, quando un pugno di ottusi aristocratici trascinò l’intera penisola in una guerra rovinosa, nell’intento di negare agli alleati italici la cittadinanza che si erano conquistati col sangue, combattendo al nostro fianco?»
«Mi sembra di sentir parlare Artige!» esclamò sprezzante il padre coscritto. «Sei sicuro di non essere celta anche tu?»
«Fammi pensare, può darsi che anche qualche mia antenata venisse da Placentia o da un altro municipio della Cisalpina...» ribatté perfidamente il senatore.
Elvio Valente ingoiò l’insinuazione mordendosi la lingua: si era dato tanta pena per occultare le origini della sua defunta moglie, ricca ma non proprio di latinissime origini, che non avrebbe mai immaginato che il senatore Stazio ne fosse a conoscenza.
«Comunque mio genero è appena caduto vittima di barbari che voi considerate tanto affidabili. I fatti parlano chiaro: Artige voleva la riforma, Irzio la osteggiava, quindi è stato eliminato» borbottò il padre coscritto.
«Però il capanno non è arso interamente...» precisò il senatore, ansioso di ispezionare il luogo del delitto.
«No. In effetti il fuoco ha attecchito male, perché è stato acceso con legna umida: i giardinieri, oltre a riporre nel capanno i loro attrezzi, vi mettevano anche a seccare i rami verdi appena recisi dai cespugli. “Tipico di un uomo oculato come Valente, conservare anche i residui della potatura” pensò il patrizio.
«Marco Elvio, stento a credere che un esperto soldato se ne sia stato buono buono a farsi bruciare vivo. Viene da pensare che non fosse in condizioni di reagire.»
«Ma lo ha fatto: in mano gli abbiamo trovato questo» affermò Valente mostrandogli un falcetto di bronzo a forma di becco di corvo, di quelli usati, insieme alle cesoie, dai topiarii del giardino per dare ai cespugli le forme più strane e fantasiose.
«Il corpo presentava forse segni di lotta?» insistette il patrizio.
«Non sono né un medico, né un vigile notturno per prestare attenzione a questi particolari. E a che scopo, poi? Sappiamo tutti da chi è stato ucciso mio genero. Quando Porfirio, vedendo il fumo nero, è accorso verso il ripostiglio, Romolo gli è passato praticamente sotto il naso!» esclamò Valente, spazientito. Non bastava il dolore di una grave perdita familiare, sottintendeva il suo tono insofferente, doveva anche subire il serrato interrogatorio di un impiccione pronto a soppesare ogni singola risposta, quasi che lui stesso, e non il figlio di Artige, fosse sospettato del delitto.
«Come aveva passato la mattina, Irzio?» curiosò infatti Aurelio.
Valente fremette: chi altri avrebbe osato rivolgersi in quel modo a un padre coscritto, se non il senatore Publio Aurelio Stazio, ben noto in Curia per la sua irriverenza verso ogni forma di autorità costituita, prima tra tutte quella dell’alto consesso di cui faceva indegnamente parte? E presto ce ne sarebbero stati altri come lui, se non si fosse scongiurata la disgraziatissima riforma che quel dissennato di Claudio intendeva mandare in porto...
«Ti pregherei, illustre collega, di riferirmi circa le ultime ore del tuo chiarissimo genero...» ribadì il patrizio, per nulla intenzionato a demordere. L’altro cedette, rassegnato: Stazio gli ricordava uno di quei cani stizzosi che si attaccano coi denti al polpaccio di un passante e non lo mollano nemmeno sotto una gragnuola di bastonate.
«Irzio si era alzato prestissimo, come sempre d’altronde: gli piaceva di lavorare nelle prime ore del mattino. Prima di farsi vestire in modo acconcio per accoglierti, aveva dettato alcune lettere all’intendente, chiudendosi poi a chiave nel tablino.»
«Anche questo rientrava nelle sue abitudini?»
«In verità, non l’aveva ...