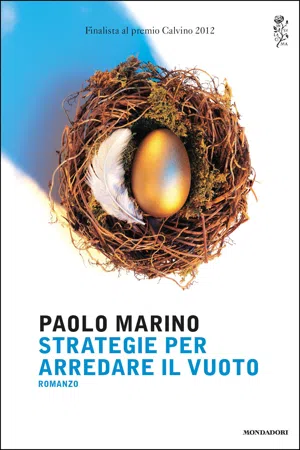![]()
![]()
Lavinia si tagliava le unghie dei piedi seduta sul pavimento del balcone, la schiena appoggiata alla ringhiera. Indossava un paio di calzoncini corti e una maglietta a righe. I capelli castani le cadevano sulle spalle e rispecchiavano il riverbero della luce che s’incuneava attraverso i tendoni verdi. Immersa nella più seria delle espressioni, muoveva le forbicine con precisione e radunava in un mucchietto le scaglie bianche. Quando ebbe finito le spinse sul bordo del balcone, le contemplò e con un gesto definitivo se ne liberò, quindi prese lo smalto rosso, lo aprì ed estrasse un pennellino. Un odore fastidioso mi colpì le narici. Mi voltai verso di lei e la osservai mentre stendeva meticolosamente il colore, passando da un dito all’altro, prima sul piede sinistro, poi sul destro. Si scostava per osservare il risultato d’insieme e si piegava per cogliere i dettagli, quasi toccando le mattonelle col naso.
Arrivò Greta con un asciugamano arrotolato sulla testa, prese una sedia, la portò sul balcone, scostò il tendone e si sedette al sole. Lavinia alzò lo sguardo verso di lei e si spostò per mantenersi al centro della zona d’ombra. I capelli di Greta erano rossicci, venati da riflessi scuri. Li spazzolò, poi chiuse gli occhi e lasciò cadere la testa all’indietro, appoggiandola alla ringhiera del balcone. Allungò le gambe e si puntellò coi piedi sulla parete opposta. Anche lei indossava pantaloni corti, una maglietta e scarpe da ginnastica di tela che arrivavano alle caviglie.
Lavinia si alzò, passò in sala, scomparve per qualche secondo, tornò con una banana in mano e si sedette sulla poltrona di fronte a me. Disse che era troppo matura.
«Quando diventano nere le odio.»
Greta si affacciò e si diresse all’altra poltrona. Lavinia si azzittì, finì la banana e si accovacciò con la buccia che le penzolava da una mano, le gambe piegate e strette al petto, gli avambracci appoggiati sulle ginocchia, gli occhi immobili. Non guardava né verso di me, né verso la sorella, ma sembrava concentrare la sua attenzione su un punto indefinito della parete. Greta era rivolta verso Lavinia, ma non mostrava alcun interesse nei suoi confronti. L’attraversava con le pupille, raggiungeva la cucina, sgattaiolava dalla finestra e planava sulle foglie dell’albero che stava là fuori.
Pensai che dovesse succedere qualcosa, invece non accadde nulla. Restammo un bel pezzo a quella maniera, Lavinia ipnotizzata dal vuoto della parete, Greta proiettata da qualche parte oltre la stanza. Avranno avuto le loro ragioni per ignorarsi e non ritenni di dover fare domande.
Mi voltai verso il televisore. Era acceso e col volume al minimo. Un ghepardo correva al rallentatore, portava le zampe posteriori quasi all’altezza del muso, si dava una spinta forsennata e si protendeva in avanti stirando le zampe anteriori nel tentativo di ghermire una gazzella che sfrecciava tra l’erba secca, scavalcava gli arbusti e scartava bruscamente di lato cercando di seminarlo. Alla terza virata il ghepardo fu pronto a cambiare direzione, strisciò con le zampe sulla terra e alzando una nuvola di polvere azzannò la preda a una coscia. La gazzella cadde, un secondo dopo il ghepardo le fu addosso e la prese alla gola. Stringeva coi denti e la gazzella si dibatteva. Quando si acquietò, il felino si staccò qualche secondo, pregustò il pasto e affondò le fauci.
È iniziata così, in modo apparentemente innocuo. Sembrava niente e invece era già tutto lì. Ripensandoci ne sono convinto. Ma è una di quelle convinzioni che non servono a nulla, che si formano a cose fatte, che riavvolgono un filo a ritroso alla ricerca del bandolo per il gusto di mettere in ordine i fatti. Solo un esercizio per darsi pace.
Ho infilato un errore dietro l’altro e il più grossolano è stato supporre un sodalizio tra Greta e Lavinia, vederle come indivisibili, declassando l’individualità di ciascuna agli angoli vivi di un’entità alla quale ero solito riferirmi come “le gemelline”. Non ignoravo le scintille che si producevano nell’attrito tra una parola e l’altra quando le loro schermaglie s’infittivano, tuttavia lo ritenevo un fenomeno naturale in una materia turbolenta, che non ne avrebbe minacciato l’equilibrio generale e la solidità. Ovviamente mi sbagliavo.
Me ne resi conto il giorno che Greta entrò sconvolta nella mia camera, il volto infuocato, gli occhi spalancati, la bocca deformata, i capelli fradici appiccicati alla pelle. Anche la faccia e la maglietta erano bagnate e l’acqua colava sul pavimento, formando una pozzanghera ai suoi piedi. Si era piantata di fronte a me, le braccia strette lungo i fianchi e i pugni chiusi.
Non sapevo cosa fare, non ero preparato a portare aiuto ed esprimere solidarietà. M’irrigidii anch’io e non dissi nulla, comportandomi con la cautela che si riserva alle cose fuori dal comune. Forse non fu un male. Con la mia inadeguatezza le restituii una sensazione di estrema gravità che non la lasciò abbandonata a se stessa. Anche se non capivo, eravamo pur sempre in due a percepire l’enormità della faccenda.
Si accasciò sulle piastrelle bagnate appoggiandosi con una spalla al muro. Aveva l’aria stremata e abbassò gli occhi, risparmiandomi la pena di raccogliere informazioni sull’accaduto. Andai in bagno a prendere un asciugamano e trovai il lavandino pieno d’acqua insaponata e il pavimento allagato. Tornai, le appoggiai la salvietta sulle ginocchia, lei la guardò e sembrò soppesarla prima di passarsela sui capelli, che strofinò tirando su col naso.
Mi sedetti sul letto e rimasi muto. Si sarebbe potuto dire che aspettassi qualcosa. In realtà i pensieri avevano preso fuoco ed erano rimasti soltanto scheletri fumanti che non sapevo come interpellare.
In sala trovai Lavinia sdraiata sul divano con il broncio. Le lanciai un’occhiata interrogativa e lei replicò ringhiando.
«Cosa vuoi?»
Ripiegai in camera non sapendo cosa augurarmi. Sospettavo che una relazione sui fatti sarebbe stata dolorosa e umiliante per Greta e decisi di non fare domande. Stavamo così, uno di fronte all’altra, in attesa che la sabbia smossa sul fondo tornasse a depositarsi. C’era stata una zuffa, questo non era difficile intuirlo, e la luce s’era intorbidita. Era come stare immersi in un lago di montagna, profondo, l’acqua nera e gelida. Scendevamo assieme, sempre più giù e a poco a poco ci perdevamo di vista. Ma sapevamo di non esserci allontanati e che saremmo riemersi. Ci voleva soltanto pazienza, in quelle condizioni non c’era modo di fare nulla, era meglio starsene ognuno nel suo angolo.
![]()
L’estate si attaccava alla pelle e non mollava. Non mi aspettavo che potesse diventare tanto inospitale, trasformarsi in un oceano rovente che esplode in un milione di atomi. Quando un rumore attirò la mia attenzione ero sdraiato sul letto, invaso da umori che percolavano in un punto nascosto, tra stomaco e intestino, dove ribolliva il brodo dell’indolenza. Era un tonfo, ogni volta anticipato da un lamento, una membrana che si sfibrava in un urlo e si serrava in un pugno. Ci misi un po’ a capire che una palla veniva lanciata contro un muro.
In cortile Lavinia faceva rimbalzare un pallone contro la parete opposta ai garage. Un lancio dietro l’altro: prendeva la palla al volo, caricava gambe e braccia, scagliava e riafferrava. Una sequenza ininterrotta e testarda nella sfiancante tinozza dell’afa pomeridiana.
La osservai per un paio di minuti e quando fece una pausa la chiamai. Lei si girò e alzò lo sguardo portandosi una mano sopra la fronte per riparare gli occhi dalla luce. Grondava di sudore.
«Cosa fai?»
«Lancio la palla.»
«Vedo.»
«Ti dà noia?»
«Per niente.»
«Meglio.»
«Non hai caldo?»
«Caldo?»
«Si crepa.»
«Già...»
«E Greta?»
«A casa.»
«Tu vieni su?»
«Adesso no.»
«Sicura?»
«Rimango qua ancora un po’.»
«Okay.»
Mi rifugiai nell’ombra della stanza e Lavinia ricominciò a lanciare la palla. Mi sedetti sul bordo del letto e contai i suoi lanci, seguendoli mentalmente con un lieve movimento del busto, ogni volta piegandomi in avanti. Arrivò a 42, s’interruppe e riprese. La seconda serie terminò a 26, poi non si sentì più nulla. In attesa del terzo round contai fino a 50, e infine mi affacciai. Lavinia se n’era andata.
Trovai consolante che in casa ci fosse il rappresentante. Mi sedetti accanto a lui in sala e gli passai dei biscotti che avevo preso in cucina. Mise una mano nella scatola, ne tirò fuori tre o quattro, si girò verso di me e sorrise. Per un’ora non ci furono parole e la luce cambiò, facendosi più morbida. Quando attaccò capii che era incappato in una delle sue perturbazioni interiori, sembrava aver bisogno di una giustificazione per ogni cosa. Non riusciva a compiere un’azione in modo incurante, per esempio prendere il pacchetto delle sigarette, estrarne una, appoggiarsela tra le labbra e accenderla, come chiunque avrebbe fatto. In quei momenti doveva per forza illustrarti le ragioni che animavano i suoi gesti e farti capire che non erano fatti a caso, che ricadevano in qualcosa di più grande.
Fumando, il rappresentante insisteva su due elementi: il fuoco che brucia all’estremità e il fumo che si spande nell’aria. Erano cose a cui riservava una particolare attenzione, decisamente più di quanto ci si sarebbe aspettati, e si sentiva ispirato soprattutto la sera quando si appoggiava alla ringhiera del balcone. Dalla sala si scorgevano soltanto la brace rossa e la sua figura nera sullo sfondo del cielo.
«Tutto viene da lì lo vedi anche tu che la punta della sigaretta diventa rossa e se la tocchi brucia e c’è questa cosa che devi aspirare per farla incendiare gli devi togliere l’aria come se dovessi soffocarla ma invece di morire quella si rianima e però nello stesso tempo muore e si riduce fino a scomparire.»
Erano i suoi momenti migliori e, per quanto strampalati fossero i suoi pensieri, dimostrava di poterne avere in qualche modo il controllo.
«Quando in bocca ti prendi l’aria che passa attraverso la sigaretta e la butti dentro ai polmoni la brace diventa incandescente e si anima ma è anche il modo che ha di andare verso la morte e alla fine sei costretto a schiacciare il cicco nel posacenere e sarebbe lo stesso se lasciassi lì la sigaretta a bruciare per conto su...