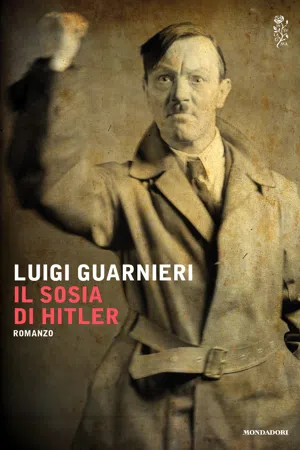![]()
Credo che la mia vita sia il più grande romanzo della storia mondiale.
ADOLF HITLER
![]()
a.
Stando al voluminoso dossier preparato dai funzionari del Dipartimento H, che come ho già spiegato ebbi la fortuna di ritrovare all’inizio del 1948 nella baita di Altaussee, Mario Schatten venne al mondo il 13 gennaio 1891 in Alto Adige, in una minuscola frazione della Val d’Ultimo. Suo padre Rudolf era una guida alpina, uno scalatore esperto e audace che dopo un grave incidente sulla parete nord-est del Pizzo Badile appese i moschettoni al chiodo e cominciò a gestire il ristorante di un albergo. La madre, Anna Bodoni – figlia di un ingegnere di Rovereto specializzato nel progettare dighe e impianti idroelettrici – era un’insegnante elementare nonché una pianista dilettante di buon livello. Quando Mario aveva sei anni la famiglia si trasferì a Innsbruck per lavoro; lui frequentò le scuole medie e cominciò a prendere lezioni private di pianoforte, violoncello e teoria musicale. Al ginnasio riportò ottimi voti nelle materie umanistiche, appena sufficienti in quelle scientifiche. Mostrava una spiccata inclinazione per gli studi letterari: nel dossier dell’SD erano addirittura conservati i testi di alcuni versi giovanili e l’abbozzo di un racconto umoristico dal titolo Catalogo aggiornato delle specie in estinzione. Nel 1908 il padre lo portò al festival di Bayreuth; il ragazzo prese degli appunti sul viaggio, che si aprono con alcune note del Parsifal, e ne ricavò un ampio resoconto di oltre sessanta pagine. Cominciò a tenere un diario che si fece sempre più fitto negli anni successivi, ma sfortunatamente nel dossier non se ne trovava traccia: doveva essere andato perduto, oppure – per qualche ragione destinata a rimanere ignota – venne distrutto proprio dagli agenti del Dipartimento H agli ordini di Sommer.
Influenzato da Wagner, nel 1909 Mario realizzò il suo primo saggio di composizione di una certa ampiezza, una Ballata per soprano e orchestra sul testo di una poesia di Stefan George. In realtà sembra che il padre dubitasse del suo talento musicale, e che abbia cercato di convincere Mario a studiare ingegneria come il nonno; nell’autunno del 1909 venne invece ammesso all’università di Vienna e si dedicò a studi di musicologia con Guido Adler, seguendo seminari di armonia e contrappunto con Hermann Grädener e Karl Navrátil. L’Istituto di storia della musica possedeva una bella biblioteca e un meraviglioso pianoforte Bösendorfer, che Mario utilizzava per esercitarsi e per comporre. Frequentò anche le lezioni di filosofia morale del dottor Müller. Si diplomò nel 1913 con una tesi sui Madrigali guerrieri et amorosi di Claudio Monteverdi, opera che il grande compositore – maestro di musica della Serenissima Repubblica di Venezia – aveva dato alla luce nel 1638. Continuò a studiare il violoncello col maestro Gasha, membro dell’orchestra della società dei concerti di Vienna; entrò nel coro della società wagneriana e si esibì nei circoli cameristici per dilettanti.
La prima offerta di lavoro che gli arrivò fu quella di maestro di cappella nell’abbazia benedettina di Lambach, la stessa in cui Adolf Hitler era stato corista e chierichetto. Poi svolse l’identica mansione in un teatro di Landeck: costretto a prestare servizio quotidianamente secondo orari prestabiliti, angariato da registi che lo umiliavano come un cane per pochi minuti di ritardo, si vide obbligato a occuparsi di una musica risibile che non gli lasciava il tempo di dedicarsi alla composizione. Sennonché scoppiò la guerra e Mario, dopo un addestramento affrettato, fu spedito al fronte il 21 ottobre 1914. Due mesi dopo era già in prima linea nella Fiandra francese, a qualche chilometro da una cittadina ridotta a un cumulo di rovine fumanti, a combattere in un dedalo di sentieri invasi dal fango e prati che somigliavano a paludi, nei quali correvano le trincee della fanteria – un labirinto di ricoveri, feritoie, reticolati e camminamenti. Ogni giorno dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio, come se osservassero un paradossale orario d’ufficio, le granate e gli shrapnel facevano tremare la terra in un concerto infernale di sibili, schianti e scoppi. La notte invece erano i cannoni a rombare su tutto il fronte, prima lontani e poi sempre più vicini, mentre i razzi illuminanti disegnavano parabole multicolori nel cielo appannato dal fumo.
Il reggimento si spostava con difficoltà fra binari manomessi, ponti saltati e locomotive distrutte. Per parecchie notti, durante un bivacco in una fattoria diroccata, Mario non riuscì a dormire perché a quattro passi dal suo mucchio di paglia c’era un cavallo morto: da almeno due settimane, a giudicare dall’aspetto della carogna mezza putrefatta. Poi il reggimento si mosse per partecipare a un attacco alle postazioni inglesi. Alle 6 del mattino uscirono allo scoperto in un campo ai margini di un bosco e lo attraversarono correndo a zig zag mentre le mitragliatrici crepitavano senza interruzione e gli shrapnel scoppiavano sulle loro teste con ruggiti e ululati, strappando via gli alberi come fili d’erba e sollevando nuvole di terriccio. Piombarono in una lunga trincea allagata piena di soldati inglesi feriti, moribondi o morti. Schizzarono fuori di nuovo come formiche impazzite e andarono all’assalto di una fattoria fortificata sotto il fuoco di sbarramento dell’artiglieria, facendosi impallinare uno dopo l’altro. Frastornato, confuso, prima di lasciarsi prendere dal panico Mario riuscì a trovare riparo dietro al muro di cinta della fattoria assieme a un giovanissimo tenente che non aveva mai visto prima, ma una granata atterrò con un tonfo sordo a pochi metri di distanza ed esplose con un boato spaventoso. Il tenente venne colpito in pieno e il suo corpo disintegrato si spaccò a metà, le gambe volarono al di là del muro, le braccia col torso nella direzione opposta e la testa spiccata dal busto rotolò lentamente in un rigagnolo. Mario venne investito da un nugolo di schegge e riportò gravi ferite alla schiena, a entrambe le braccia e alla gamba destra; perse molto sangue, ma venne soccorso in tempo dai barellieri e trasferito all’ospedale da campo.
Dopo sei mesi alla clinica militare di Beelitz nei dintorni di Berlino, una volta guarito, ma ormai inabile al servizio attivo, Mario Schatten si arruolò volontario nella Croce Rossa. Fu assegnato al campo di Gorizia, poi venne inviato in Stiria. Fu smobilitato all’inizio del 1917 e tornò a Vienna. Finita la guerra cominciò a lavorare come insegnante e direttore di cori maschili, ma non riuscì mai ad avere una cattedra fissa. Si arrangiò impartendo lezioni private, collaborando con l’Istituto per ciechi della comunità israelitica e con gli Arbeiter Konzerte, i Concerti sinfonici dei lavoratori viennesi – un’istituzione che aveva il compito di far conoscere alla classe operaia la musica romantica e contemporanea. Emil Hertzka, direttore della Universal Edition, gli pubblicò alcuni spartiti. A quell’epoca Mario guadagnava la miseria di 280 scellini al mese. Trascorreva le notti a comporre, seduto a un tavolinetto traballante con carta da musica e matita. Hertzka gli procurò un aiuto da una fondazione americana di beneficenza e una collaborazione saltuaria con l’Ente radiofonico austriaco. Nel 1928 Mario sposò una studentessa del conservatorio di Vienna, Elizabeth Reinhart, figlia di un liutaio svizzero, che l’anno dopo partorì una bambina, Petra. Troppo a corto di denaro per l’esistenza dispendiosa della capitale, si trasferì con la famiglia nel tranquillo e grazioso sobborgo di Mödling, in una modesta villetta a due piani con un piccolo giardino di cui curava personalmente le piante e i fiori: sorgeva nei pressi di Kapuzinerplatz, non lontano dalla bella casa che nel 1812 Beethoven era stato sul punto di acquistare. Gli Schatten facevano la fame, ma erano felici – una serenità che durò poco: il 29 agosto 1931, durante una gita a cavallo, Elizabeth cadde malamente di sella, si ruppe l’osso del collo e morì.
Mario Schatten sprofondò in una crisi depressiva così terribile che per tre anni, dal 1932 al 1935, Petra fu affidata ai nonni materni. Lui si trasferì in una baita sui monti dell’Engadina – sul Piz Grevasalvas, a 2.500 metri di quota – che apparteneva alla famiglia della defunta moglie, e guadagnò qualche soldo dando lezioni di sci ai villeggianti. Intanto meditava, dipingeva e componeva: risaliva a questo periodo la maggioranza delle partiture conservate nel dossier dell’SD – oltre ai pezzi per violoncello solo, quelli per quartetto d’archi, per violino e pianoforte nonché per violoncello e pianoforte, e poi Lieder e cantate. Tornato a Mödling, visse con la figlia in condizioni economiche difficili fino al 1938: dopo l’Anschluss perse anche la collaborazione con la radio e con gli Arbeiter Konzerte, e l’amministrazione nazista gli vietò di svolgere qualsiasi tipo di attività che non fosse l’insegnamento privato. Solo la Universal Edition lo impiegò come correttore e arrangiatore, facendogli trascrivere per pianoforte migliaia di pagine di partiture altrui. La solitudine di cui la sua musica aveva spesso parlato ricoprì anche tutta la sua esistenza, come una campana di vetro. I suoi genitori morirono entrambi nel giro di tre mesi; gli restavano Petra e alcuni allievi, ma ci furono momenti in cui non ne ebbe neppure uno. Continuava a scrivere musica, studiava le partiture dei contemporanei – Mahler e Skrjabin, Debussy e Satie, Reger e Bartók – ma anche le composizioni già classiche di Brahms, il suo autore prediletto, e poi Johann Strauss, Schubert, Beethoven. Era così povero che non poteva comprarsi neanche un biglietto per un concerto. Del resto, ormai veniva boicottato persino Paul Hindemith, che simpatizzava per il regime nazista ma fu costretto a trasferirsi negli Stati Uniti; lasciarono la Germania anche celebri direttori d’orchestra come Bruno Walter o pianisti famosi come Artur Schnabel. Più di una volta pensò di emigrare anche lui: un sogno cui la cronica mancanza di denaro, però, lo costrinse a rinunciare.
Durante la mobilitazione generale fu obbligato a seguire un corso di addestramento della difesa antiaerea, che per sei mesi lo relegò nella caserma di Mödling a trascinare sacchi di sabbia dalle 6 del mattino alle 5 del pomeriggio, per di più in uniforme, con appena cinque ore di libera uscita ogni tre giorni. Una volta ottenuto il congedo tentò di riprendere a comporre; e, con suo grande stupore, nel giro di poche settimane si accorse che adesso, quasi per miracolo, come era accaduto solo nella baita sul Piz Grevasalvas, scriveva la sua musica senza pensare a nulla: le note sgorgavano a ritmo febbrile dalla sua testa, fluide e già perfette, come se una presenza invisibile gli sussurrasse all’orecchio ritmi e melodie. Non era riuscito a diventare qualcuno: ma adesso, all’improvviso, non gli importava più. Per la prima volta, nella sua vita così sfortunata e futile, si sentiva padrone dello spazio, del tempo e di se stesso. Questo stato euforico di esaltazione, però, svanì presto assieme alla vena creativa, e così per mesi Mario si limitò a vegetare nel misero salotto di casa, sprofondato in una poltroncina di vimini con una gigantesca penna stilografica tra le mani – una Waterman che conteneva quasi un decilitro di inchiostro – e un mazzo di spartiti intonsi ammonticchiati in grembo.
Quando non se ne stava seduto a meditare in poltrona, trafitto dallo sguardo desolato della piccola Petra, frequentava le riunioni letterarie del lunedì sera in casa di un’anziana vedova che abitava nei pressi della Peterskirche: per la verità, spinto dalla fame, lo faceva solo per ghermire qualche panino imbottito. Nel corso del rigido inverno del 1940-1941 guadagnò solo quel tanto che bastava a dar da mangiare a sua figlia; quanto a lui, utilizzando i pochi spiccioli che i nonni materni riuscirono a destinargli attingendo alle loro magre risorse, in tre mesi mise insieme a malapena dodici pranzi, sette cene e venti colazioni, più qualche pasticcino sgraffignato di nascosto agli avventori dei café del Graben. Tra il 14 e il 18 febbraio 1941 sfiorò un record mondiale: restò novantasei ore di fila senza mangiare né bere. Con le ultime forze che gli restavano si appostò in un angolo di Stephansplatz, tese un agguato a un passante e con un filo di voce gli confidò che stava crepando di fame; il passante, un giovane dottore di buon cuore, si sentì in dovere di aiutare il poveruomo e gli offrì una sistemazione provvisoria sul pianerottolo di casa sua, al primo piano di un palazzo della Spiegelgasse.
Mario si trasferì sul pianerottolo, che aveva il pregio di essere riscaldato e nel bel mezzo del quale vennero allestiti due giacigli di fortuna, uno per lui e uno per Petra; nelle settimane successive, pur di risultare gradito all’ospite filantropo, sfoderò fantastiche doti seduttive che non sapeva neppure di possedere. A cena deliziava il dottor Sieglitz e sua moglie con una conversazione immaginifica e brillante, sciorinando dotte dissertazioni su Mozart e Beethoven, Haydn e Schubert, Mendelssohn e soprattutto Brahms, naturalmente. In realtà, esclusi gli intermezzi culinari, i Sieglitz non avevano il piacere di vedere molto spesso lo strano personaggio che avevano salvato da morte certa per inedia. Finito di mangiare, infatti, il signor Mario Schatten non voleva essere disturbato: scambiava con i coniugi qualche rapido commento sulle condizioni atmosferiche e sulle ultime notizie dal mondo, dopodiché preferiva rifugiarsi dietro il tramezzo del pianerottolo, accanto a quella splendida bambina bionda e lentigginosa che non apriva mai bocca, tanto da lasciar quasi sospettare che fosse muta, e lavorare alle sue nuove composizioni, delle quali si rifiutava di offrire qualche saggio al pianoforte che troneggiava nel confortevole salotto di casa Sieglitz. Quando la pazienza quasi infinita dei suoi benefattori si esaurì e si vide costretto a tornare con Petra nella casetta di Mödling, Mario si buscò una polmonite. In ospedale venne considerato ormai moribondo, tanto che gli fu impartita l’estrema unzione: ma miracolosamente, a dispetto della gravità delle sue condizioni, si salvò.
Un anno dopo, nell’estate del 1942, era ancora vivo. Aveva patito privazioni e oltraggi, ma il suo orgoglio non era ancora vinto. Era più che mai deciso a non arrendersi. Nulla poteva domarlo. “L’onta esiste per gli imbecilli che l’accettano. La sconfitta esiste per i vili che la riconoscono” – sentenziò in una delle numerose lettere non spedite, indirizzate alla moglie defunta e raccolte nel dossier dell’SD, che ho utilizzato senza risparmio per ricavare buona parte delle informazioni su questo oscuro periodo della sua vita. Aveva lavorato duramente per anni, scriveva, peggio di un forzato o di uno schiavo, e si trovava con un pugno di mosche in mano. Eppure, con infaticabile perseveranza, continuava a lottare a dispetto di tutto – della solitudine, della povertà, della fame, della mostruosa dittatura che gli impediva di lavorare e di vivere. SI OMNES, EGO NON: ecco il suo motto. Continuava a scrivere i suoi brani rivoluzionari in anticipo sui tempi e a sperare di ottenere prima o poi l’attenzione di un serio editore musicale, perché in genere l’insuccesso si attribuiva all’ubriachezza o all’ozio, e lui non voleva che gli si imputassero dei vizi nei quali non era ancora caduto.
Di fatto, però, oltre a Petra non aveva un’anima con cui parlare, non aveva più un soldo e da quasi un anno indossava la stessa vecchia e frusta giacca da sera di velluto grigio, un modello di neutra modestia ormai ridotto a un sudicio straccio informe. Aveva persino consumato le suole delle scarpe, e portava un paio di pantofole scalcagnate. Le spesse lenti dei suoi occhiali si erano incrinate, e la sua bocca aveva assunto una piega ancora più amara. Cominciava a pensare che non avrebbe mai coronato il sogno della sua vita, ovvero fare ciò per cui era nato: scrivere musica diciotto ore al giorno, libero da ogni condizionamento materiale e dall’asfissiante necessità di guadagnare denaro. Era incredibilmente stanco della vita – della sua, almeno: ormai ridotta a una monotona, triste, frustrante sequela di giorni insignificanti e sterili. A parte la giacca di velluto e un paio di pantaloni, possedeva solo una spugna, una borsa di pelle di cinghiale, lo spazzolino da denti, un rasoio, qualche foglio di carta da musica e una matita spuntata. Da un’eternità non portava più calzini né biancheria intima. La testa gli pesava come il piombo, e la sua mente era un marciapiede affollato, percorso da processioni interminabili di idee confuse. Chiedere di essere ricoverato in un asilo per senzatetto avrebbe significato accettare la carità e separarsi da Petra, il che era da escludersi. Per combattere l’umido gelo notturno che imperava nella casetta priva di riscaldamento dormiva avvoltolato in un impermeabile di tela cerata, stringendo Petra al petto, la testa posata sulla borsa di cinghiale. Ogni tanto cercava di scrivere uno di quei pezzi per violoncello solo che costituivano i suoi cavalli di battaglia, anche se a causa del forte esaurimento nervoso aveva gli occhi oscurati da una nebbiucola grigiastra. Quando finalmente riuscì a comporne uno di suo gusto, però, la notte una lampada gli cadde su una porzione dello spartito, mentre l’altra se la portò via un improvviso colpo di vento che spalancò la finestra con una folata dispettosa.
Anche la musica, sua fedele compagna, lo stava abbandonando: era sparsa per il mondo, chiusa nei cassetti degli innumerevoli editori che avevano rifiutato di pubblicare i suoi spartiti. Doveva rassegnarsi all’idea che ciò che aveva da vendere non aveva prezzo sul mercato. E che le sue composizioni così originali, elaborate, eleganti e squisite, dallo stile brillante come gli inchiostri che tanti anni prima aveva adoperato per scriverle, non gli avrebbero mai fatto guadagnare un centesimo, non gli avrebbero mai dato nessuna sicurezza. Ma, soprattutto, doveva accettare il fatto che non sarebbe mai stata resa giustizia al talento incompreso del disgraziato autore. E che il mondo per lui sarebbe stato sempre un luogo di tenebra, privo di felicità, pieno di sofferenza, prossimo al dolore, lontano dalla beatitudine. La mattina del 25 ottobre 1943 si risvegliò all’alba, l’archetto del violoncello stretto fra le dita, il cuore che pulsava all’impazzata – un martello, un maglio che sferragliava sullo sterno. La pioggia crepitava sui vetri, una tiepida bruma sbocciava nelle tenebre. Andò in bagno, afferrò il rasoio e lo portò alla gola. Petra gli si avvicinò, gli sorrise e prese la mano armata di rasoio con la sua, così piccola e fragile. L’ultimo legame che lo teneva aggrappato alla vita, pensò Mario, non si era ancora spezzato. Lasciò cadere il rasoio nel lavandino. Un attimo dopo qualcuno bussò alla porta. Come un sonnambulo, andò ad aprire: riconobbe a stento Karl Forster, un bravo pianista che era stato suo compagno di tanti anni prima ai corsi di musicologia di Guido Adler. All’inizio, però, non seppe cosa rispondergli quando Forster gli propose di unirsi a lui e a due giovani violinisti, inesperti e non molto conosciuti, per suonare un popolare repertorio mozartiano nei café dei grandi alberghi di Vienna.
b.
Già pochi giorni dopo il rapimento, la salute e lo stato psichico di Mario Schatten ebbero un crollo verticale. Rinchiuso in un appartamento senza finestre al piano interrato del palazzo di Wilhelmstrasse 102, sorvegliato giorno e notte da ufficiali delle SS armati fino ai denti, cominciò ad accusare attacchi di nausea e vertigini, a udire strani sibili, a collezionare capogiri e svenimenti. Immerso in un torpore catatonico, trascorreva intere giornate in uno stato di completa abulia, sonnecchiando come un coccodrillo nel fango del Nilo; poi tutte le sere, verso le dieci, si riscuoteva dal suo stato sonnambolico, faceva chiamare Egon Sommer dalla sentinella delle SS e scambiava quattro chiacchiere col suo gentile carceriere, che gli raccontava gli avvenimenti di giornata e gli ultimi pettegolezzi berlinesi riportati dai colleghi. A peggiorare lo stato depressivo di Mario contribuiva senz’altro la bruttezza irredimibile dell’appartamento in cui era di fatto tenuto prigioniero: curiosamente arredato nello stile di uno chalet di montagna, era corredato di rozzi sgabelli di legno, un camino che però non funzionava, pesanti sedie coi braccioli e sgraziati armadi in legno di quercia. Dopo l’ennesimo capogiro, Sommer – che non era ancora riuscito a cominciare neppure l’addestramento preliminare di Mario, schedato nei fascicoli dell’SD con la sigla “sosia B” – si decise a convocare d’urgenza Theodor Morell, il medico personale del Führer. Non gli spiegò chi fosse quello strano paziente e non si premurò di appurare se Morell si fosse accorto della singolare somiglianza tra il detenuto e la suprema autorità del Reich; gli disse però che quell’uomo era necessario a un progetto che stava molto a cuore al Reichsleiter Martin Bormann e fece promettere a Morell che non avrebbe parlato con nessuno di quella sua attività al servizio dell’SD, nemmeno con Hitler in persona.
Stupito e perplesso, ma anche un po’ intimorito dal nome del temutissimo Bormann, che peraltro era da anni un suo affezionato cliente, all’inizio di novembre del 1944 Morell si recò controvoglia in Wilhelmstrasse per incontrare Sommer. Due ore dopo venne introdotto alla presenza di un individuo pallido come un fantasma, riverso su un letto in mezzo a un mucchio di lenzuola spiegazzate, che gli apparve molto confuso, agitato e debole. Iniziò a visitarlo: il polso era normale, ma c’era un forte tremito alle mani. I riflessi pupillari erano buoni, i movimenti oculari inalterati. La lingua però era coperta da una patina giallastra. Il fegato sembrava ingrossato. Morell gli iniettò per endovena due o tre di quei cocktail medicinali di sua invenzione che lo avevano reso tristemente celebre alla corte di Hitler, tanto che gli altri medici del Führer lo avevano più volte accusato di star cercando di avvelenare l’illustre paziente. Cominciò col Vitamultin-Calcium, una miscela di vitamina B1, acido ascorbico, calcio e nicotinamide, con dosaggi piuttosto bassi – fiale da 2 cc – per evitare reazioni i...