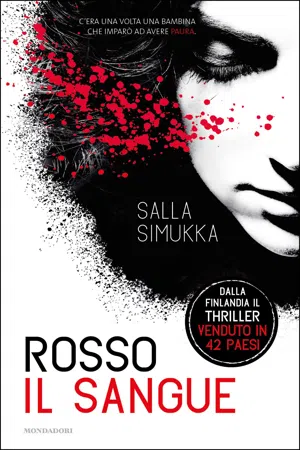![]()
![]()
L’orologio segnava le tre e quarantacinque. Notte fonda.
Boris Sokolov guardò il cellulare come se fosse uno scarafaggio troppo cresciuto, e fu tentato di sbatterlo contro la parete. Lo avevano svegliato nel mezzo del sonno. Gli avevano mentito. Lo avevano minacciato. Poteva anche sopportare di essere svegliato, e le menzogne più che altro lo disgustavano, ma se c’era una cosa che odiava era che qualcuno lo minacciasse. Soprattutto se a provarci era un uomo che non avrebbe dovuto permettersi di farlo neppure per scherzo.
Cambiò la scheda SIM del cellulare e compose il numero.
L’estone rispose al terzo squillo. Dalla voce si capiva che la telefonata lo aveva svegliato. Le parole impastate sembravano venire da lontano, anche se abitava a un paio di chilometri di distanza.
— Sì?
Sokolov parlò in russo: — Ha chiamato. Dice che i soldi non sono arrivati.
— Ma di che va farneticando? — replicò l’estone stupito. — Gli abbiamo fatto pure la consegna a domicilio, una volta tanto.
Boris si alzò in piedi e si avvicinò alla finestra della camera. Il parquet era freddo. “Avrei dovuto farci mettere la moquette. Chi se ne frega se si sporca, potevo cambiarla ogni due anni” si lamentò tra sé. La luna splendeva luminosa, fastidiosamente luminosa. Il cortile era attraversato da due scie di impronte di lepre che si incrociavano. Quanto alle altre tracce sulla neve, le aveva cancellate con l’aiuto degli estoni, battendo tutto il percorso fino all’estremità del cortile sul retro: avevano rimosso scrupolosamente tutta la neve che non fosse immacolata.
— Ha detto che è stato di guardia per l’intera notte. Stanotte.
— Ma che diavolo dice? L’avevamo avvisato che i tempi erano gli stessi ma in un posto diverso.
L’estone cominciava a svegliarsi del tutto.
— Ha parlato di un equivoco. Che ieri era l’ultimo giorno del mese, perché quest’anno è bisestile — grugnì Boris.
Tamburellava con le dita sul davanzale della finestra, pensando: “Le lepri! Non saranno mica andate a rosicchiare l’albero di mele? Dovrei metterci una specie di rete protettiva, sulle radici. Oppure, devo appostarmi una notte e procurarmi un paio di arrosti di lepre da conservare nel congelatore. Stavolta il mio, però, di congelatore.”
— Sì, infatti. Ma la consegna era il ventotto, e il ventotto è il ventotto, mica diventa ventinove perché un anno è bisestile. E poi perché è rimasto di guardia stanotte, quando la grana è già stata consegnata ieri?
— Appunto. Secondo lui non è stata consegnata. Dice che non ha visto niente. Nada.
L’estone restò in silenzio per un istante. Boris attese, per vedere se sarebbe arrivato alle sue stesse conclusioni.
— Vuole fotterci. I soldi li ha presi, ha visto com’erano e ha mangiato la foglia. E adesso cerca di giocare sporco.
Sì, le stesse conclusioni.
— Quel figlio di puttana mi ha minacciato. Ha detto che vuota il sacco.
A quelle parole, Boris sentì di nuovo montare la rabbia. Strinse forte il cellulare. Forse immaginando di stritolare nel pugno la corazza chitinosa di una blatta.
— Non farà proprio niente, cazzo!
L’estone andò su tutte le furie. Bene. Erano decisamente dalla stessa parte. Due traditori, nel giro delle ultime trentotto ore, bastavano e avanzavano. Anzi, erano troppi. Due di troppo. Un congegno funzionante come la sua organizzazione non sopportava l’eliminazione in contemporanea di più componenti senza disporre dei pezzi di ricambio.
— Non lo farà. Ce ne occuperemo noi.
Boris scandì le parole con un certo godimento. Nessuno poteva minacciarlo e restare impunito. Nessuno poteva tentare di fregarlo e cavarsela per il rotto della cuffia.
Credeva che, come avvertimento, sarebbe bastata una busta piena di banconote insanguinate.
Invece a quanto pareva non era stata sufficiente.
Ebbene, anche loro sapevano fare i duri. La differenza era che loro avrebbero avuto la meglio.
Terho Väisänen sapeva che quella notte non si sarebbe più riaddormentato. Era steso su un solo lato del letto matrimoniale, anche se volendo avrebbe potuto occuparlo tutto. Aveva la sensazione che qualcuno ne avesse rosicchiato l’intelaiatura, e che lui sarebbe crollato sul pavimento da un momento all’altro; poi avrebbe ceduto anche il pavimento. Qualcosa si stava sgretolando, qualcosa che credeva eterno.
Terho Väisänen non poteva dire di essere fiero di sé. C’erano mattine in cui gli era difficile guardarsi allo specchio, ma di solito quella sensazione si stemperava al più tardi quando arrivava al lavoro e si ricordava di quante buone azioni era riuscito a fare negli ultimi dieci anni. Quante operazioni erano state portate a termine con successo solo grazie a lui. Sia pure pagandone il prezzo.
Si tirò la coperta fino al mento e annusò il profumo del copripiumone pulito. Avrebbe voluto abbracciare qualcuno, stringere a sé un corpo caldo.
Tentò di telefonare ancora una volta. Il cellulare continuava a squillare, ma non rispondeva nessuno. Terho sentì una paura indefinita annidarsi nella zona accanto al diaframma. Fu assalito dal presentimento che, dopo quella notte, niente sarebbe stato più come prima.
![]()
C’era una volta una notte che non aveva mai fine. Divorava il sole con le sue tenebre, strangolava la luce e allungava i neri e freddi tentacoli sul mondo. Incollava per sempre le palpebre agli esseri umani, rendeva il sonno più profondo e i sogni più bizzarri, faceva sì che, nell’oblio, scivolassero fianco a fianco con le creature oniriche prodotte dalla loro mente, dimentichi del passato. La notte dipingeva sui muri delle case le immagini più spaventose, prive di colori, alitava sui volti degli uomini immersi nel sonno un’aria fredda, asfissiante, che penetrava nei polmoni e li anneriva.
Lumikki inspirò avidamente e aprì gli occhi. Era madida di sudore, e il peso delle coperte le serrava la gola. Doveva liberarsi del piumone e alzarsi. Infilarsi le pantofole, andare alla finestra e affacciarsi sul parco: vederlo avrebbe smorzato l’angoscia opprimente del suo incubo in una vaga, incerta sensazione di vuoto. La luna illuminava la neve, le altalene, le attrezzature per arrampicata del parco e i tetti delle case, rivestendoli di una patina argentea. Le ombre si stagliavano immobili come sagome dipinte con una vernice nera sulla distesa bianca.
Le finestre di due appartamenti erano illuminate. Qualcun altro era sveglio quella notte. Era assurdo essere svegli alle tre e quarantacinque, contrario alla natura umana. A quell’ora in giro vagano solo le immagini che prendono forma dagli incubi, chi è sveglio non le distingue dalle ombre. Nella parte inferiore della finestra, appena al di sopra della cornice, Lumikki vide un ricamo di fiorellini di cristallo. Toccò istintivamente il vetro, pur sapendo che i cristalli erano all’esterno, e che il calore della sua mano non li avrebbe sciolti. Il gelo soffiava sulle sue dita da una fessura della finestra. Ritrasse la mano con un brivido.
C’era stato un tempo in cui si svegliava la notte sperando che non finisse mai, che il giorno non arrivasse. Anche allora aveva sognato di una notte infinita, ma si trattava di un desiderio. Stavolta era un incubo. Erano cambiate tante cose. Un tempo il risveglio mattutino segnava la delusione di doversi alzare e affrontare una giornata che non aveva in serbo nulla di buono per lei. Lumikki sapeva che sarebbe stata aggredita dal male, più di quanto una persona normale potesse sopportare. Eppure lei l’aveva sopportato, per anni. Forse era stata anormale, proprio come sostenevano gli altri.
Lumikki tornò a letto, tra le lenzuola ancora calde. La stanchezza le appesantiva le palpebre. Per il resto della notte dormì senza brutti sogni. Non sognò affatto, o quantomeno si abbandonò a quei sogni che al mattino non si ricordano più.
Quando si svegliò, il sole splendeva. Erano le dieci. Si sentiva stranamente riposata e attiva. Magari era così che le persone dovevano sentirsi al mattino, non degli zombie morti e resuscitati più volte. Non le era mai piaciuto saltare la scuola, ma quel giorno era sicuramente una buona idea. Non aveva nessuna voglia di rivedere la faccia spocchiosa di Tuukka.
Stese braccia e gambe sul materasso. “Cosa faccio oggi? Forse vado in palestra.” Per Natale zia Kaisa le aveva regalato un abbonamento annuale a una palestra. Non che si sentisse propriamente a suo agio tra le ragazze briose e scattanti che la frequentavano, ma sudare le faceva bene e aveva bisogno di mettere su un po’ di muscoli. Tuukka era riuscito a coglierla di sorpresa e in quei momenti l’aveva tenuta in pugno. Invece, se lei avesse potuto fare affidamento sulla sua forza muscolare, non avrebbe avuto difficoltà a divincolarsi dalla presa del ragazzo e a lasciargli anche il bel ricordino di un’abrasione alla guancia da contatto con la pietra fredda del muro.
Non usare la forza per vendicarti, usala per evitare di trovarti in situazioni che possano ispirarti sete di vendetta. Come suonava nobile! In realtà non voleva dire nient’altro se non che Lumikki non aveva più intenzione di soccombere, mai più.
Non voleva pensare al giorno prima. Si sarebbe concentrata su quella giornata tutta per sé.
Di tanto in tanto la madre e la zia chiacchieravano di quanto fosse importante per una donna dedicare qualche ora a se stessa. Il che voleva dire fare shopping, mangiare cioccolato, immergersi nella vasca piena di spuma, leggere riviste femminili e laccarsi le unghie. Lumikki rabbrividì. Per lei una giornata di quel tipo non sarebbe stata altro che una finzione imbarazzante.
Dedicare del tempo a se stessa voleva dire invece fumetti, liquirizia salata, un’attività sportiva che facesse sudare, curry vegetariano e soprattutto solitudine. La madre si chiedeva come facesse la figlia ad amare tanto la solitudine: «Come fai a non annoiarti mai?» Lumikki aveva rinunciato a spiegarle che per lei era più facile annoiarsi in compagnia, ascoltando le banalità degli altri. Meglio soli che mal accompagnati. Quando era sola, poteva essere pienamente se stessa. Libera. Nessuno pretendeva nulla. Nessuno parlava quando lei desiderava il silenzio. Nessuno la toccava se lei non voleva.
Le piacevano anche le mostre d’arte. Dedicava molte ore a visitarle, si caricava un bel po’ di canzoni sul cellulare, preferibilmente dei Massive Attack, e ci andava senza preconcetti, evitando di informarsi troppo sull’artista o sul tema della mostra. Dopo aver pagato il biglietto d’ingresso, entrava nella prima sala con lo sguardo fisso a terra, metteva le cuffie, accendeva la musica e chiudeva gli occhi. Svuotava completamente la mente e la riempiva di musica. Si concentrava, respirava a ritmo pacato e regolare e rallentava la frequenza cardiaca fin quasi allo stato del sonno. Quando era riuscita a far scomparire la realtà banale che la circondava, apriva gli occhi e si immergeva nel primo dipinto.
A volte, mentre era a una mostra, perdeva la cognizione del tempo. Le immagini, i colori, le atmosfere, l’illusione del movimento sulla tela, sulla carta o sulla pellicola fotografica, il senso della profondità, l’irregolarità della superficie e la trama del tessuto la trascinavano nei meandri di un mondo che non conosceva appieno né arrivava a comprendere, ma che tuttavia le apparteneva. Era il suo lago e il suo bosco, il paesaggio della sua anima. L’arte figurativa le parlava in un idioma che si fondeva con la musica e formava sentieri che conducevano alla luce o alla tenebra. Raramente Lumikki dava importanza ai soggetti dei dipinti: non faceva differenza ciò che i quadri mostravano, né che mostrassero qualcosa. Non contava che l’atmosfera.
Le succedeva di rado di uscire da una mostra senza averne trattenuto qualcosa. A volte effettivamente capitava, ma in quei casi il motivo era un fattore esterno, come la fame, la stanchezza o lo stress. O gli altri visitatori della mostra, troppo rumorosi, che con le loro voci avevano insidiato la musica che avrebbe dovuto coprirli. Alcune esposizioni erano come uragani: la lasciavano senza fiato e con le gambe deboli. Altre le trasmettevano una duratura riserva di calore. Altre ancora si tramutavano in una melodia che le restava in mente. I colori si imprimevano sulla retina e arricchivano i sogni di nuove sfumature. Dopo ogni mostra, comunque, Lumikki non era più la stessa.
Quel giorno tuttavia non si sarebbe dedicata all’arte: aveva già visitato le esposizioni in corso al Museo d’Arte di Tampere, al museo intitolato a Sara Hildén e alla Galleria TR1. Cercava sempre di andarci presto, anche se non nelle primissime settimane; quando cioè i più entusiasti sono ormai esauriti e i ritardatari non si sono ancora decisi.
I fiori disegnati dal ghiaccio sfavillarono al pungente tocco del sole. “Magari potrei fare un po’ di jogging prima di colazione.” Guardò il termometro: meno venticinque gradi. No, grazie. A quelle temperature il respiro non ci mette niente a diventare affannoso.
All’improvviso suonò il cellulare. Lo prese. Un numero sconosciuto.
Non rispondere alle telefonate di numeri che non conosci. Mai. Un principio che aveva adottato in passato e poi trascurato. Ora però, visto che viveva da sola e doveva gestirsi le proprie cose, bisognava rispondere per forza.
— Lumikki Andersson — pronunciò in tono formale.
— Ciao, sono Elisa.
Elisa? Perché le telefonava?
— Tuukka mi ha detto che sai tutto — si affrettò a spiegare la ragazza.
Lumikki sospirò. Adesso doveva promettere anche a Elisa che non avrebbe spifferato nulla di sua iniziativa?
— Non sapevo a chi telefonare. I ragazzi non vogliono parlarne. Io sono distrutta. Devi venire qui, non ce la faccio a star sola. Ho paura. Aiutami!
La sua voce aveva un tono acuto, a...