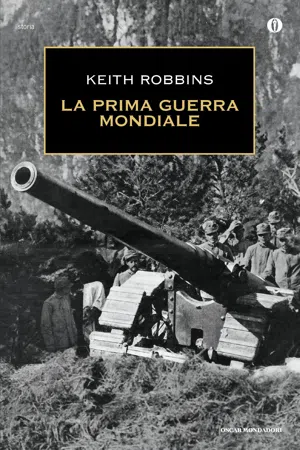![]()
![]()
Scopo di questo libro – certo non il primo sulla «Grande guerra», ma forse uno dei più brevi e di più ampia angolatura – è quello di fornire un chiaro resoconto delle principali operazioni militari e insieme di lumeggiare molti aspetti del conflitto. Pur non pretendendo di esaurire la vasta materia, il volume mira ad avvicinare il lettore ad alcuni dei problemi sociali, psicologici e politici degli anni 1914-1918, problemi affrontati con particolare insistenza dalla recente storiografia. Il numero delle opere sulla Prima guerra mondiale è enorme e non accenna a fermarsi. L’autore ha attinto largamente a questo prezioso patrimonio e desidera riconoscere il proprio debito verso tutti gli studiosi i cui scritti sono citati nella bibliografia, anche se gli è impossibile esprimere precisi ringraziamenti; unico responsabile delle affermazioni e dei pregiudizi contenuti nel testo finale, l’autore ringrazia inoltre i colleghi D.R. Gillard e E. Mawdsley per gli utili commenti alla prima stesura e Pat Ferguson per l’esemplare lavoro dattilografico.
K.R.
![]()
Nell’estate 1914 molti uomini di cultura europei reputarono che era giusto, date le circostanze, partecipare alla guerra. Si respirava un’atmosfera di grande eccitazione, perfino di esultanza. La guerra era finalmente arrivata e il momento doveva essere assaporato fino in fondo. Freud dichiarò di sentirsi austriaco per la prima volta in trent’anni e di essere pronto a concedere all’Impero asburgico una nuova chance e la possibilità di diventare il centro di tutte le sue emozioni. Ignotus, uno scrittore ungherese, riconobbe che la guerra andava fatta: «Altrimenti,» aveva aggiunto «saremmo finiti come la Turchia» – la peggiore delle sorti immaginabili nei salotti intellettuali di Vienna o di Budapest. Lo scrittore ceco Hašek annotò divertito che un ufficiale tedesco aveva imposto all’amante di ricamare sulle giarrettiere il motto «Dio stramaledica l’Inghilterra». Più tardi, naturalmente, l’eroe del suo romanzo, il buon soldato Svejk, adottò un atteggiamento molto meno entusiasta verso il conflitto. I poeti austriaci esultarono al pensiero che ogni colpo tedesco contribuisse a instaurare «sulla terra l’aureo impero» dell’umanità: quali che fossero le loro astratte convinzioni politiche, erano certi che con sangue freddo e acciaio rovente si stesse compiendo una «meravigliosa opera umana». Molto di questo zelo guerresco nasceva da uno spirito che in seguito si manifestò più veracemente nell’alacre ricerca di un poco eroico rifugio nelle stanze dei ministeri; ma non sempre andò così. E vi fu qualcuno, come Kafka, che non poté in alcun modo evitare di venir destinato al servizio sedentario in una compagnia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Un entusiasmo di tale natura può essere facilmente spiegato dalla peculiare situazione dell’Impero asburgico. Vienna, la capitale, era una città brillante ma turbolenta, ossessionata da cupi presentimenti di disastro, magistralmente riassunti dallo scrittore Karl Kraus nel titolo del libro Die letzten Tage der Menschheit (Gli ultimi giorni dell’umanità). L’immigrazione dalle diverse zone dell’impero aveva prodotto nuove tensioni sociali ed esacerbato quelle esistenti. Era estremamente difficile mettere in moto un governo parlamentare, nonché abbastanza scarsa la propensione a tentare il gran passo. Cechi e slovacchi, polacchi e ucraini, croati e serbi appartenevano tutti a quelle «nazionalità oppresse» che miravano combattivamente alla conquista di concrete soddisfazioni e di uno status. Grazie al compromesso costituzionale del 1867 i magiari avevano ottenuto da quell’anno il controllo interno in Ungheria; ma nonostante ciò, la frizione fra Vienna e Budapest era endemica e non senza ripercussioni sulla condotta della politica estera. L’avvenire di questi domini asburgici, messi insieme nei secoli in virtù di matrimoni, acquisti e conquiste, era argomento di infinite diatribe ai tavolini da caffè, ma l’imminente fine della monarchia non deve far credere che il trono fosse in realtà sul punto di crollare: gli Asburgo, come dinastia, stavano lì per essere criticati, non sostituiti. Visto in complesso, l’impero appariva un intricato mosaico di sviluppo industriale e di arretratezza agricola, dove i contrasti tra le regioni erano enormi. Il ritornello «Meglio una fine senza paura che paure senza fine» stava diventando più che un cliché, soprattutto nei circoli militari. L’esercito confidava di avere il futuro nelle proprie mani, pretendendo a buon diritto di costituire l’unica incarnazione di uno stato che non poteva fondare la raison d’être su una coscienza nazionale. La molteplicità delle lingue e le suscettibilità da esse generate complicavano spesso l’organizzazione e l’addestramento delle truppe, ma gli alti ufficiali erano in grado di superare le molte difficoltà con un’indubbia abilità linguistica. Conrad von Hötzendorf, il capo di Stato maggiore, sosteneva di saper parlare correntemente sette lingue – anche se forse in un ristretto campo di conversazione; di solito, comunque, preferiva discutere in tedesco, come faceva con l’erede al trono, il quale recalcitrava al suggerimento di sottrarre i flautisti alle bande militari per trasformarli in fucilieri.
Secondo Conrad un nutrito corpo di fucilieri avrebbe potuto essere utile sia contro l’Italia che contro la Serbia, i due stati indipendenti – verso sud – che mal celavano l’aspirazione a liberare le minoranze nazionali rimaste inglobate entro i confini dell’impero. A Vienna la tentazione di atti di forza ricompariva, di tanto in tanto, molto acuta, benché si riconoscesse che i rischi erano grandi. Una dimostrazione di determinatezza era già stata data nel 1908 con la formale annessione della Bosnia-Erzegovina, un territorio che rappresentava un sorta di microcosmo dell’impero, intessuto di popolazioni, culture e religioni varie. Un gesto così perentorio era sembrato dimostrare che Vienna non intendeva cedere alle smanie di quanti sognavano di includere tutti i serbi in uno stato serbo, né agli analoghi aneliti di qualsiasi altra nazionalità: e forse indicava anche che erano altrettanto irrealizzabili i disegni di un profondo cambiamento costituzionale sotto l’egida della «vecchia» monarchia, quantunque il reazionario arciduca Francesco Ferdinando amasse trastullarsi con progetti di questo genere, al chiaro scopo di accattivarsi il favore dei liberali.
Fu proprio in Bosnia che alla fine del giugno 1914 Francesco Ferdinando si recò in visita con la moglie morganatica, forse anche spinto dal desiderio di farle assaporare quel tipo di prestigio di cui solo in periferia le era possibile godere. Voleva il caso, però, che il 28 giugno ricorresse l’anniversario della distruzione dell’esercito serbo da parte degli ottomani, una disfatta risalente al 1389, e che di conseguenza quello fosse un giorno di lutto nazionale. La concomitanza si rivelò insopportabile per uno studente bosniaco, Gavrilo Princip, che tra l’orrore della folla colpì a morte gli illustri ospiti. L’associazione Mlada Bosnia (Giovane Bosnia), della quale Princip era membro, non dubitò che l’assassinio di Francesco Ferdinando costituisse un «tirannicidio per il bene comune». Le migliori tradizioni del pensiero europeo venivano allora distillate nelle scuole superiori del paese, dove si mescolavano con un più primordiale desiderio di sangue. Il pericolo che l’omicidio avrebbe potuto avere più ampie implicazioni per l’Europa non meritò alcuna considerazione; sebbene gli attivisti non avessero un’unità d’intenti e potessero perfino venire accusati di atteggiamento nichilistico verso i lavoratori, nel tirannicidio era insita una «bellezza» che ai loro occhi ne era la giustificazione: essi, in fondo, erano soltanto gli ultimi di una lunga serie di combattenti contro l’oppressione straniera.
Era naturale, tuttavia, che la reazione di quasi tutte le capitali europee fosse quella di ritenere il governo serbo in certo modo responsabile dell’accaduto. Indipendente di fatto dal quarto decennio dell’Ottocento, in quel breve tempo la Serbia aveva visto lo sviluppo interno intralciato da spettacolari e sanguinosi contrasti tra gli aspiranti al trono. L’ardore marziale della popolazione, dispiegato nelle guerre balcaniche appena concluse, era indubbio, ma alquanto primitivo: non sarebbe stato difficile definire il piccolo stato come un reame contadino, come un’arretrata appendice dell’Europa incivilita. Anche se, forse, non si potrà mai conoscere l’intera verità, dal momento che esistono cruciali discrepanze nelle prove, è sommamente improbabile che il governo serbo fosse il diretto istigatore degli assassinii; piuttosto, a quanto pare, esso era a conoscenza della possibilità di un tentativo in tal senso e cercò, almeno per vie traverse, di far pervenire l’informazione a Vienna. Ma gli ingranaggi da muovere erano intricati, e all’interno dei circoli politici e militari della Serbia imperversavano feroci dissidi e rivalità. S’ignora quanto fossero estese le ramificazioni della «Mano nera», una società segreta che era sorta nel 1911 e che promuoveva attività rivoluzionarie in tutti i territori abitati da serbi, nella convinzione che il governo Pašić non si occupasse con sufficiente zelo del destino dei connazionali sottoposti al giogo straniero; è chiaro però che contatti e connivenze dovevano avere permeato profondamente esercito ed amministrazione, essendo poi risultate coperte con molta cura le tracce che avrebbero potuto rivelare il preciso intento di Princip e la provenienza degli eventuali fiancheggiatori.
All’improvviso, comunque, il vecchio imperatore Francesco Giuseppe divenne oggetto di vaste simpatie per la morte di un nipote assai poco amato. Anche nelle capitali dell’Europa occidentale le usuali lamentele per le pene sofferte dalle nazioni minori passarono in secondo piano di fronte alla sfida all’ordine costituito che l’omicidio rappresentava. Il governo serbo, se non la stampa locale, tentò di prendere le distanze dall’assassinio e dalla «Mano nera», ben consapevole che nella morte degli arciduchi gli impetuosi circoli di Vienna potevano facilmente trovare un’ottima occasione per un «regolamento di conti». Nella capitale austriaca, in effetti, i sentimenti bellicosi non difettavano, nonostante la grande incertezza sia circa il tipo di spedizione militare da preparare contro la Serbia, sia circa lo scopo ultimo della manovra. Guardando in retrospettiva, appare evidente che il resto dell’Europa avrebbe tollerato un’immediata ritorsione di Vienna, tuttavia una risposta rapida non era connaturata all’ambiente austriaco. Sagge voci dichiararono subito poco fondata la tesi di una diretta implicazione del governo serbo: bisognava prima indagare su quell’aspetto, di modo che se si fosse raggiunta la prova di una complicità il governo austriaco si sarebbe trovato nella solida posizione di poter agire con il consenso internazionale. Passarono così molti giorni senza che si arrivasse a una risoluzione. In teoria il controllo della politica estera toccava a Francesco Giuseppe, ma la tarda età di questi non ne rafforzava la prontezza mentale. Il ministro degli Esteri, conte Berchtold, propendeva per un’inchiesta sulle circostanze dell’assassinio, anche se condivideva con Conrad l’impressione che fosse giunto il momento d’intervenire contro la Serbia; invece il Primo ministro ungherese, Tisza, nutriva maggiori perplessità, temendo soprattutto che un successo sulla Serbia avrebbe finito per fare aumentare la pressione di Vienna su Budapest. Non sorprende, di conseguenza, che a questo punto Berchtold considerasse essenziale una consultazione con Berlino.
Germania e Austria-Ungheria erano alleate dal 1879, e nel corso degli anni successivi le questioni balcaniche avevano sistematicamente turbato il loro rapporto, un rapporto che con il passare dei decenni era diventato sempre più difficile gestire. Bismarck era diviso tra la riluttanza al coinvolgimento diretto della Germania e la necessità di aiutare gli austriaci. I suoi successori avevano continuato a considerare la Duplice alleanza assolutamente vitale per la sicurezza tedesca, quantunque in varie occasioni l’Austria-Ungheria sembrasse più di peso che di vantaggio. Gli interessi dei due stati erano quindi strettamente connessi ma, per forza di cose, non identici. Iniziato il ventesimo secolo, la Duplice aveva assunto con maggiore evidenza il carattere di un accordo da cui né l’una né l’altra delle contraenti avrebbe potuto ritirarsi senza gettare nello scompiglio quella rete di intese che tutti ritenevano garantisse l’assetto dell’Europa. Se Vienna non fosse stata sostenuta nei Balcani, l’isolamento austriaco non avrebbe fatto che ampliare l’ambito dell’azione russa in quell’area e condurre infine alla dissoluzione dell’Impero asburgico; nulla, viceversa, doveva alterare la realtà geopolitica dell’Europa centrale e sudorientale.
Era questo, nell’insieme, lo sfondo diplomatico allorché il 5 luglio il Kaiser Guglielmo II e un’eterogenea accolita di consiglieri civili e militari esaminarono la lettera proveniente da Vienna. In seguito alla discussione il Cancelliere imperiale, Bethmann-Hollweg, fu autorizzato a concedere «carta bianca» all’ambasciatore austriaco. Il calcolo prevalente era stato che la Russia non fosse pronta per una guerra e che lo zar non avrebbe voluto dare l’impressione di assolvere un assassinio: da Pietroburgo sarebbero partite parole aspre, ma neppure una sola mossa, mentre se la Germania non avesse sostenuto Vienna, ne sarebbe stato minato il prestigio austriaco, con gravi conseguenze per la stessa Berlino. La promessa di un aiuto all’Austria, al contrario, avrebbe anche potuto portare il beneficio di indebolire l’alleanza franco-russa in quanto Parigi, magari costretta da Londra, avrebbe probabilmente invitato i russi a non intervenire; a questo fine, anzi, sarebbe stato meglio non allarmare inutilmente le altre capitali occidentali. Rassicurato dall’ineccepibile logica, e prevedendo quindi che vi sarebbe stato un periodo di tensione per circa tre settimane e che alla fine tutto si sarebbe risolto bene, Guglielmo II non ritenne opportuno rinunciare al progetto dell’annuale crociera al largo delle coste norvegesi.
In realtà, fu solo dopo quell’intervallo che il nervosismo crebbe notevolmente. Imbarazzata dalla «carta bianca» lasciatale dai tedeschi, Vienna aveva faticato non poco a prendere una decisione. I primi risultati dell’inchiesta sulla complicità del governo serbo non avevano fornito una base d’azione soddisfacente. Tisza, soprattutto, era sempre più allarmato ai discorsi di un annientamento della Serbia: piuttosto che accettare una cosa simile, i russi sarebbero certamente scesi in guerra. Non sarebbe stato più conveniente accontentarsi semplicemente di un netto trionfo diplomatico, imponendo ai serbi una pesante umiliazione a cui essi non avrebbero potuto non piegarsi? E se anche essi non l’avessero accettata subito, avrebbero potuto essere persuasi a farlo con la minaccia di una mobilitazione austriaca. Al governo serbo, in ogni caso, andava inviata una rigida protesta. La stesura del documento prese però tempo, anche perché nessuno sapeva con certezza se lo scopo fosse quello di rendere accettabili o inaccettabili le richieste austriache. Finalmente ci si accordò su dieci punti, ma ad onta di ciò si attese fino al 23 luglio prima di inviare alla Serbia una nota ufficiale, che le concedeva quarantotto ore per una replica alle condizioni dettate da Vienna: tra queste la cessazione di ogni propaganda contro l’Austria-Ungheria, l’arresto di alcune persone e la partecipazione di rappresentanti austriaci alle indagini condotte in luogo. Era trascorso ormai quasi un mese dalla morte di Francesco Ferdinando, e appariva perciò già passato il momento in cui si sarebbe potuta scusare un’impennata austriaca. La replica serba, seppure di tono dignitoso, sembrò accettare quasi tutte le imposizioni, ma fu accompagnata dalla mobilitazione delle forze armate.
Cruciale come sarebbe stata, la reazione russa rimase avvolta nel mistero. Sulla forza dei sentimenti filoserbi diffusi in importanti circoli di Pietroburgo non c’era alcun dubbio. Per decenni la politica russa nei Balcani si era poggiata da un lato sul «panslavismo» che direttamente incoraggiava le idee di ribellione contro il dominio ottomano, e dall’altro sulla testarda convinzione che vi fosse spazio per un ampliamento (non sempre ben visto dai presunti beneficiari) della diretta influenza zarista. D’altro canto Pietroburgo non misconosceva i pericoli di un conflitto che avrebbe potuto mettere in luce i limiti della sua capacità di difendere i putativi protetti. La Russia, quindi, non era per nulla ansiosa di un immediato confronto con l’Impero asburgico, l’unico rivale nell’egemonia sui popoli balcanici, o almeno non lo era stata mentre ancora cercava di risollevarsi dalla sconfitta che all’inizio del secolo le aveva inferto il Giappone; e per questo aveva piegato il capo all’annessione austriaca della Bosnia-Erzegovina – un’accondiscendenza da cui era inevitabilmente derivata la sensazione che il potere di Vienna fosse in ascesa. Non stupisce, così, la generale opinione che il prestigio russo avrebbe nuovamente sofferto se ora non si fosse proposto qualche appoggio alla Serbia. Per molti riguardi l’Impero dei Romanov era lo specchio di quello degli Asburgo: multinazionale, multilingue, straordinariamente vario nello sviluppo economico-sociale. Si ripeteva a Pietroburgo il dilemma austriaco tra azione e inazione: una condotta ferma avrebbe potuto essere catastrofica o, all’opposto, rafforzare la posizione del trono. In questa critica congiuntura le valutazioni estere della forza russa mostrarono grandi disparità; a Berlino, per esempio, Bethmann-Hollweg commentò amaramente che gli sembrava inutile piantare alberi nelle sue terre perché sarebbero stati i russi a goderseli. Un pessimismo del genere, motivato da angosciose ipotesi sulle immense dimensioni territoriali, sulle infinite riserve demografiche e sull’accelerazione del pur caotico sviluppo industriale della Russia, poteva essere molto contagioso. Resta da chiedersi se questi timori di una futura espansione russa possano spiegare o addirittura giustificare la temperie della capitale tedesca. A Pietroburgo, di certo, vi era fiducia sufficiente a rendere possibile una linea dura. Ma l’atteggiamento della Francia avrebbe potuto mutare gli equilibri.
La Francia aveva stretto alleanza con la Russia nel 1894: un accordo che appariva chiaramente dettato dalla geografia e dalla disfatta subita a opera della Prussia nel 1870-71, piuttosto che da una comunanza di sistemi o di valori politici. Poiché la Francia era, anzi, l’unica grande repubblica europea, l’ethos vagamente spiritualista della corte zarista non avrebbe potuto offrire maggior contrasto con lo stridente anticlericalismo che aveva animato i successivi governi francesi. Tuttavia le due potenze continuavano a sentirsi legate da ciò che percepivano costituire un solido interesse comune, tanto che alla metà di luglio, i due più autorevoli politici francesi, il presidente Poincaré e il Primo ministro nonché ministro degli Esteri Viviani, decisero di compiere una breve visita ufficiale a Pietroburgo. In un’atmosfera euforica venne suonata perfino la Marseillaise; e più tardi, quando a un pranzo in onore di Poincaré l’ambasciatore francese si trovò accanto alla moglie del granduca Nicola (comandante in capo e zio dello zar), la nobildonna non esitò a formulare l’allettante congettura che gli eserciti dei due paesi si sarebbero incontrati a Berlino dopo la sconfitta delle forze tedesche. A dare enorme risalto alla profezia fu il particolare che la granduchessa era figlia del re del Montenegro, lo stato balcanico confinante con la Serbia. Anche se non sappiamo di preciso che cosa si dissero, è probabile che Poincaré e Viviani parlassero in tono meno eccitato con lo zar e con il ministro degli Esteri russo, Sazonov; ma non v’è ragione di credere che Poincaré cercasse di sedare gli animi. Come entrambe le potenze convenivano, non ci si poteva aspettare che la Serbia acconsentisse, secondo le pretese della nota di Vienna, a un’esplicita interferenza austriaca nei propri affari interni. La delegazione francese fece quindi ritorno in patria: se si fosse giunti alla guerra, la Francia avrebbe potuto riavere l’Alsazia-Lorena – una prospettiva da cui trassero grande soddisfazione i molti francesi che avevano tenacemente coltivato il rancore per lo scacco sofferto.
I motivi egoistici – o, più semplicemente, la paura dell’espansionismo tedesco – che avevano fatto nascere il patto d’amicizia tra Francia e Russia gli consentirono anche di sopravvivere ad alcuni difficili episodi. Il trattato aveva confermato la comparsa di una nuova competitività nei rapporti tra i grandi stati europei, delineando due fronti: da una parte la Triplice alleanza (in quanto la Duplice si era allargata nel 1882 per l’inclusione dell’Italia) e dall’altra l’Intesa franco-russa. Il campo era rimasto tale per due decenni, anche se di tempo in tempo all’interno di entrambi gli schieramenti si erano manifestate discordie e lacerazioni che minavano la forza ostentata agli occhi del raggruppamento antagonista. Berlino, in particolare, aveva compiuto strenui sforzi per incrinare l’alleanza franco-russa, tentando di convincere un settore dell’opinione francese che sarebbe stato vantaggioso un rapprochement alla Germania; e vi erano state anche occasioni in cui sia Berlino che Pietroburgo avevano preso in seria considerazione l’opportunità di un allineamento russo-tedesco, mentre diveniva meno salda nella Triplice la posizione dell’Italia, che aveva migliorato i rapporti con la Francia. Durante la guerra boera si era addirittura profilata la possibilità che i maggiori stati continentali si decidessero ad accantonare vecchie e recenti divergenze per strappare insieme qualche concessione al potente Impero britannico.
In un tale contesto il ruolo inglese venne ad assumere una sempre maggiore importanza, benché da una prospettiva centroeuropea non fosse facile giudicare quale corso Londra avrebbe seguito. Finora la Gran Bretagna era rimasta estranea, almeno fino a un certo punto, ai sistemi di alleanza rivali: le convenzioni da essa stipulate con la Francia (1904) e con la Russia (1907) avevano riguardato problemi di natura quasi esclusivamente coloniale, ovvero relativi a territori situati oltre i confini dell’Europa – quali l’Egitto e il Marocco a sud e la Persia a est. Le implicazioni di questi accordi per la successiva politica europea sono state argomento di ampie discussioni. Tra Gran Bretagna e Francia si erano indubbiamente svolti scambi di vedute di carattere militare, ma gli inglesi avevano insistito nel voler conservare mano libera. Sebbene nel 1906 e nel 1911 i tedeschi non fossero riusciti a indebolire, sfruttando la questione del Marocco, l’entente anglo-francese e avessero invece sortito il risultato opposto, Parigi e Londra non erano mai arrivate ad una vera cordialità o comprensione, e il governo liberale inglese aveva sempre sottolineato che nell’eventualità di una crisi la propria politica sarebbe dipesa soltanto dalle precise circostanze: alla Francia, insomma, non era mai stata data «carta bianca». L’incertezza di Londra scaturiva in parte dai limiti che imponevano gli impegni globali dell’impero, ma in parte anche dalla natura del sistema politico, incentrato su un governo parlamentare, e del processo decisionale concernente gli affari esteri. Quando affermavano di essere condizionati dall’opinione pubblica (o almeno dalle vedute delle Camere), gli statisti non mentivano: indubbiamente sir Edward Gray poteva permettersi (o si arrogava) una certa libertà nella scelta degli indirizzi, ma la decisione di una guerra avrebbe dovuto ottenere l’approvazione di tutti i membri del gabinetto e far confrontare con l’intero Parlamento il Partito al potere. È chiaro che questo duplice assenso non poteva essere garantito in anticipo.
A parte la crisi balcanica, i rapporti tra Gran Bretagna e Germania erano i più complessi in Europa, quasi a ogni immaginabile livello di contatti e di c...