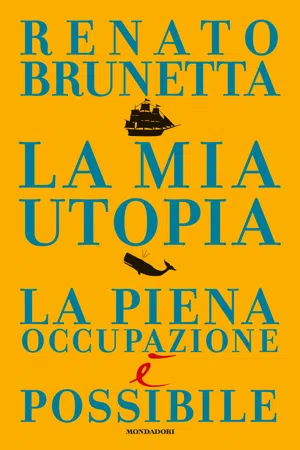![]()
Dove si espone la novità di pensiero di due grandi economisti anglosassoni, Weitzman e Meade, e il modo in cui hanno disegnato le linee di un’Utopia contemporanea basata sulla partecipazione e sul merito, superando di un balzo un sistema economico anchilosato dal patto salariale, che in nome dell’uguaglianza crea miseria e disoccupazione.
![]()
Dove si spiega come e perché è cambiato il capitalismo, come esso non smetta di tirarsi dietro la sua bisaccia di problemi e come fuori dal mercato competitivo non ci sia la possibilità di un’etica, ma solo buio e cenere, dove l’uomo è calpestato.
Di come le questioni fondamentali ancora oggi restino quella del lavoro e del lavoro per tutti insieme a quella della giustizia. E semmai si siano fatte più gravi. Eppure non tutto sia scritto sulle tavole delle presunte bronzee leggi dell’economia.
Lo sviluppo demografico e la centralità della «connessione», un altro modo di chiamare il web, costringono ad affrontare questi temi da un punto di vista diverso da quello del pensiero calcolante.
L’homo œconomicus – se mai ci fu – lascia il campo all’homo innovaticus. Come scrive Edmund Phelps, economista della Columbia University, premio Nobel 2006, «le persone reali non sono solo esseri avidi che cercano di non correre rischi, ma sono anche esseri curiosi e avventurosi, che a volte sentono il bisogno di gettarsi a capofitto nell’ignoto». E ancora «se al centro dell’economia mettiamo l’innovazione, veniamo allora a porre un’affermazione spiazzante circa la natura umana, perché affermiamo, a qualche livello, che l’uomo sia un innovatore.
«Il problema della moralità nell’economia non consiste né nell’equità della distribuzione del reddito né nella stabilità del sistema finanziario. Consiste nel modo in cui le istituzioni umane possano essere conformate alla natura umana – alla natura dell’uomo inteso come innovatore.»
Qui si mostra come proprio questo atteggiamento consenta di avvicinarsi a Utopia dove l’uomo possa insieme lavorare e costruire un mondo buono. Dove siano valorizzati il merito, la conoscenza e la creatività individuale e collettiva. E valorizzare uno non crei disoccupazione e disuguaglianza, ma un bene che cada a pioggia sopra tutti, nessuno escluso…
La crisi finanziaria che, sul piano globale, ha preso formalmente avvio con il fallimento della banca d’affari americana Lehman Brothers nel settembre 2008, ha rappresentato il detonatore di una grave crisi economica.
Quest’ultima, dalla quale il mondo non si è ancor oggi sollevato, ha indotto molti a temere l’innesco di una crisi generale del capitalismo.
Il mondo non sarà più come prima, è stato detto da più parti.
La crisi di panico che dai mercati finanziari si è trasmessa ai mercati reali ha indotto molti a mettere in discussione il mercato, il capitalismo, la globalizzazione, dimenticando, irrazionalmente, che la crisi è arrivata dopo il più lungo periodo di crescita ininterrotta dal dopoguerra.
Ma non è il dibattito sulla crisi e sulle strategie macroeconomiche di uscita dalla recessione globale il tema di questo libro, né esso trae occasione da pulsioni catastrofiste o palingenetiche originate dalla crisi in atto.
Non c’è dubbio, tuttavia, che le crisi sono una grande occasione, non solo per ristrutturare e aggiustare le economie e le istituzioni, bensì anche per soffermarsi a capire il mondo e le sue trasformazioni, che avvengono nel continuo, ma di cui ci accorgiamo nel discreto, per revisionare, rivisitare e reinterpretare idee e teorie, anche non nuove, che in un nuovo contesto possono mostrare aspetti e fecondità non colti prima.
Le crisi petrolifere iniziate a metà degli anni Settanta, causate dall’aumento del prezzo del petrolio che ha seguito il formarsi del cartello dei Paesi produttori, misero in crisi le politiche di regolazione della domanda di impianto keynesiano.
Il periodo di stagflazione che accompagnò quelle crisi fu anche il prodotto di politiche non adeguate perché la teoria economica, almeno quella prevalente, non era sufficientemente attrezzata a fronteggiare le crisi derivanti da shock di offerta e non da shock di domanda.
Lo smarrimento dette luogo ai grandi progressi della moderna macroeconomia che ha posto maggiore attenzione alle condizioni di offerta degli equilibri macroeconomici e ha dato vita alle nuove teorie della crescita endogena.
Allo stesso tempo, la sfida posta dalla contemporanea presenza di inflazione e disoccupazione portò agli sviluppi analitici delle teorie della partecipazione dei lavoratori ai profitti delle imprese, sia nella versione di Weitzman sia in quella, più articolata e complessa, di Meade, entrambe peraltro ancorate all’impianto teorico neoclassico dei mercati competitivi.
In queste teorie si cercava di sciogliere il nodo della rigidità dei salari e quindi l’ostacolo al raggiungimento della piena occupazione.
Ma dagli anni Ottanta il mondo è cambiato. Sono cambiate le tecnologie e sono cambiati i mercati. Vi è stato il processo di globalizzazione prodotto sia dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia dai mutamenti geopolitici.
La crisi attuale riflette gli squilibri economici globali e i mutamenti della geografia economica, e da essi, comprendendone la vera natura, è necessario partire.
Questi mutamenti hanno comportato il trionfo della demografia. Gli equilibri economici sempre più sono potenzialmente dettati dai pesi demografici relativi dei vari Paesi. Nei mercati internazionali si muovono liberamente i capitali e le merci, ma si muovono necessariamente meno le persone, anche se flussi crescenti di lavoratori transnazionali si spostano tra i Paesi, non solo dai Paesi poveri a quelli ricchi. E viene a ridisegnarsi, allora, la mappa dell’espansione economica e della competizione mondiale, nella misura in cui i diversi fattori produttivi vanno incontro alle persone.
Vi è però anche di più. Oggi viaggiano, rapidamente e con facilità, soprattutto i dati, le informazioni, le idee, le intuizioni, le innovazioni. Come ci ha insegnato la moderna teoria della crescita endogena, la conoscenza è un fattore produttivo con rendimenti crescenti, e nell’economia della conoscenza è il fattore fondamentale.
Ma se è la conoscenza il fattore principale di crescita e di competitività delle economie, se il processo stesso di produzione di conoscenza e di innovazione, ancor prima che la sua disseminazione e diffusione, è rivoluzionato dalla nuova internet economy, quella del web 2.0, e se a ciò si aggiunge l’accesso libero al sapere e la sua crescente non escludibilità, ne deriva che è il fattore umano, capace di produrla, assorbirla e gestirla, che torna al centro della scena economica, ed è questo il vero motivo della nuova rilevanza del fattore demografico nel disegnare gli equilibri mondiali.
Le potenze asiatiche emergenti non sono divenute tali orientandosi a costituire la manifattura del mondo, ma utilizzando i primi surplus commerciali, accumulati in quel modo, per affermarsi come una forza trainante dell’innovazione attraverso l’investimento in conoscenza.
Se in una mappa del mondo si indicano con degli istogrammi rispettivamente la concentrazione delle scoperte scientifiche e delle innovazioni, si vede che le prime si concentrano ancora maggiormente nel Nordamerica e in Europa, ma le seconde, che rappresentano l’applicazione della conoscenza, nell’Asia orientale.
È questo il mondo di cui parla il libro, interrogandosi sul modo in cui le relazioni di lavoro ne risultano influenzate, e chiedendosi soprattutto se le forme di remunerazione del contributo del lavoro e del capitale all’attività economica non debbano essere adattate a quello che abbiamo scelto di chiamare «capitalismo 2.0».
Un capitalismo la cui capacità di rimanere lo strumento dinamico di sviluppo dell’umanità è legato al modo in cui esso si adatterà, come è avvenuto attraverso tutte le precedenti rivoluzioni tecnologiche, alle nuove forme di produzione della conoscenza e dell’innovazione, e al modo in cui queste diverranno i motori dei mercati competitivi.
Si è oggi di fronte alle difficoltà della congiuntura e di una crisi che, pur presentando anche aspetti sistemici, non è la crisi del mercato o del capitalismo. È invece una crisi di crescita di entrambi, dovuta in primo luogo all’irrompere contemporaneo di qualche miliardo di persone in più nei giochi di interazione economica planetaria, e di una profonda rivoluzione tecnologica.
In questo contesto si riparla anche di economia della partecipazione, interpretata come partecipazione agli utili delle imprese da parte dei lavoratori, perché vi si ravvisa innanzitutto una corretta risposta a un problema immediato: quello di affrontare i mercati internazionali post-crisi con una maggiore flessibilità salariale riuscendo, al tempo stesso, a trovare le vie più percorribili per articolare più equamente la pressione fiscale sui redditi dei lavoratori.
Questa è tuttavia solo una parte del problema, e forse non la più importante. Perché una discussione sul salario, cioè sulla remunerazione del lavoro, deve partire oggi da una riflessione sul mercato e sul capitalismo.
In questa riflessione, il punto da cui dobbiamo prendere le mosse è quello offertoci da un breve ma fondamentale saggio di Edmund Phelps, economista della Columbia University, premio Nobel 2006, che si intitola Economic Justice and the Spirit of Innovation (2009).
Ragionando di moralità del mercato, Phelps osserva che «nel dibattito vi è chi presuppone l’esistenza di un homo œconomicus orientato a massimizzare i propri consumi e assumere rischi minimi. Queste stesse voci presuppongono anche che l’economia in cui ha luogo tale massimizzazione sia un sistema di tipo meccanico. Ma gli esseri umani in carne e ossa presentano poche somiglianze con questo tipo ideale. Qualsiasi discussione sull’economia e sulla moralità dovrebbe muovere invece dalla premessa che le persone reali non sono solo esseri avidi che cercano di non correre rischi, ma sono anche esseri curiosi e avventurosi, che a volte sentono il bisogno di gettarsi a capofitto nell’ignoto». E ancora: «Se al centro dell’economia mettiamo l’innovazione, veniamo allora a porre un’affermazione spiazzante circa la natura umana, perché affermiamo, a qualche livello, che l’uomo sia un innovatore … Il problema della moralità nell’economia non consiste né nell’equità della distribuzione del reddito né nella stabilità del sistema finanziario. Consiste nel modo in cui le istituzioni umane possano essere conformate alla natura umana – alla natura dell’uomo inteso come innovatore».1
Il capitalismo basato sul libero mercato va inteso quindi, in primo luogo, come il sistema migliore che fino a oggi si sia trovato per realizzare, come rileva Phelps, «un’antropologia che prenda le mosse dalla natura umana intesa come innovativa: dall’homo innovaticus, non dall’homo œconomicus».
Un capitalismo ben funzionante, non corporativo, permette agli individui di realizzare prima di ogni cosa le domande e il potenziale dello spirito umano. Riconciliare la mai quieta (restless) natura umana, l’homo innovaticus, con le necessità della società nel suo complesso è il compito delle istituzioni.
Perché abbiamo ritenuto importante richiamare queste righe?
Perché riteniamo che la società della conoscenza, con la sua carica di potenziale innovativo per risolvere le grandi sfide dell’umanità, a partire da quella fondamentale di conciliare la crescita del benessere di tutti i popoli con la limitatezza delle risorse naturali finora conosciute, abbia in sé il massimo potenziale di espansione per l’homo innovaticus definito da Phelps.
L’economia della conoscenza allarga i confini dell’homo innovaticus. Accanto all’imprenditore classico propenso al rischio e all’avventura, una quota crescente di lavoratori, e in generale di membri della società, viene a essere coinvolta nel processo di formazione della conoscenza e dell’innovazione.
È difficile, però, comprendere in che modo la natura collettiva e sempre più partecipativa dell’attività di innovazione possa essere cristallizzata nella «società dei salariati», caratterizzata, come questa è, dalla netta divisione tra l’imprenditore che assume il rischio e i lavoratori dipendenti che percepiscono un salario fisso, e il cui rischio risulta essere quello, tipicamente passivo, di perdere il posto di lavoro per cause non dipendenti dal proprio comportamento.
La constatazione di questa strutturale inadeguatezza del tradizionale sistema salariale a ricomprendere gli elementi di mutamento implicati dal maturare di una società della conoscenza sollecita anche l’ulteriore riflessione analitica che è proposta nelle pagine di questo libro. Una riflessione che muove, come utile schema di riferimento, dall’impianto teorico di quegli economisti, come Weitzman e soprattutto Meade, che maggiormente hanno contribuito, seppur in un altro contesto storico, ad affrontare il problema.
Del resto, quando Phelps afferma ancora che «muovendo dal riconoscimento del carattere mai quieto della natura umana, e incanalandola verso il fine sociale della creazione di ricchezza, la scienza economica mette a fuoco il problema morale di come riconciliare il carattere intrinsecamente mai quieto della natura umana con le esigenze di base della società», viene da ricordare il tema del «dividendo sociale», ripreso da Meade e collocato nel complesso quadro analitico da lui posto a fondamento delle istituzioni di un’economia partecipativa di tipo capitalistico.
Non è un caso che il concetto di «dividendo sociale» di Meade e dei suoi precursori, basato sulla partecipazione alla ricchezza collettiva di una società, sia di natura quasi opposta a quello di «reddito minimo», inteso come rete di assistenza per chi è senza altri redditi. La differenza è infatti di tipo «funzionale», e non si basa solo sul tipo di finanziamento attivato.
L’idea sottesa è quella «dell’accettabile grado di rischio», ed è quindi funzionale ad allargare la platea di chi passa dalla natura, costretta dal bisogno, dell’homo œconomicus, a quella, più vicina all’essenza dell’uomo, dell’homo innovaticus.
Al contrario dell’approccio assistenzialistico, che spinge l’uomo a sedersi in una comoda situazione di avversione al rischio negando la propria stessa natura, il «dividendo sociale» deve essere concepito come una tecnologia istituzionale che consente di spingere il rischio più in avanti.
In tal modo si va al cuore della riflessione contemporanea sul capitalismo e sulla sua carica innovativa. Ancora Edmund Phelps, nell’incipit del suo ultimo libro (Mass Flourishing. How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge and Change, 2013), si pone la domanda: «Cosa accadde nel XIX secolo che determinò in alcuni Paesi – per la prima volta nella storia umana – crescita illimitata dei salari, espansione dell’occupazione nell’economia di mercato e diffusa soddisfazione del proprio lavoro? E cosa è accaduto per cui molti di questi Paesi – ormai tutti, o così sembra – abbiano perso tutto ciò nel XX secolo?».2
Phelps cerca la risposta nell’esplodere di quell’insieme di valori che hanno generato nel corso dell’Ottocento l’economia moderna, esemplificata dal modello prima britannico e poi americano. Per Phelps sono stati importanti il progresso tecnologico e le istituzioni economiche e finanziarie richieste per lo sviluppo delle attività economiche, ma è contato soprattutto il dinamismo dell’economia moderna che nasce dall’individualismo, dalla ricerca del nuovo, di nuove idee, di nuovi prodotti e nuovi modi di produrre, dall’immaginazione, dalla ricerca della soddisfazione individuale e dell’affermazione di se stessi, dall’accettazione della sfida e del rischio come valore diffuso. Si tratta, secondo Phelps, di valori «non tradizionali», i quali ultimi esaltano al contrario il predominio della comunità e dello Stato sull’individuo, e antepongono la protezione dal pericolo di rimanere indietro all’opportunità del miglioramento. Nella seconda metà del secolo scorso, di fronte ai problemi sociali e alle disuguaglianze creati dalla rapida crescita conseguita da un capitalismo dinamico e aggressivo, si rafforzano invece in Occidente, anche negli Stati Uniti, i valori più tradizionali della comunità, della protezione, della sicurezza.
Questa interpretazione della storia economica e sociale degli ultimi due secoli spiega forse il declino dell’Occidente di fronte a una globalizzazione che ripropone nel resto del mondo le forme di capitalismo aggressivo che determinarono nei secoli passati l’affermazione dell’Occidente. Ma ciò indica anche come siamo di nuovo, oggi più che mai, a porci il problema di come conciliare...