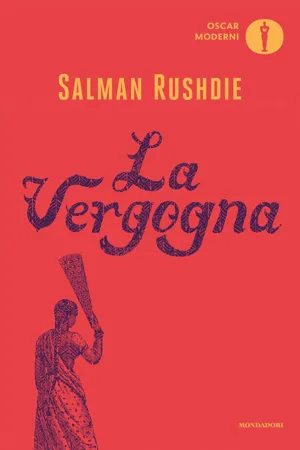![]()
![]()
Iskander Harappa appare in primo piano, con un dito puntato verso l’avvenire, stagliato nel cielo dell’alba. Sopra il suo profilo aristocratico si snoda il messaggio; da destra a sinistra in fluenti caratteri dorati: UN UOMO NUOVO PER UN NUOVO SECOLO. Il quindicesimo secolo (calendario dell’Egira) fa capolino all’orizzonte, tendendo lunghe dita radiose nel cielo mattutino. Il sole sale in fretta ai tropici. E a echeggiare il sole sul dito di Isky luccica un anello di potere... Il manifesto è onnipresente, è incollato sui muri di moschee, cimiteri, bordelli, corrompe gli spiriti: Isky il mago, che evoca il sole dai neri abissi marini.
Cosa sta nascendo? Una leggenda. L’ascesa e la caduta di Isky Harappa; Isky condannato a morte, il mondo inorridito, il suo carnefice sommerso da telegrammi, ma che si leva sopra di loro, li liquida con un’alzata di spalle, un boia spietato, disperato, spaventato. Poi Isky morto e sepolto; ciechi riacquistano la vista davanti alla sua tomba di martire. E nel deserto sbocciano mille fiori. Sei anni al potere, due in carcere, un’eternità sotto terra... Il sole tramonta anche in fretta. Puoi metterti sulle lingue di terra costiera e guardarlo tuffarsi nel mare.
Il segretario Iskander Harappa, morto, spogliato di Pierre Cardin e della storia, continua a proiettare la propria ombra. La sua voce sussurra, nell’orecchio segreto dei suoi nemici, un melodioso implacabile monologo che rosicchia loro il cervello come un verme. Un dito inanellato punta oltre la tomba, facendo scintillare le sue accuse. Iskander ossessiona i vivi; la bella voce dorata, una voce che contiene i raggi dell’alba, ancora sussurra inestinguibile, inarrestabile. Arjumand ne è sicura. In seguito, dopo che i manifesti sono stati strappati; dopo che il cappio, avvolgendosi intorno al suo collo come il cordone ombelicale di un neonato, ha mostrato un tale rispetto per la sua persona da non lasciarvi segni; dopo che lei, Arjumand, è stata rinchiusa nella nuovamente saccheggiata Mohenjo, insieme a una madre che sembra una nonna e che si rifiuta di accettare la divinità del marito defunto; la figlia ricorda, concentrandosi sui particolari, dicendo a se stessa che verrà il giorno in cui Iskander sarà reintegrato nella storia. La sua leggenda è affidata a lei. Arjumand percorre i corridoi brutalizzati della casa, legge romanzetti d’amore, mangia come un uccellino e prende lassativi, si svuota di tutto per far posto ai ricordi. La riempiono tutta, le viscere, i polmoni, le narici; è lei l’epitaffio di suo padre, e lo sa.
Cominciamo dall’inizio. Le elezioni che portarono Iskander Harappa al potere non furono (diciamolo) oneste come io le ho fatte apparire. E come potevano esserlo in un paese diviso in due Ali, con mille miglia in mezzo, in quella specie di uccello fantastico, con due Ali, e senza un corpo, separate dalla massa di terra del suo maggior nemico, unite soltanto da Dio... Lei ricorda quel primo giorno, le folle rumoreggianti intorno ai seggi elettorali. Oh, la confusione di chi ha vissuto per troppo tempo sotto un governo militare e ha dimenticato gli aspetti più semplici della democrazia! Numerosi uomini e donne furono travolti dagli oceani dello smarrimento, incapaci di individuare le urne elettorali e persino le schede, e non poterono neanche votare. Altri, nuotatori più vigorosi in questi mari, riuscirono a esprimere le proprie preferenze dodici o tredici volte. Attivisti del Fronte popolare, afflitti da questa generale mancanza di buona educazione elettorale, tentarono eroicamente di salvare la giornata. Le poche circoscrizioni urbane che diedero risultati incompatibili con il comportamento elettorale dell’intera Ala occidentale ricevettero nottetempo la visita di entusiasti membri del partito che aiutarono gli scrutatori a rifare i conti. In tal modo la situazione divenne molto più chiara. Fuori degli erranti seggi elettorali si radunarono folle di democratici, molti con fiaccole accese sopra la testa nella speranza di fare nuova luce sul conteggio. Il chiarore dell’alba risplendeva nelle strade, mentre le folle salmodiavano rumorosamente, ritmicamente, per spronare gli scrutatori nelle loro fatiche. E prima del mattino la volontà popolare era stata espressa e il segretario Isky aveva conquistato una larga e assoluta maggioranza dei seggi dell’Ala occidentale nella nuova Assemblea nazionale. Giustizia approssimativa, ricorda Arjumand, ma giustizia.
I veri guai cominciarono però nell’Ala orientale, quella suppurante palude. Popolata da chi? Oh, da selvaggi che prolificavano all’infinito, da conigli selvatici capaci soltanto di coltivare iuta e riso, di accoltellarsi tra loro, di allevare traditori nelle loro risaie. Perfidia orientale: dimostrata dall’incapacità del Fronte popolare di conquistarvi anche un solo seggio, mentre la gentaglia della Lega del popolo, un partito regionale di borghesi malcontenti guidati da quel famigerato incompetente dello sceicco Bismillah, aveva conseguito una così schiacciante vittoria da finire con più seggi all’Assemblea di quelli che Harappa aveva vinto nell’Ala occidentale. Date alla gente la democrazia e guardate cosa vi combinano. L’occidente in uno stato di shock, il rumore di un’Ala che batte, tormentata dall’ipotesi spaventosa di dover cedere il governo a un partito di aborigeni delle paludi, di piccoli uomini scuri con una lingua impronunciabile di vocali deformate e di consonanti biascicate; forse non proprio stranieri, ma forestieri senza il minimo dubbio. Il presidente Shaggy Dog inviò, con dispiacere, un enorme esercito per ristabilire nell’Ala orientale un corretto senso delle proporzioni.
I pensieri di Arjumand non si soffermano sulla guerra che ne seguì, se non per notare che ovviamente la nazione idolatra posta tra le due Ali appoggiò fino in fondo i bastardi orientali, per evidenti ragioni del genere divide et impera. Fu una guerra terribile. Nell’occidente, raffinerie di petrolio, aeroporti e case di civili timorati di Dio bombardati da esplosivi pagani. La disfatta finale delle forze occidentali, che portò alla ricostituzione dell’Ala orientale come nazione autonoma (che ridere) e caso pietoso internazionale, fu ovviamente combinata da stranieri: i lavatori su pietra e i fottutissimi yankee, certo. Il segretario Harappa andò alle Nazioni Unite e sgridò duramente quegli eunuchi: «Non riuscirete a distruggerci finché io sarò vivo!». E uscì tempestosamente dall’Assemblea generale, bellissimo, infuriato, grande: «Il mio paese mi sa ascoltare! Perché dovrei restare in questo harem di puttane travestite?», e tornò in patria per prendere le redini del governo in quel che rimaneva della terra di Dio. Lo sceicco Bismillah, l’artefice della divisione, divenne il capo di quelli della giungla. Che poi, inevitabilmente, sciamarono nel suo palazzo e riempirono di buchi lui e la sua famiglia. Il tipo di comportamento che ci si può aspettare da gentaglia del genere.
La catastrofe: per tutta la durata della guerra, bollettini radiofonici descrissero d’ora in ora i gloriosi trionfi dei reggimenti occidentali in oriente. L’ultimo giorno, alle undici del mattino, la radio annunciò l’ultimo e il più glorioso di questi fatti d’armi; a mezzogiorno informò concisamente gli ascoltatori dell’impossibile: resa incondizionata, umiliazione, disfatta. Si paralizzò il traffico nelle strade cittadine. Il pranzo della nazione non venne cucinato. Nei villaggi, le bestie non furono nutrite e nonostante il caldo non si irrigarono i campi. Correttamente il segretario Iskander Harappa, diventato Primo ministro, definì la reazione nazionale alla stupefacente capitolazione un esempio di giusta rabbia alimentata dalla vergogna. Quale calamità aveva potuto colpire così rapidamente un esercito? Quale rovescio poteva essere stato talmente repentino e totale da trasformare la vittoria in disastro in soli sessanta minuti? «La responsabilità di quell’ora fatale» dichiarò Iskander «risiede necessariamente al vertice.» I poliziotti, cani compresi, circondarono la casa dell’ex presidente Shaggy meno di quindici minuti dopo questa dichiarazione. Lo portarono in prigione in attesa di processarlo per crimini di guerra; ma poi il segretario Harappa, rispecchiando ancora una volta lo stato d’animo di un popolo nauseato dalla disfatta e ansioso di arrivare a una riconciliazione, di porre fine alle analisi della vergogna, offrì a Shaggy la grazia purché accettasse gli arresti domiciliari. «Tu sei i nostri panni sporchi,» disse Iskander al vecchio incompetente «ma per tua fortuna il popolo non vuole che tu venga finito a colpi di bastone su una pietra.»
Ci furono dei cinici che ironizzarono su questa grazia; è superfluo dirlo poiché ogni nazione ha i suoi nichilisti. Questi individui, facendo notare che Iskander Harappa era stato il principale beneficiario della guerra civile che aveva spaccato in due il paese, diffusero voci sulla sua complicità in questa triste faccenda. «Shaggy Dog» mormoravano nei loro squallidi antri «è sempre stato il cocco di Harappa; gli mangiava in mano.» Questi elementi disfattisti sono una realtà della vita. Il segretario li trattava con disprezzo. A un comizio cui assistettero due milioni di persone, Iskander Harappa si sbottonò la camicia. «Cos’ho da nascondere?» gridò. «Dicono che ho tratto benefici; ma ho perso una buona metà della mia amata patria. E ditemi voi, è un guadagno questo? È un vantaggio? È una fortuna? Popolo mio, i vostri cuori sono sfregiati dal dolore; guardate, anche il mio cuore porta le stesse ferite.» Iskander Harappa si strappò di dosso la camicia e la spaccò a metà; denudò il petto senza peli davanti alla folla plaudente e piangente. (Richard Burton da giovane fece una volta la stessa cosa nel film Alessandro Magno. I soldati amavano Alessandro perché mostrava loro le cicatrici ricevute in battaglia.)
Ci sono uomini talmente grandi che possono essere abbattuti soltanto da se stessi. L’esercito disfatto aveva bisogno di nuovi capi; Isky spedì prematuramente in pensione la screditata vecchia guardia e affidò il comando a Raza Hyder. «Sarà un mio uomo. E con un capo così compromesso l’esercito non potrà mai diventare troppo forte.» Quest’unico errore si rivelò la causa della rovina dello statista più abile di questo paese così tragicamente sfortunato, così maledetto nei suoi capi di Stato.
Non poterono mai perdonargli la capacità d’ispirare amore. Arjumand a Mohenjo, piena di ricordi, permette alla propria mente di tramutare gli elementi tesaurizzati del passato nell’oro del mito. Durante la campagna elettorale era abituale che donne gli si avvicinassero, sotto gli occhi della moglie e della figlia, per dichiarargli il loro amore. Nei villaggi nonne appollaiate sugli alberi gridavano al suo passaggio: «Ehi tu, se avessi trent’anni di meno!». E gli uomini non si vergognavano a baciargli i piedi. Perché lo amavano. «Io sono la speranza» diceva Iskander alla figlia... e l’amore è un sentimento che si riconosce negli altri. La gente lo vedeva in Isky, ne era evidentemente pieno, sino all’orlo, traboccava da lui e li lavava tutti. Da dove veniva? Arjumand lo sa, e anche sua madre. Era un torrente deviato. Egli aveva eretto una diga tra il fiume e la sua destinazione. Tra se stesso e Pinkie Aurangzeb.
All’inizio Arjumand aveva assunto fotografi per scattare istantanee segrete di Pinkie. Pinkie al bazar con un pollo spennato, Pinkie in giardino appoggiata a un bastone, Pinkie nuda sotto la doccia come un dattero da tempo seccato. E lasciava queste foto in luoghi in cui il segretario potesse vederle. «Ma guardala, Allah, ha cinquant’anni e ne dimostra cento, o almeno settanta, cosa le resta?» Nelle fotografie il viso era gonfio, le gambe sfregiate da vene varicose, i capelli scarmigliati, radi, bianchi. «Smettila di mostrarmi queste foto!» gridò Iskander alla figlia (se ne ricorda ancora perché con lei non perdeva quasi mai le staffe). «Credi che io non sappia cosa le ho fatto?»
Se un grand’uomo ti tocca, tu invecchi troppo in fretta, vivi troppo e ti consumi. Iskander Harappa aveva il potere di accelerare i processi d’invecchiamento nelle donne della sua vita. A cinquant’anni, Pinkie era andata oltre i tacchini, persino oltre il ricordo della propria bellezza. E anche Rani aveva sofferto, seppure non in questa misura perché lo aveva visto meno. Aveva sperato, naturalmente, ma quando fu chiaro che lui la voleva accanto solo sulle tribune elettorali, che il suo tempo era passato e non sarebbe più tornato, tornò a Mohenjo senza discutere, ridiventando la padrona dei pavoni e della selvaggina da penna e delle concubine che giocavano a badminton e dei letti vuoti, non tanto una persona quanto un aspetto della proprietà, il benigno spirito familiare del luogo, pieno di crepe e coperto di ragnatele proprio come una vecchia casa. E anche Arjumand era sempre stata accelerata, matura troppo giovane, precoce, estremamente sveglia. «Il tuo amore è troppo per noi;» disse al segretario «moriremo tutte prima di te. Tu ti nutri di noi.»
Di fatto però gli sopravvissero tutte. Il suo amore deviato (perché non rivide più Pinkie, non alzò mai il telefono né scrisse mai una lettera, il nome di lei non uscì mai dalle sue labbra; vide le fotografie e poi più niente) schizzava sulla gente, sino al giorno in cui Hyder ne bloccò la fonte.
Schizzava anche su Arjumand; e per lei era più che sufficiente. Si trasferì con lui nella residenza del Primo ministro nella nuova capitale nel nord, e per qualche tempo Rani continuò a scriverle, proponendo ragazzi, mandando persino fotografie; ma Arjumand le rispediva lettere e fotografie dopo averle fatte a brandelli. Ci vollero parecchi anni, passati strappando a metà potenziali mariti, prima che la Vergine Mutandediferro frustrasse definitivamente le speranze di Rani e potesse liberamente proseguire nel cammino che si era scelto. Quando Isky divenne Primo ministro, essa aveva ventitré anni, ma ne dimostrava di più e, benché fosse sin troppo bella, il trascorrere del tempo assottigliava le sue prospettive matrimoniali e alla fine rimase senza corteggiatori. Arjumand e Haroun non si dissero più nulla. Mi ha strappata a metà da un pezzo.
Arjumand Harappa si laureò in legge, divenne un’attivista della “rivoluzione verde”, cacciò zamindar dai loro palazzi, aprì prigioni sotterranee, guidò irruzioni nelle case dei divi del cinema e squarciò i loro materassi con un lungo coltello a doppio taglio, ridendo nel vedere il denaro nero fluire copioso dalle cavità delle molle. In tribunale perseguitava i nemici dello Stato con una scrupolosa ferocia che diede al suo soprannome un nuovo significato meno scurrile; una volta, arrivando nel suo studio, trovò che un ignoto burlone vi si era introdotto durante la notte e aveva lasciato, al centro della stanza, un dono beffardo: la metà inferiore di un’antica armatura arrugginita, un paio di satiriche gambe di metallo, in posizione d’attenti, coi talloni riuniti, sul tappeto. E disposta trasversalmente alla vita una cintura di metallo con lucchetto. Arjumand Harappa, la Vergine Mutandediferro.
Quella notte pianse, seduta sul pavimento dello studio del padre, con la testa appoggiata a un suo ginocchio. «Mi odiano.» Iskander allora l’afferrò e la scosse finché lo stupore non le asciugò le lacrime. «Chi ti odia?» domandò. «Chiediti solo questo. I tuoi nemici sono i miei nemici e i nostri nemici sono i nemici del popolo. Che motivo c’è di vergognarsi se si è odiati da quei bastardi?» Lei capì allora che l’amore genera odio. «Io sto costruendo il paese» le disse pacatamente Iskander «come un uomo che si costruisce il proprio matrimonio. Con la forza e con l’affetto. Non è il momento di piangere se vuoi essermi d’aiuto.» Lei si asciugò gli occhi e sorrise. «Poligamo» gli diede un pizzicotto alla gamba. «Che tipo antiquato, in fondo! Non vuoi altro che matrimonio e concubine. Uomo moderno un corno!»
«Signor Harappa,» gli chiede l’intervistatore della televisione angrez «molti commentatori potrebbero dire, secondo un’opinione ampiamente diffusa, a quanto sostengono i suoi oppositori, che cosa direbbe lei se qualcuno insinuasse che, in base a certi criteri, secondo certi punti di vista, in un certo senso, il suo modo di governare potrebbe essere forse definito, in qualche misura...»
«Vedo che a intervistarmi adesso mandano i bambini» lo interrompe Isky. L’intervistatore ha cominciato a sudare. Arjumand non è inquadrata, ma ricorda.
«... aristocratico,» conclude quello «autocratico, intollerante, repressivo.»
Iskander Harappa sorride, si rilassa sulla sua sedia Luigi Quindici, sorseggia roohafza da un bicchiere di vetro tagliato. «Lei potrebbe dire» risponde «che io non sopporto con gioia gli stupidi. Ma, come vede, li sopporto.»
Arjumand a Mohenjo riascolta i videotape di suo padre. Ritrasmessa nella stessa stanza in cui avvenne, questa conversazione la sconvolge, questa resurrezione elettronica comandata a distanza. Sì, li sopportava. Il suo nome era inciso nella storia a caratteri d’oro fiammante; perché doveva dar retta agli impudenti? Eccoli qui sul videotape, fidati di un giornalista occidentale per rimestare nelle fogne e cavarne una manciata di rifiuti. Mi ha torturato, gemono, mi ha licenziato, mi ha messo in prigione, ho dovuto scappare per salvarmi. Cara televisione: fa’ apparire i nostri capi come dei primitivi, dei selvaggi, anche se hanno studiato all’estero e vestono con ricercatezza. Sì, sempre i malcontenti, sono i soli che a loro interessino.
Non gli era mai piaciuto discutere. Fa’ quello che ti ho ordinato e fallo subito, senza perder tempo, se no fili. Ed era così che doveva essere. Pensate con chi gli toccava lavorare – ministri compresi. Voltagabbana, profittatori, quisling, conformisti, dal primo all’ultimo. Non fidandosi di nessuno, istituì la Forza di sicurezza federale e ne affidò il comando a Talvar Ulhaq. «Informazione è illuminazione» diceva il segretario Iskander Harappa.
La chiaroveggenza di Talvar Ulhaq gli permise di compilare esaurienti dossier sulle distribuzioni di bustarelle, sui complotti, sulle evasioni fiscali, sulle chiacchiere pericolose durante i pranzi, sulle sette studentesche, sull’omosessualità, insomma sulle radici del tradimento. Questa chiaroveggenza gli dava la possibilità d’arrestare un futuro traditore prima ancora che commettesse l’atto di tradimento, e di salvargli così la vita. I disfattisti attaccavano la FSF, avrebbero spento volentieri quella grande luce purificatrice, e così finivano tutti in galera, il posto migliore per i malcontenti. Non c’è spazio per gente del genere in un periodo di rigenerazione nazionale. «Come nazione, abbiamo chiaramente il genio dell’autodistruzione» disse una volta Iskander a Arjumand. «Troviamo sempre da ridire su noi stessi, divoriamo i nostri figli, buttiamo giù chiunque cerchi di salire. Ma io sostengo che sopravviveremo.»
«Nessuno potrà farmi cadere,» dice lo spettro di Isky all’ombra elettronica del giornalista angrez «non i capitalisti, non gli americani, e neanche voi. Cosa sono io? Io sono l’incarnazione dell’amore del popolo.»
Le masse contro le classi, l’antica contrapposizione. Chi lo amava? “Il popolo” che non è una mera astrazione romantica; che è sensibile e abbastanza intelligente per capire ciò che più gli giova. Chi lo amava? Pinkie Aurangzeb, Rani Harappa, Arjumand, Talvar, Haroun. Ma quanti dissensi in questo quintetto! Tra moglie e amante, madre e figlia, respinta Arjumand e respingente Haroun, abbandonato Haroun e usurpante Talvar... forse, riflette Arjumand, la sua caduta è stata colpa nostra. È attraverso le nostre schiere divise che loro hanno potuto spingere i reggimenti della sua disfatta.
Loro. I capitalisti, i contrabbandieri, i preti. L’alta società cittadina che ricordava la sua giovinezza spensierata e non poteva tollerare che da quel bozzolo di dissolutezza fosse uscito un grand’uomo. I padroni di fa...