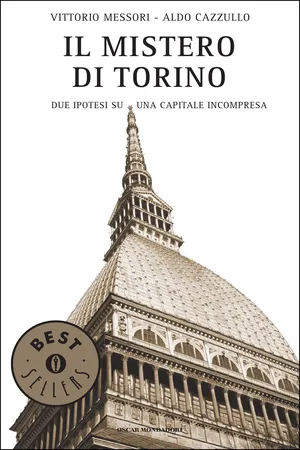![]()
![]()
Torino, caro Aldo, entrò nella mia vita per trentadue anni, dodicimila giorni, a causa di un commerciante ebreo, un commendator Corinaldi, che lavorava con il figlio in un alloggio che era anche il suo ufficio di import-export. All’inizio di ogni autunno, all’approssimarsi della festa di Sukkot, quegli israeliti chiedevano aiuto al loro unico impiegato – mio padre – per costruire la capanna rituale sul balcone. Questo dava su via Guicciardini, davanti allo spiazzo desolato di Porta Susa, dove era stata in progetto una colossale Casa del Littorio e dove invece, sulle fondamenta già gettate, tirarono poi su il grattacielo della Rai. Lo vidi montare, pezzo dopo pezzo, come un gioco di costruzioni, nei primissimi Sessanta: era il primo, e restò l’unico, vero grattacielo torinese (assieme, forse, all’anomala Torre di piazza Castello), ed era con emozione che seguivo le manovre delle gru che incastravano gli enormi elementi in acciaio.
Correvano gli anni in cui sembrava davvero che la città stesse trasformandosi in grande metropoli europea e anche quel gigante pareva confermarlo. Ma lo costruivano di malavoglia, per ragioni politiche: la direzione della Rai aveva lasciato da poco il palazzetto eclettico al mitico indirizzo di via Arsenale 21 e si era insediata nella nuova, scintillante sede, nel romano viale Mazzini. Per placare le proteste piemontesi si decise di lasciare sotto la Mole almeno la direzione amministrativa, costruendo per questa un edificio imponente. Una divisione artificiosa, per una grande azienda, un’operazione che moltiplicava i costi. Difatti Roma, pezzo per pezzo, svuotò il palazzo torinese che, da quel che so, è da tempo in vendita. Ma mi pare che finora non si sia fatto avanti nessuno.
In questa Torino dove venni per merito (io lo considero tale) di un commerciante ebreo, cercò di impedirmi di venire un altro commerciante, dal nome inconfondibilmente piemontese e «ariano», un Cambursano, che mi costrinse ad arrivare da clandestino, sbarcando nottetempo – come oggi gli immigrati dal Terzo mondo – non a Lampedusa ma a Porta Nuova.
Resta il fatto che proprio un figlio osservante di Israele convocò a Torino mio padre che, obbedendo ai bandi di richiamo, aveva militato nella divisione Littorio della Repubblica sociale italiana. Una piccola storia; ma, a suo modo, esemplare.
Noi siamo di Sassuolo, al confine tra Modena e Reggio, proprio là dove la pianura padana termina e inizia l’Appennino. I miei due nonni facevano bei mestieri, di artigianato antico e sapiente: il sellaio quello paterno, il tappezziere e il materassaio quello materno.
Pare che Sassuolo fosse, un tempo, un posto gradevole. Tanto che i duchi di Modena ci costruirono il Palazzo di Delizie dove trascorrere l’estate e dove ricevere gli ospiti con i quali far bella figura. Era, comunque, una bella zona: uso l’imperfetto, e non posso fare altro. Come sai, quei posti non furono mai poveri, grazie a una terra generosa lavorata da contadini instancabili e accorti. Ma quel che determinò l’apocalittica mutazione, con un fiume di denaro e di immigrati, fu anche la rovina.
Parlo, ovviamente, dell’industria della ceramica, che aveva radici antiche, grazie all’argilla delle colline attorno al Secchia. L’intraprendenza e la genialità di alcuni imprenditori innestarono, nel dopoguerra, un processo a valanga che, in pochi anni, fece prima di Sassuolo e poi dei comuni vicini quel «distretto della ceramica» che non ha pari nel mondo. In ogni continente, cucine e bagni sono piastrellati con le formelle sfornate dalle gigantesche linee di produzione del mio paese, ora in realtà città di quasi 50mila abitanti. Ci torno poco, pochissimo, proprio perché mi si serra il cuore. Non solo con un delitto ambientale, ma anche economico, campi tra i più fertili del mondo, con colture di pregio, sono stati coperti da un’industria che mangia spazi enormi ed è tra le più inquinanti.
La gente, da noi, fu molto cattolica, poi molto socialista, poi molto fascista, poi molto comunista. Infine, molto consumista, di un edonismo ruggente. Come dice il cardinal Giacomo Biffi, che è brianzolo ma che la mia gente la conosce bene, dopo tanti anni da arcivescovo di Bologna, «gli emiliani sono straordinari, quando si mettono a fare qualunque cosa spesso diventano i primi nel mondo. Sono bravissimi, ma hanno un vizio non da poco, viste le conseguenze che provoca: riescono sempre a sbagliare le scelte politiche». Peccato. Anche perché, come non si stanca di ripetere quel bolognese di montagna che è Enzo Biagi, pare che addirittura un terzo degli italiani che stanno nelle enciclopedie sia nato in quella che è chiamata Emilia-Romagna.
Comunque, il famoso «comunismo all’emiliana» – che ha concesso al Pci maggioranze granitiche e inamovibili – ha permesso ai miei corregionali di essere iscritti al Partito e, al contempo, padroncini o padroni avveduti e, spesso, spietati con i subordinati, obbedendo solo alle leggi di un mercato sfrenato. È lo stesso «comunismo» che ha governato per decenni città e paesi e che ha a suo carico disastri ambientali più devastanti di quelli di qualunque liberismo anarchico. D’altro canto, la caduta del Muro ci ha permesso di constatare che altrettanto è avvenuto a est: nessun capitalismo si sarebbe spinto a provocare le catastrofi ecologiche del «socialismo realizzato».
Ma in questo disastro c’è per me, un po’ tristemente, almeno un vantaggio: proprio l’inabitabilità dei luoghi, assediati da polveri, esalazioni di piombo e altre prelibatezze, frutteti e campi sostituiti da capannoni, colonne di camion intrappolati su strade inadeguate, proprio tutto questo scenario da apocalisse mi ha impedito ogni tentazione nostalgica di «ritorno alle radici», di vita da retraité nella «piccola patria». Mi accontento della Sassuolo del mito di cui sentivo parlare in casa, a Torino; della Sassuolo anni Trenta delle poesie di mio padre.
Sono cresciuto bilingue. Anzi, trilingue. In effetti, la mia famiglia rimase, quanto a cucina e dialetto, un’isola emiliana dentro Torino. Così, pur integrati, ci restavano alcune bizzarrie linguistiche: mio fratello e io, ad esempio, sorprendevamo e divertivamo i piemontesi che ci sentivano chiamare «babbo» quello che per loro è solo «papà». Dicevano che sembravamo Pinocchio quando si rivolge a Geppetto. Sono grato ai miei di avere continuato a parlare così come ha parlato la lunga, oscura catena dei miei antenati, permettendo anche a me di sentirmi figlio di un luogo. Come sai, non si abita un paese, si abita una lingua. E anche una cucina: quella di mia madre mi ha dato problemi seri di colesterolo. Ma come non volerle bene anche per quei tortellini, tortelli, lasagne, tagliatelle, gnocchi, zamponi, lessi e tante altre cose che non dico perché non ne conosco la traduzione in lingua?
Amo la cucina piemontese, ne apprezzo la varietà e, spesso, la raffinatezza, la credo più ricca della gastronomia emiliana che si concentra su pochi piatti, soprattutto primi, e ignora, fra l’altro, quel mondo di delizie costituito da una serie infinita di antipasti. Ma è il Dna dei secoli che mi porto dentro a farmi emozionare quando – rotto il sottile involucro della sfoglia fatta a mano, macerata dal brodo di cappone, ricoperta di parmigiano rappreso – arrivo al gusto del ripieno dei tortellini di Natale.
Mio padre, poi, ha vissuto un’esperienza singolare. È giunto a Torino a ventisette anni e non si è più mosso. Eppure, appena andato in pensione, e pur restando ostinatamente sotto la Mole (anche a lui, il ritorno era impedito dalla devastazione che dicevo), è divenuto il più noto, credo, dei poeti in sassolese. Se chiedi un libro di un Messori nella provincia di Modena, è probabile che il libraio ti chieda: «Quèl di Mesóri? Al pèder o al fiól?», quale dei Messori, il padre o il figlio?
Il successo di quelle sue plaquettes viene dalla qualità dei contenuti, ma anche dal linguaggio. In effetti, il lungo esilio piemontese ha ibernato il suo dialetto a prima della guerra, prima che cominciasse a corrompersi.
Sono trilingue, dicevo. In effetti, al sassolese dei versi di mio padre e all’italiano (impeccabilmente insegnatomi da professori tutti piemontesi, che sono riusciti persino a non trasmettermi l’inconfondibile pronuncia subalpina, che un po’ m’intenerisce quando la sento, ora che sono lontano), aggiungo un passabile torinese che mi permette di gustare sin nelle riposte sfumature cose come, ovviamente, Le miserie d’ monsù Travet o i versi di Nino Costa; e in cui ogni tanto, chiacchierando, mi piace dire qualcosa.
Frasi vere e proprie le pronuncio solo quando, nei miei ritorni, mi avvedo che il tassista che mi trasporta è indigeno e, dunque, diffida di me, sospettando di avere un napouli sul sedile posteriore. Soprattutto quando portavo grossi baffi neri, l’equivoco era possibile e non era escluso che, nell’autista, scattasse il timore che il tipo caricato alla stazione o all’aeroporto fosse un malintenzionato, un rapinatore o almeno un mafioso. Ma, alle prime parole alla Gianduja, l’autista si distende, mi sorride ed è disponibile a conversare. Il che è cosa preziosa, per la curiosità di quel cronista che sono e che ho sempre voluto rimanere.
Non molti lo sanno: seppur per pochi chilometri – soltanto un sette o otto, per giunta di impervio Appennino – il Piemonte confina con l’Emilia. Succede, per intenderci, non lontano da Bobbio, il paese della famosa abbazia il cui favoloso archivio, nella sua parte più preziosa, finì proprio alla Biblioteca Nazionale di Torino, in via Po, e lì andò in gran parte distrutto nell’incendio del 1904. Malgrado questa vicinanza, le due culture sembrano avere pochi punti in comune e le due regioni, tutto sommato, si conoscono poco. In quello che era stato il Ducato di Modena, Reggio e Guastalla fu aspra la resistenza all’unione con il Piemonte (tutto il piccolo esercito, nel 1859, seguì volontariamente il duca nel suo esilio in Austria e si sciolse solo per sua richiesta), aspra anche per questioni religiose. Può sembrar strano, oggi, per gente come la mia, ma i nuovi padroni venuti da Torino furono osteggiati anche, e soprattutto, perché anticlericali. Modena fu una delle capitali dell’intransigentismo cattolico che guardava ai Savoia delle leggi ostili alla Chiesa quasi come a degli anticristi. Pensa che nelle elezioni del 1865, il candidato antigovernativo nei collegi di Modena e Reggio fu, nientemeno, il conte cuneese Clemente Solaro della Margarita, il cattolicissimo ministro di Carlo Alberto che diede le dimissioni quando lo Statuto ammise la libertà di culto.
Ma sì, ancora adesso ci si conosce poco. I torinesi confondono gli emiliani con i romagnoli (simpatici cugini ma che, nel bene e nel male, sono altra cosa) e, per giunta, con i romagnoli delle barzellette. Credono, dunque, che gli emiliani siano tutti focosi, polemici, teste calde, anarchici, a metà tra il giovane, scarmigliato Mussolini, il Nenni, demagogo in basco e sandali, e Stefano Pelloni, il pascoliano «Passator Cortese». Ricordo il maestro alle elementari Pacchiotti che, se gli sembravo troppo vivace, scuoteva il capo e rimandava a De Amicis, a quel suo «racconto mensile». «Sangue romagnolo!» esclamava, con indulgenza e, mi pareva, con qualche simpatia.
Per gli emiliani, invece, quelli di Torino (Turèin, in dialetto), la Torino in cui pochi sono stati se non – quando c’era – per il Salone dell’auto, sono, ovviamente, «falsi e cortesi», gente magari seria ma impenetrabile, forse un po’ ottusa ma di cui diffidare perché può fregarti con buone maniere, tipi snob e noiosi, che abitano in una città altrettanto noiosa, grigia e per giunta nevosa e fredda. Come se in Emilia il clima, d’inverno, fosse clemente. Ma c’è, qui, un pregiudizio che accomuna gli italiani che non sanno che Torino ha un microclima secco, con una media annuale di soli 800 millimetri di precipitazioni, in minima parte neve. Ebbene, a Napoli (’o paese do sole...) la media è di 947 millimetri e di ben 1400 sui Colli Romani. Ma il cliché vuole sempre grigi e tristi i cieli piemontesi.
Al tempo dei miei genitori, si diceva pure che quei fighetti dei torinesi, invece del pane, quello massiccio, emiliano, di pasta dura, mangiassero dei bastoncini leggeri, pieni più di aria che di farina e che chiamavano «grissini». Roba da signorine anoressiche o da aristocratici slombati. Così si diceva: se ho usato l’imperfetto è perché gli emiliani, che hanno poco da invidiare ai cinesi quanto a capacità di mettersi a fare da sé ciò che scoprono in giro, fanno ora dei grissini non dico come quelli di Chieri (i rubatà non rientrano nel loro gusto) ma certamente come quelli di Torino.
Molti, tra Emilia e Romagna, tifano per la Juventus, tanto che – come sai – la squadra pensava (anche lei!) di andarsene da Torino e di costruire il suo stadio in qualche posto lungo la via Emilia. Ma ho l’impressione che, da quei tifosi delle mie parti, lo squadrone degli Agnelli sia percepito come una sorta di istituzione nazionale (non è quello che ha il maggior numero di supporter in tutto lo Stivale?), senza particolari legami con la città dei Savoia.
Molte anziane sassolesi non conoscevano, ovviamente, Torino, ma erano convinte di conoscere il Piemonte perché deportate ogni anno, con altre migliaia di donne, a fare la stagione, come mondine, nelle risaie vercellesi, da cui tornavano portando sulle spalle un sacco di chicchi. Per quelle buone vecchie, il Piemonte era tutta una palude, una campagna allagata. E mia nonna materna, che qualche volta si unì alle spedizioni come cuoca, finché visse mi parlò con spavento del canale Cavour, dove – diceva – l’acqua era così alta e la corrente così forte che non c’era scampo per chi vi cadesse dentro, com’era successo a certe povere mondine.
Comunque, per la mia gente, è istintivo il raffronto tra Torino, sentita come enigmatica e lontana, e Milano, dove precisano subito che non vivrebbero perché la considerano troppo grande, per il loro gusto dei rapporti umani, e anche brutta, ma che avvertono più comprensibile e più vicina, in tutti i sensi. Non a caso, la via Emilia termina a Rimini ma inizia a Milano, da Porta Romana e, nei primi secoli cristiani, anche i vescovi al di sotto del Po dipendevano dalla grande metropoli ecclesiastica di Ambrogio. Sino all’Unità, si diceva Reggio di Lombardia per distinguerla dalla Reggio calabrese.
Milano era, per mio nonno e per tanti come lui, la vera, la sola metropoli italiana, la città dei «Fratelli Bocconi», il primo e a lungo unico grand magasin alla parigina, che D’Annunzio ribattezzò «la Rinascente». Un posto, mi ripeteva sbalordito il buon, vecchio sellaio, dove, stando a chi c’era stato, potevi entrare nudo e scalzo e uscirne un’ora dopo, vestito e calzato di tutto punto. Il parmigiano Guareschi ha espresso bene, dedicandovi un libro (La scoperta di Milano), questa attrazione emiliana, ammirata e un po’ sgomenta, per la New York lombarda. Quella da dove arrivavano (per stare solo alla carta stampata) la «Domenica del Corriere», la «Gazzetta dello Sport», la «Settimana Enigmistica», l’«Illustrazione italiana», le Guide del Touring per i notabili che ne erano soci. Niente di tutto questo, s’intende, per Torino, da dove giungevano solo le auto (e non tutte, agli emiliani piacevano le sportive, dunque sbavavano per le milanesi Alfa Romeo), per Torino che, al massimo, era creduta elegante: ma di un’eleganza frigida e arrogante, da corte reale.
Succede, però, che al Museo di Arte moderna di New York siano esposte alcune automobili considerate il vertice mondiale del design e della tecnica. Una di quelle auto che hanno fatto la storia è una Ferrari carrozzata da Pininfarina. Le mie radici paterne non sono a Sassuolo bensì nel paese attiguo, Fiorano, che a Sassuolo fu spesso unito in un unico comune. Ebbene, è proprio a Fiorano che la Ferrari (che ha fabbrica a Maranello, il comune confinante) ha la sua celebre pista di prova. Il vertice della tecnica e dello stile italiano nel mondo è da decenni l’unione tra un Enzo, il modenese, e un Giambattista alias Pinìn, il torinese; è l’alleanza tra il mago dei motori e l’artista della lamiera.
Io, se vogliamo metterla così, sono partito dal paese della Ferrari per approdare nella città della Pininfarina. Insieme, emiliani e piemontesi abbiamo fatto, e continuiamo a fare, grandi cose: sulle piste le «rosse» spadroneggiano nei campionati del mondo e, sulle strade, il loro motore ruggisce sotto l’abito confezionato sul Po, come da unione ormai storica.
Per restare fra i motori, qualcos’altro è successo con i trattori. La Fiat non li ha mai fatti a Torino: fu la prima, e credo unica, produzione che il vecchio senatore Agnelli volle fuori del Piemonte. Con scelta che non ebbe mai ripensamenti, a ogni altro posto preferì Modena. Agnelli fu, fra l’altro, preveggente perché, quando lui era ormai morto, sotto il controllo occhiuto delle amministrazioni comuniste, attente a preservare migliaia di posti di lavoro ad altrettanti operai che le votavano, gli impianti modenesi della Fiat godettero di una pace sociale che a Torino ebbero di rado.
A proposito di legami: ho sempre trovato curioso che sia proprio a Sassuolo una delle poche parrocchie italiane rette dai Missionari della Consolata, questa Congregazione così torinese. Ma, tra i sassolesi stessi, ben pochi sanno che per tutto un secolo, il Cinquecento, sono stati sotto la signoria dei Pio di Savoia, legati, lo dice il nome, agli omonimi che dominavano sul Piemonte. E infine, se permetti, una piccola sorpresa da bibliofili: lo Struzzo dell’Einaudi, con il cartiglio dal motto Spiritus durissima coquit, viene anch’esso dalle mie parti. In effetti, fu lo stemma scelto da un monsignor Giovio, vescovo di Modena nel Cinquecento.
C’è un’altra singolarità che molti ignorano: buona parte di ciò che, nell’aspetto architettonico, consideriamo più «torinese» in realtà è «modenese». Mi sai dire se c’è qualcosa che appaia più piemontese, che meglio sembri sintetizzare lo spirito profondo della città di piazza Carignano? Il sinuoso palazzo che fu sede del Parlamento Subalpino (e dove nacque Vittorio Emanuele II, come da enorme festone in bronzo), il grande «Collegio dei Nobili» costruito per i gesuiti e divenuto poi sede del Museo Egizio e della Pinacoteca Sabauda, l’abside della chiesa di San Filippo, la più vasta della città... Ebbene: tutte cose nate dalla fantasia e dalla straordinaria sapienza di tecnico e di matematico del padre teatino Guarino Guarini. Modenese. È ancora lui che, sul modesto duomo di un toscanismo spaesato da queste parti, inventa lo scrigno fantastico per la gemma maggiore dei Savoia e dei loro popoli, la Sacra Sindone. È lui che costruisce la chiesa di San Lorenzo per dare gloria alla dinastia. È lui che riplasma il santuario torinese per eccellenza, la Consolata. Non sta ai margini, dunque, ma nel cuore stesso della città.
L’uso, nelle facciate esterne, del mattone a vista (come, appunto, quello che domina in tutta piazza Carignano) non era piemontese, era una necessità di noi emiliani, senza cave di pietra e meno che mai di marmo, di noi, ricchi solo di argilla. È il modenese Guarini che lo importa anche per le sue architetture torinesi, provocando scandalo per la novità, ma poi con tale successo che sarà adottato per secoli – sino ad Alessandro Antonelli – dagli architetti locali e diverrà parte inconfondibile del volto non solo della città ma dell’intera regione. Ebbene, è un volto che ha i tratti di un frate emiliano, il cui stile visionario dovette imporsi contro un’ostilità locale tanto tenace che, ancora in guide dell’Ottocento, di Guarini si parla con disagio, considerandolo un eccentrico barocco più che un artista vero.
Ci metteva dentro anche, anzi soprattutto, il Guarini, Davide Bertolotti che scriveva, nella sua Storia di Torino: «In una città sì ingombra di opere barocche, il purissimo stile del tempio della Gran Madre di Dio, al di là del Ponte di Pietra, è per l’amatore della bella architettura ciò che allo stanco viaggiatore è un’oasi in mezzo al deserto». A loro piaceva quell’imitazione del Pantheon, in scala ridotta e con la freddezza del neoclassico: tristissimo andarvi a messa. Anche se riconosco in quella chiesa, costata uno sproposito su quel terreno paludoso e retta da millecinquecento pali, uno straordinario oggetto di arredo urbano, con la grandiosa scenografia del grande fiume, del grande ponte e della grande piazza al di là. Un colpo d’occhio da vera capitale. Eppure, quando vi passo, non c’è volta che non mi venga da pensare alla folla di prigionieri spagnoli messi alla sferza da un Napoleone furibondo per l’indomabile resistenza iberica e costretti, come schiavi, a costruire le cinque arcate di quel ponte.
Comunque, contro l’ostilità dei «conoscitori d’arte», vinse il modenese, e ora guai a toccarglielo, ai torinesi. Guarini, del resto, era l’architetto giusto per loro, visto che in lui c’è un lato oscuro, inquietante. Il sacerdote e il costruttore convivevano con il cabalista, l’esoterista, il matematico che spesso e volentieri applicava i suoi calcoli alle arti astrologiche. Uomo di tecnologia e di occulto, di macchine e di tarocchi: che cosa di più subalpino? Quanto ai suoi mattoni, forse ha ragione Saverio Vertone spiegandone la fortuna presso i torinesi: «Rozze, cupe, disciplinate, le argille a vista nascondevano il fasto con il loro ascetismo». Insomma, un mix di esoterismo e di ipocrisia?
Ma fantasie e mani emiliane continueranno a plasmare il volto della capitale dei Savoia. Se il barocco piemontese è, soprattutto, Guarini, il neoclassico, qui, è sotto il segno del bolo...