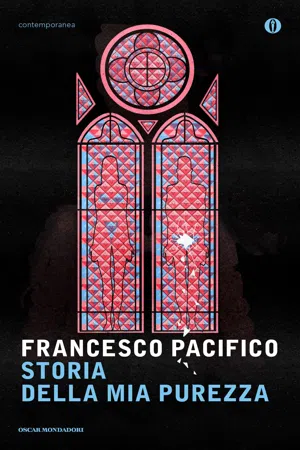![]()
Napoleone: nell’Ottocento i manicomi traboccavano di uomini convinti di essere l’imperatore della Francia libera. Si aggiravano, la testa coperta da goffi tricorni gualciti, dando ordini a truppe invisibili nei giardini all’inglese dei loro ospizi. Non sono stranezze, solo casi limite in una scala continua di comportamenti assolutamente normali per gli esseri umani. Tutti devono credere di essere qualcuno. Se non ci si dà una faccia, se non ci si colloca, qualunque azione diventa impossibile. A volte si esagera con le supposizioni e si finisce in manicomio, ma in generale non si può prescindere dall’immaginazione.
Per esempio, ero a casa dei miei, pranzo di Natale 2005, e dovevo chiedere un prestito a mio padre. Che genere di persona ero? Brin e Page, i creatori di Google; Julien Sorel; Donald Trump – uno che con un prestito di centomila euro può sollevare il mondo? O ero uno di quei figli di uomini di successo, la faccia gonfia di vacanze al mare, sorrisi da bambino sul corpo bitorzoluto di uomini incompiuti? Quei nobili che muoiono affogando in piscina, o i giovani Kennedy, i giovani Agnelli, coi vizi, i complessi? Perché mio padre era ricco. E nemmeno poi troppo, così era perfino un ricco felice, non aveva grossi doveri verso il mondo. E non solo era un ricco felice, ma era anche completamente padrone del suo destino, perché da giovane col suo ingegno aveva salvato il patrimonio del suocero e si era guadagnato una reputazione. Fine degli anni Settanta, la crisi del mercato dei mobili, imprenditori agguerriti sbucati dal nulla piazzavano mobili a prezzi irrisori. Mio padre vide arrivare la crisi e consigliò per tempo al suocero di darsela a gambe. Nonno allora fece un patto alla Gattopardo con dei nuovi commercianti di prodotti a buon mercato, diversificò, perse da una tasca ma gli rientrò nell’altra, riuscì a limitare i danni, e mio padre divenne Achille, Ettore, un eroe senza macchia.
Non a un altro: a quest’uomo affascinante e sicuro di sé dovevo chiedere un prestito, io che ero lo scialbore personificato. Un gran pancione tendeva la mia camicia azzurra di sartoria, la schiena ingobbita mi doleva, e come se non bastasse tenevo sempre lo sguardo a terra: mi avevano spiegato che Gesù nella scena dell’adultera da lapidare si siede e pungola il suolo con un dito per evitare lo sguardo della folla inferocita, e io lo imitavo quand’ero in pericolo. Tra la gobba e la pancia, mia moglie non provava più interesse per me e il mio corpo, il che mi rendeva impossibile avere fiducia in me stesso, e non provava il minimo interesse benché fossi alto e avessi spalle larghe da campione: su tutto vincevano le due pieghette stordite sotto le chiappe, eccessi di grasso, eccessi di rassegnazione fisica, e le mie cosce gonfiavano i pantaloni anche quel giorno di Natale che portavo il vestito del matrimonio. Perché un completo elegante al pranzo di Natale? Come tutti sapevano, visto che lo spiegavo a ogni occasione, io, che di regola vestivo sciatto – inverosimili maglioni con i rombi e pantaloni grigi a coste larghe –, per le feste del Signore indossavo il completo buono, affinché si capisse che solo del Signore mi importava, solo per Lui mi mettevo in ghingheri, e certo non per piacere alle donne. Con l’aria nervosa e contrita che non abbandonavo mai, specialmente in famiglia, dove insistevo per dire la preghiera prima di mangiare anche se tra noi non s’era mai fatto, con l’aria nervosa e contrita e il mio completo grigio da inglese, mi era impossibile farmi alleati al momento del bisogno. Un buon cristiano dovrebbe essere più accomodante, però mi dicevo: i tempi sono quelli che sono e con le buone la gente non lo capisce che il Signore è il loro pastore. La cosa mi addolorava sinceramente, tutti lo sapevano, mi giravano al largo, non mi facevano confidenze né ricevevo abbracci e carezze. Io cazziavo quanti avessero da ridire sulle esternazioni di papa Ratzinger; storcevo il naso se qualcuno faceva battute sporcaccione; in sostanza mi impegnavo a fondo, con i miei mezzi, per diventare santo: andatevele a leggere le vite dei santi, erano ossi duri.
Ora, anche un santo, nel chiedere un prestito a suo padre, deve decidere che genere di figlio è, se un figlio cazzuto, in gamba, o un bambolotto che vivrà all’ombra dei genitori e morirà molliccio. Per questo di solito i santi non chiedono prestiti ai genitori e scelgono la via della povertà. Ma io volevo cambiare lavoro. Dovevo per forza cambiare lavoro, stavo uscendo pazzo. Dovevo mollare il mio posto di redattore alla casa editrice cattolica Non Possumus e cercare un impiego più spensierato. Ma come giudicherete dalla conversazione in cui chiedo il denaro a papino, all’epoca avevo proprio il genere di lavoro che fa esclamare: “Hai voluto la bicicletta?”.
Ero un ragazzo difficile. E se siete persone difficili converrete che se a volte, agli altri, la vostra ostinazione pare un vezzo, essere difficili impedisce di vivere bene. Nel mio caso particolare, va aggiunto che prima della conversione fulminante che mi aveva accecato d’amore per Gesù, ero stato un bel ragazzo, e in molti trovavano antipaticissima la mia trasformazione volontaria in uomo bruttino e sulle sue. Avevo sempre avuto la pelle gialliccia di papà e dei miei fratelli, che ci vuoi fare, ma per il resto, un po’ le spalle, un po’ l’altezza e le gambe flessuose, un po’ la parlantina e il filosofare, un naso tra l’ebreo e il romano imperiale, prima di fidanzarmi con Alice avevo conosciuto ragazze quante ne volevo. Così ora si diceva in giro: “Ma come si è ridotto Piero Rosini? È diventato brutto e più antipatico di prima. Un filosofo da strapazzo già lo era, ma adesso mai una battuta, mai una leggerezza”. Smettevano di telefonarmi. E io pensavo: Beati coloro che sono perseguitati per causa Sua.
In attesa di trovare il coraggio di avvicinare papà ero rimasto alla tavola imbandita. Gli altri si erano già trasferiti in salotto e ce li avevo alle spalle. Le due grandi stanze adiacenti e diseguali erano separate da un paio di corti tramezzi che le presentavano una all’altra come palcoscenici speculari. Su un palco c’ero io, in questa bella scena da Harold Pinter: i polsi della camicia adagiati sulle briciole nel campo di battaglia di lino bianco, la tovaglia con i ricami in filo d’oro cosparsa di piattini strisciati di crema chantilly e scampoli di pangiallo e parrozzo, la schiena curva; e di fronte a me un nipotino di cinque anni in gilet rosso e camicia a righe bianche e blu con gli angoli del colletto sbottonati e stropicciati, i sottili capelli castani con la riga da una parte, rapito dal compito di riempire un foglio di Q maiuscole e minuscole alternate. E da quel personaggio che sono, forse qualcuno dei miei parenti aveva capito – per esempio mia moglie – che ero rimasto lì per dispetto. Non mi andava giù che mio padre avesse dato il rompete le righe prima del caffè, prima che mamma si alzasse per andare ad accendere la moka elettrica, solo per coprire gli affari loschi di Carlo, il mio fratello maggiore. Il quale, mentre addentava una fetta sbriciolosa di parrozzo, aveva ricevuto sul cellulare prima uno squillo, poi a distanza di pochi secondi un altro, ma prolungato; aveva controllato il display e dopo un secondo di esitazione, sopracciglia inarcate, alzandosi nel rispondere con un «Ehilà!» era sparito dalla stanza, lasciando il golfino color aragosta sullo schienale della sedia imbottita. Era un’amante, sicuramente. E papà, solidale con i figli, specialmente i primi due, Carlo e Fausto, che hanno sempre viaggiato con lui per lavoro e chissà quante ne avranno combinate insieme (non lo saprò mai), aveva comandato: «Ci spostiamo in salotto? Il caffè, mamma, ce lo porti di là?». Mamma si era alzata dicendo: «Quanti?». Papà grande e grosso era scemato via con passo da grizzly trascinando le pantofole di pelle; atterrato sulla poltrona di velluto verde acqua aveva chiesto le sigarette, che mamma gli aveva portato nel giro di poco.
Un pranzo di Natale non può essere interrotto da un’amante. Io rimanevo al tavolo con il mio nipotino – «Zio, quante parole conosci con la Q?», «Quante è con la Q», «Eh, sì, quante ne conosci?», «Quante è una parola con la Q», «Eeeh?» – e in mezzo a noi aleggiava fra piattini bicchieri e posate la memoria delle linguine all’astice, del rombo gigante sepolto nelle patate tagliate sottili, i gamberetti in salsa rosa e tutto quel vino piemontese e pugliese con cui ci eravamo storditi conversando di A.S. Roma, buche nell’asfalto, marche di scooteroni e lunghezza delle sciarpe.
Mio padre a quell’ora doveva essere sazio di cuore: già dimenticato con praticità l’incidente della telefonata, mi stava alle spalle felice del pranzo riuscito. Che gli importava, a lui, se due delle tre nuore soffrivano e scalfivano gli stipiti delle porte con le corna? Se aveva cresciuto due figli maggiori (i minori, vale a dire io e mia sorella, eravamo una creazione di mamma) come due mediocri accumulatori di piaceri, privi di afflati, schiavi dei bisogni materiali? Tanto a pagare il conto sarebbero stati i nipotini, figli di madri e padri che non si amavano alla luce della Croce.
Come vedete, la mia mente sregolata trasformava i volti più familiari, equamente, in brutti ceffi e povere vittime, e le case più note in deserti inospitali dove mi sentivo alla mercé del diavolo tentatore. Immagini che possono andar bene a Gesù di Nazareth nel momento in cui il diavolo se lo porta su al monte per offrirgli le ricchezze del mondo: per lui davvero la realtà è sinistra e minacciosa. Ma io? Io avevo bisogno di soldi, ed è difficile chiedere denaro a uno che ti sembra il diavolo in persona.
Sì, pensavo mio padre lo fosse. L’ultimo dei diavoli, come Al Pacino in Donnie Brasco è l’ultimo dei mafiosi, ma sempre uno della gerarchia, un tirapiedi del Male. Perché aveva tradito mia madre (io so anche se non ho le prove), perché non approvava la mia piega religiosa ultrapapista, perché da quando volevo diventare un santo moderno, un martire intellettuale, non sapeva più come prendermi, letteralmente come parlarmi.
Da un altro punto di vista, era solo un vecchio, un vecchio svenevole, facile al pianto, che altro non voleva dalla vita se non godersi la sua famiglia acciambellata intorno alla tavola per un pranzo di quattro portate, e dopo, con in mano una Camel superleggera a dirigere l’orchestra, vedere i nipotini scorrazzare sui tappeti, sbucare da una porta e imboccare subito l’altra, fare il diavolo a quattro mentre le tre belle nuore e la figlia Federica, vestali della religione familiare, conversavano a due a due felicemente.
E questa era la scena dell’altra ribalta, che voltandomi con in mano una fetta di panettone vidi in un colpo d’occhio. Il salotto color zabaione, la carta da parati a righine; Carlo e Fausto affacciati in terrazzo a fumare con dietro la pioggia e i pini che sgrullavano sul viale, in maniche di camicia Carlo, maglione verde pisello misto cachemire Fausto; le loro mogli vestite di nero con la collana di perle, su un divanetto di raso, le tazzine di caffè in mano; i tre bambini, una femmina e due maschi (quello delle Q mi aveva poi disertato per raggiungere i cugini), che scappavano e poi tornavano dalle madri strapazzando un camion di plastica dei pompieri. Su due poltroncine, mia sorella Federica e Alice, mia moglie, diverse dalle nuore in nero: le calze arancione squillante di Alice, le sue mani gesticolanti da amica di vecchia data; e accostati all’arancione (le loro gambe vicine si sfioravano), i tre colori a righe spesse delle calze di Federica, spalle tonde, vestito di lana marrone al ginocchio, coprispalle d’angora azzurro ghiaccio, animaletto dolce e conturbante con molte rughe – all’epoca aveva trentasei anni, sette più di me. Restavano: mamma dietro le quinte, in cucina, macchinista del caffè destinata a comparire ogni due minuti col vassoio per servire tutti; e al centro della scena mio padre in poltrona, che incrociò il mio sguardo mentre scostava un braccio dal corpo per accendere la lampada di un tavolino. Con la luce, la carta da parati gialla a righine si ossidò di colpo, quasi ispessita; fuori la pioggia rada sporcava i cornicioni e faceva il solletico ai vetri. Bucando la quarta parete mi andai a sedere nel loro spettacolo, il mio completo grigio in quel composito casino alla De Filippo faceva di me l’intruso da colpo di scena, un funzionario, un beccamorto, l’ambasciatore di notizie nefaste.
«Senti, papà, vorrei parlare di lavoro.»
«Con me? Quale onore.» Si era sfilato le pantofole e picchiettava una sigaretta sul portasigari d’argento. La mise in bocca, accarezzò gli sparuti capelli bianchi sopra le orecchie. Avvolto nel cardigan blu come un lottatore di sumo, alto e con la grande pancia. Il suo cardigan mi ricordava l’infanzia: a cinquant’anni lo portava sotto la giacca nelle cene con certi socialisti di monte Mario appassionati di basket e barche a vela.
Accende la sigaretta, quindi soffia fumo e si distende; poi con una mano raccoglie a sé il nipotino più grande che passa di lì, gli dice: «Vacci a prendere una sedia, amore di nonno». Lanciato uno sguardo sprezzante al cugino e alla sorella, corre in sala da pranzo, dove comincia a trafficare con una sedia come fosse un operaio in un cantiere navale. Gli vado incontro, prendo la sedia, il nipotino guarda il nonno che, sigaretta in bocca, infila la mano in una tasca del cardigan e tira fuori cinquanta centesimi. Il bambino corre nella mano del nonno, afferra il doblone dorato poi scappa di là, in un’altra stanza, seguito dagli altri due nanetti, sbalorditi all’apparire dei soldi.
«Allora, che mi dici? Vuoi fumare?»
«No, non fumo, no.»
«Come non fumi? Pensavo di sì.»
Non mi piaceva vederlo fumare, succhiava le sigarette come ostriche. «Volevo dirti che, dirti del mio lavoro. Volevo dirti. In pratica sto cominciando a guardarmi intorno, e volevo...»
«Certo, chiaro. Giustamente.»
«Giustamente?»
«Guarda, Fede secondo me ti tiene d’occhio» si sporse a confidarmi con aria saputa; la brace sgargiante della sigaretta, un anello prezioso. «Secondo me Fede sta cercando di capire come lavori in quella tua casa editrice... sbicchierata... e appena vede che ti sei fatto un’esperienza, ti presenta alla gente seria, capito? Questione di mesi, direi.»
Mia sorella Federica era una scrittrice, pubblicava per una grande casa editrice; il piano originario, quando eravamo ancora molto legati, era che introducesse anche me nell’editoria: prima che le Sacre Scritture la spazzassero via, la letteratura era la mia vita. Mio padre si era perso questo passaggio e ascoltava solo ciò che voleva; come sono spesso i vincenti, su alcuni dettagli era ingenuo perché guardava solo avanti; nel linguaggio manageriale anglosassone che aveva fatto suo di buon grado, un problema era un’opportunità. Papà era un esaltato.
«Tu sai benissimo» spiegò «che prima di affidare incarichi pagati ai tuoi fratelli li ho fatti sfacchinare gratuitamente finché non cacciavano fuori le palle. Fede fa lo stesso con te, ti aspetta.»
Io e Federica non parlavamo più. Fede frequentava uomini sposati, scriveva di clitoridi e cenacoli teatrali; mi considerava un bigotto. Il bigotto e la mignotta, così era finita la nostra alleanza letteraria. Mamma ci aveva lavorato fin da quando eravamo piccoli perché diventassimo migliori di Carlo e Fausto, della cui educazione troppo borghese e tendente al lato paterno (tennis, calcetto, fidanzate parioline, poche letture) si era pentita. Federica, capolavoro pedagogico, era arrivata dove mamma sperava, a fare la scrittrice abbastanza famosa: giornali, cataloghi d’arte, romanzi con tramonti dell’Occidente e organi genitali grondanti. Chissà che avevano da dirsi lei e mia moglie tutte le volte.
«Lascia perdere Fede, papà. Volevo dirti un’idea. Innanzitutto, la casa editrice: non condivido molto la linea editoriale recente.»
«Solo quella recente?» Gli veniva da ridere, ma con tatto me lo risparmiava.
Questo mi scocciava confessarglielo, ma i soldi sono soldi: «Si stanno andando a chiudere nella paranoia pura. Non so nemmeno più...