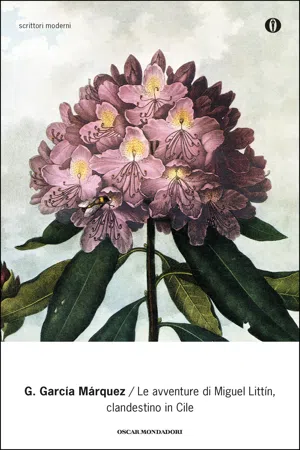Il volo Ladeco 115, proveniente da Asunción (Paraguay), stava per atterrare, con più di un’ora di ritardo, all’aeroporto di Santiago del Cile. Sulla sinistra, a quasi 7.000 metri d’altezza, l’Aconcagua sembrava un promontorio di acciaio sotto lo splendore della luna. L’aereo si inclinò sull’ala sinistra con una grazia da metter paura, poi si raddrizzò con uno scricchiolio di metalli lugubri, e toccò terra prima del tempo con tre salti da canguro. Io, Miguel Littín, figlio di Hernán e Cristina, regista cinematografico e uno dei 5.000 cileni con proibizione assoluta di ritornare, ero di nuovo nel mio paese dopo 12 anni di esilio, anche se ancora esiliato dentro me stesso: portavo con me una identità falsa, un passaporto falso, e perfino una moglie falsa. La mia faccia e il mio aspetto erano così cambiati dagli abiti e dal trucco che neanche mia madre mi avrebbe riconosciuto in piena luce qualche giorno dopo.
Pochissime persone al mondo erano a conoscenza di questo segreto, e una di esse viaggiava sul mio stesso aereo. Era Elena, una militante della resistenza cilena, giovane e molto attraente, designata dalla sua organizzazione per tenere i rapporti con la rete clandestina interna, stabilire i contatti segreti, scegliere i luoghi adatti per gli incontri, valutare la situazione operativa, combinare gli appuntamenti, vegliare sulla nostra sicurezza. Nel caso che fossi stato scoperto dalla polizia, o che fossi scomparso, o che non avessi tenuto per più di 24 ore i contatti prestabiliti, lei avrebbe dovuto rendere pubblica la mia presenza in Cile per dare l’allarme internazionale. Anche se i nostri documenti non erano quelli tipici di marito e moglie, avevamo viaggiato da Madrid, per sette aeroporti di mezzo mondo, come se fossimo una coppia ben assortita. In questo ultimo tragitto di un’ora e mezzo di volo, però, avevamo deciso di sederci lontani e di sbarcare come se non ci conoscessimo. Lei sarebbe passata dal controllo di immigrazione dopo di me, per avvisare i suoi se avessi avuto qualche intoppo. Se tutto andava bene, saremmo tornati a essere due sposi di routine all’uscita dall’aeroporto.
Il nostro progetto era molto semplice sulla carta, ma in pratica implicava un grande rischio: si trattava di filmare un documentario clandestino sulla realtà cilena dopo 12 anni di dittatura militare. L’idea era un sogno che mi frullava per la testa da parecchio tempo, perché l’immagine del paese mi era svanita nelle nebbie della nostalgia, e per un uomo di cinema non esiste modo più sicuro per recuperare la patria perduta di tornare a filmarla dall’interno. Questo sogno si è fatto più impellente quando il governo cileno ha incominciato a pubblicare elenchi di esiliati a cui era permesso ritornare, e non ho trovato il mio nome in nessuno di questi. Più tardi ha raggiunto punte di disperazione quando venne pubblicato l’elenco dei 5.000 che non potevano tornare, e io ero uno di loro. Quando finalmente il progetto si concretizzò, quasi per caso e quando meno me l’aspettavo, era da più di due anni che avevo perso l’illusione di realizzarlo.
Fu nell’autunno del 1984, nella città basca di San Sebastián. Mi ero installato lì sei mesi prima con Ely e i nostri tre figli per fare un film a soggetto che, come tanti altri della storia segreta del cinema, era stato cancellato dai produttori quando mancava una settimana all’inizio delle riprese. Mi sono trovato senza vie d’uscita. Ma nel corso di una cena con amici in trattoria, durante il festival del cinema, ho riparlato del mio vecchio sogno. Sono stato ascoltato e commentato a tavola con manifesto interesse, non solo per la sua evidente portata politica ma anche come una beffa alla prepotenza di Pinochet. Ma a nessuno è venuto in mente che fosse qualcosa di più di una mera fantasia dell’esilio. All’alba, però, quando stavamo tornando a casa per le strade addormentate della città vecchia, il produttore italiano Luciano Balducci, che aveva appena parlato a tavola, mi prese per un braccio e mi allontanò dal gruppo in un modo che sembrava casuale.
«L’uomo di cui hai bisogno,» mi disse «ti sta aspettando a Parigi.»
Era vero. L’uomo di cui avevo bisogno ricopriva un’alta carica nella resistenza interna cilena, e il suo progetto differiva dal mio solo in qualche dettaglio formale. Un’unica chiacchierata di quattro ore con lui, nell’ambiente mondano della Coupole e con la partecipazione entusiastica di Luciano Balducci, ci bastò per trasformare in realtà una fantasia da me incubata, perfino nei suoi minimi particolari, nelle insonnie chimeriche dell’esilio.
Il primo passo era introdurre in Cile tre équipes cinematografiche: una italiana, una francese e una di qualsiasi altra nazionalità europea, ma con credenziali olandesi. Tutte legali, con permessi legittimi e con la normale protezione delle loro ambasciate. L’équipe italiana, diretta preferibilmente da una giornalista, avrebbe avuto come copertura la realizzazione di un documentario sull’immigrazione italiana in Cile, con enfasi speciale sull’opera di Joaquín Toesca, l’architetto che costruì il Palacio de La Moneda. Quella francese avrebbe dovuto farsi accreditare per girare un documentario ecologico sulla geografia cilena. La terza avrebbe fatto uno studio sugli ultimi terremoti. Nessuna delle équipes avrebbe dovuto sapere nulla dell’esistenza delle altre due. Nessuno dei loro componenti sarebbe stato al corrente di quello che in realtà si stava facendo, né di chi li dirigeva dall’ombra, salvo il responsabile di ogni équipe, che avrebbe dovuto essere un professionista conosciuto nel suo ambiente, con formazione politica e conscio dei suoi rischi. Fu la parte più facile, che risolsi con un breve viaggio nei paesi d’origine di ogni équipe. Tutte e tre, accreditate nel modo dovuto e con contratti in regola, erano già in Cile e aspettavano istruzioni la sera del mio arrivo.
In realtà, la cosa più difficile fu trasformarmi in un’altra persona. Il cambio di personalità è una lotta quotidiana in cui spesso ci si ribella contro la propria determinazione di cambiare e si vuole continuare a essere la stessa persona. Così, la difficoltà maggiore non fu l’apprendistato, come si potrebbe pensare, bensì la mia resistenza inconscia, sia ai mutamenti fisici che a quelli comportamentali. Dovevo rassegnarmi a smettere di essere l’uomo che ero sempre stato e trasformarmi in un altro molto diverso, insospettabile anche per la polizia repressiva che mi aveva costretto ad abbandonare il mio paese, e irriconoscibile persino per i miei stessi amici. Due psicologi e una truccatrice cinematografica, sotto la direzione di un esperto in operazioni speciali clandestine, distaccato dall’interno del Cile, ottennero il miracolo in poco meno di tre settimane, lottando instancabilmente contro la mia determinazione istintiva di continuare a essere quello che ero.
La prima cosa fu la barba. Non era solo il problema di radermi, ma quello di uscire dalla personalità che essa mi aveva creato. Me l’ero lasciata crescere molto giovane, quando stavo per fare il mio primo film, e poi l’avevo tagliata parecchie volte, ma non tornavo mai a girare senza di lei. Era come se la barba fosse inseparabile dalla mia identità di regista. Anche i miei zii l’avevano portata, cosa che contribuiva, certo, ad aumentare il mio affetto nei suoi confronti. Due anni fa, in Messico, me l’ero tagliata e non ero riuscito a imporre la mia nuova faccia né ai miei amici né alla mia famiglia, e tantomeno a me stesso. Tutti avevano l’impressione di avere a che fare con un intruso, ma continuavo a non farla crescere ancora perché credevo di vedermi più giovane. Fu Catalina, la mia figlia minore, a sollevarmi dai dubbi:
«Senza barba ti vedi più giovane,» mi disse «ma anche più brutto.»
Così, togliersela un’altra volta per entrare in Cile non era solo un problema di schiuma e di rasoio, ma un processo molto più profondo di spersonalizzazione. Me la tagliarono poco per volta, osservando i cambiamenti a ogni tappa, valutando gli effetti che avevano sul mio aspetto e sul mio carattere i diversi tagli, finché arrivammo raso pelle. Passarono diversi giorni prima che avessi il coraggio di guardarmi allo specchio.
Poi fu la volta dei capelli. I miei erano di un nero intenso, ereditati da una madre greca e da un padre palestinese, dal quale mi veniva anche la minaccia di una calvizie precoce. La prima cosa che fecero fu tingermeli castani chiari. Poi provarono diversi tipi di pettinatura, e conclusero di non andare contro la natura. Invece di dissimulare la calvizie, come si era pensato all’inizio, decisero di accentuarla, non solo con una pettinatura lisciata all’indietro, ma anche terminando con le pinzette le stragi depilatorie che gli anni avevano già iniziato.
Non sembra vero, ma esistono dei tocchi quasi impercettibili che possono cambiare la struttura della faccia. La mia, che è da luna piena anche con meno chili di quelli che avevo addosso allora, diventò più larga con la depilazione accentuata delle estremità delle sopracciglia. Curiosamente questo mi diede un aspetto più orientale di quello che ho per nascita, ma che avrebbe corrisposto di più alle mie origini. L’ultimo passo fu l’uso di lenti graduate, che i primi giorni mi avrebbero provocato un intenso mal di testa, che però mi cambiarono non solo la forma degli occhi, ma anche l’espressione dello sguardo.
La trasformazione del corpo fu più facile, ma mi costò uno sforzo mentale maggiore. Il cambiamento della faccia era, in effetti, una conseguenza del trucco, ma quello del corpo richiedeva un addestramento psicologico specifico e un maggior livello di concentrazione. Perché era lì dove dovevo assumere a fondo il mio cambiamento di classe. Al posto dei pantaloni da vaquero che usavo quasi sempre, e dei giacconi da cacciatore, dovevo usare e abituarmi a usare vestiti di stoffa inglese di grandi marche europee, camicie fatte su misura, scarpe scamosciate, cravatte italiane a fiori dipinti. Invece del mio accento da cileno campagnolo, rapido e tormentato, dovevo imparare una cadenza da uruguaiano ricco, che era la nazionalità più conveniente alla mia nuova identità. Dovevo imparare a ridere in modo meno caratteristico del mio, dovevo imparare a camminare piano, a usare le mani per essere più convincente nel dialogo, infine. Dovevo smettere di essere un regista cinematografico, povero e anticonformista come ero sempre stato, per trasformarmi in quello che meno avrei voluto essere a questo mondo: un borghese soddisfatto. O come diciamo noi cileni: un momio.
Nello stesso tempo in cui mi trasformavo in un altro, avevo progressivamente imparato a vivere con Elena in una casa del XIV Arrondissement di Parigi, sottoposto per la prima volta a un ordine stabilito a priori da qualcuno che non ero io stesso, e a una dieta da mendicante per perdere 10 degli 87 chili che pesavo. Non era casa mia, né assomigliava in nulla alla mia, ma doveva esserlo nella mia memoria, perché ci si cura di coltivare ricordi per evitare contraddizioni future. Fu una delle esperienze più strane della mia vita, perché ben presto mi accorsi che Elena era simpatica e seria anche nella vita privata, ma che mai avrei potuto vivere con lei. L’avevano scelta gli esperti per i suoi requisiti professionali e politici, e doveva obbligarmi a seguire un binario che non lasciava nessun margine all’ispirazione. Il mio carattere di libero creatore resisteva ad ammetterlo. Più tardi, quando tutto era andato bene, mi sarei accorto di non essere stato giusto con lei, forse perché in qualche modo inconscio l’identificavo col mondo del mio alter ego, in cui ero restio a inserirmi, pur sapendo che era una condizione di vita o di morte. Adesso, evocando quella strana esperienza, mi chiedo se dopotutto non eravamo una coppia perfetta: a malapena riuscivamo a sopportarci sotto lo stesso tetto.
Elena non aveva problemi d’identità. È cilena, anche se non ha vissuto in Cile in modo permanente da più di 15 anni, e non è mai stata esiliata né ricercata da nessuna polizia del mondo, così la sua copertura era perfetta. Aveva compiuto missioni politiche importanti in diversi paesi, e l’idea di fare un film clandestino le parve affascinante. Il problema difficile era il mio, perché la nazionalità che sembrò essere la più conveniente per motivi tecnici mi obbligava a imparare un carattere molto diverso dal mio e a inventarmi tutto un passato in un paese che non conoscevo. Tuttavia, prima della data prevista avevo imparato a girare subito la testa se qualcuno mi chiamava col mio nome falso, ed ero capace di rispondere alle domande più strane sulla città di Montevideo, sulle linee di autobus che dovevo prendere per tornare a casa, e perfino sulla vita dei miei compagni, di 25 anni fa, al Liceo numero 11 dell’Avenida Italia, a due isolati da un nuovo supermercato. L’unica cosa che dovevo evitare era ridere, perché la mia risata era così tipica che mi avrebbe denunciato nonostante il travestimento. Tanto che il responsabile della mia trasformazione mi avvertì, con tutta la drammaticità di cui fu capace: «Se ridi, sei un uomo morto». Tuttavia, una faccia di mattone incapace di un sorriso non sarebbe stato niente di strano in un pescecane internazionale dei grandi affari.
In quei giorni venne fuori un dubbio imprevisto sull’opportunità del progetto, per la dichiarazione di un nuovo stato d’assedio in Cile. La dittatura – ferita dal fiasco spettacolare dell’avventura economica della Scuola di Chicago – reagiva in quel modo di fronte all’azione unanime dell’opposizione, unita per la prima volta in un fronte comune. Nel maggio 1983 erano iniziate le prime proteste di strada, che si ripeterono nell’arco di tutto l’anno con un’agguerrita partecipazione giovanile, soprattutto femminile, ma anche con una repressione sanguinosa.
Le forze dell’opposizione, legali e illegali, alle quali si sommavano per la prima volta i settori più progressisti della borghesia, proclamarono una fermata nazionale di un giorno. Fu una dimostrazione di potenza e determinazione sociali che esasperò la dittatura e accelerò lo stato d’assedio. Pinochet, disperato, lanciò un grido che risuonò nel mondo con toni operistici:
«Se continua così, dovremo fare un nuovo 11 settembre.»
Certo che quelle condizioni sembravano favorevoli a un film come il nostro, che intendeva far venire a galla anche gli elementi meno visibili della realtà interna, ma nello stesso tempo sarebbero stati molto più rigorosi i controlli polizieschi e più brutale la repressione, e il tempo utile sarebbe stato accorciato dal coprifuoco. Tuttavia, la resistenza interna valutò tutti gli aspetti della situazione e decise di andare avanti, così come lo volevo io. In modo che spiegammo le vele con mare buono e venti propizi alla data prevista.
La prima dura prova fu il giorno della partenza, all’aeroporto di Madrid. Era da più di un mese che non vedevo Ely e i nostri figli: la Pochi, Miguelito e Catalina. Non avevo neanche loro notizie dirette, e l’idea predominante fra i responsabili della mia sicurezza era che partissi senza avvisarli per evitare i danni degli addii. Anzi: all’inizio del progetto si era pensato che, per maggior tranquillità di tutti, fosse meglio che la mia famiglia ignorasse la verità, ma ci accorgemmo subito che era una cosa priva di senso. Anzi, nessuno poteva essere più utile di Ely per coprire la retroguardia. Muovendosi fra Madrid e Parigi, fra Parigi e Roma, e anche fino a Buenos Aires, era la persona meglio preparata per controllare il ricevimento e lo sviluppo del materiale che io avrei spedito poco per volta dall’interno, e anche per ottenere fondi supplementari se fosse stato il caso. E così fu.
D’altro canto, mia figlia Catalina aveva notato fin dai preparativi iniziali che nella mia stanza da letto si stava accumulando un tipo di nuovo vestiario completamente opposto al mio modo di vestire e anche al mio modo di essere, e fu tale il suo sconcerto e tanta la sua curiosità che non ebbi altro rimedio che riunirli tutti e metterli al corrente dei miei piani. Li presero con un senso di gioia e di complicità, come se all’improvviso si fossero trovati a vivere in uno di quei film che inventavamo di solito in famiglia per divertirci. Ma quando mi videro all’aeroporto, trasformato in un uruguaiano clericale che aveva ben poco a che vedere con me, tanto loro quanto io capimmo che quel film era un dramma della vita reale, tanto importante quanto pericoloso, che stava accadendo a tutti noi. La loro reazione, però, fu unanime.
«L’importante» mi dissero «è che tu metta a Pinochet una coda d’asino molto lunga.»
Si riferivano al noto gioco infantile in cui un bambino con gli occhi bendati deve mettere la coda nel posto appropriato a un asino di cartone.
«Promesso,» risposi, calcolando la lunghezza del film che mi accingevo a realizzare «sarà una coda di 7.000 metri.»
Una settimana dopo, Elena e io atterravamo a Santiago del Cile. Il viaggio, anche per ragioni tecniche, era stato una peregrinazione senza itinerario previsto per sette città d’Europa, perché via via mi abituassi a governare la mia nuova identità, spalleggiata da un passaporto insospettabile. Questo era in realtà un autentico passaporto uruguaiano, con il nome e tutti i dati del suo legittimo titolare, che ce lo aveva dato come contributo politico, ben sapendo che sarebbe stato manipolato e utilizzato per entrare in Cile. L’unica cosa che facemmo fu cambiare la sua fotografia con la mia, scattata dopo la mia trasformazione. Le mie cose vennero ordinate d’accordo con il nome del titolare: il monogramma ricamato sulle mie camicie, le iniziali della mia valigetta d’affari, la mia carta da lettere. Dopo parecchie ore di pratica avevo imparato a tracciare la sua firma senza incertezze. L’unica cosa che non fu possibile risolvere, dati i tempi stretti, furono le carte di credito, e questo fu un errore pericoloso, perché non era immaginabile che l’uomo che io fingevo di essere avesse comprato durante il tragitto diversi biglietti d’aereo pagando in contanti con dollari.
Nonostante le tante incompatibilità che nella vita reale ci avrebbero obbligato a divorziare dopo due giorni, Elena e io avevamo imparato a comportarci come una coppia capace di sopravvivere ai peggiori disastri domestici. Ognuno conosceva la falsa vita dell’altro, il suo falso passato, i suoi falsi gusti borghesi, e non credo che avremmo commesso un errore grave in un interrogatorio particolareggiato. La nostra storia era perfetta. Eravamo i dirigenti di un’agenzia di pubblicità con sede a Parigi, viaggiavamo con una équipe cinematografica per girare un film promozionale di un profumo nuovo che stava per essere lanciato nell’autunno successivo in Europa. Avevamo scelto il Cile perché era uno dei pochi paesi dove potevamo trovare in qualsiasi epoca dell’anno i paesaggi e l’ambiente delle quattro stagioni, dalle spiagge ardenti fino alle nevi perenni. Elena si muoveva con invidiabile disinvoltura nei suoi costosi vestiti europei, come se non fosse stata la stessa persona che mi avevano presentato a Parigi, con i capelli sciolti, la gonna scozzese e i mocassini da educanda. Anch’io mi credevo molto a mio agio nel mio nuovo guscio di imprenditore, finché non mi vidi riflesso in una vetrina dell’aeroporto di Madrid, con un vestito scuro spezzato, colletto duro e cravatta, e un’aria da squalo industriale che mi fece contorcere le budella. “Che orrore!” pensai. “Se non fossi io, sarei uguale a quello lì.” In quel momento, l’unica cosa che mi restava della mia vecchia identità era una copia mezzo sfasciata di Los pasos perdidos, il gran romanzo di Alejo Carpentier, che mi portavo nella valigetta come in tutti i viaggi da 15 anni per esorcizzare la mia paura incontrollabile di volare. Ciononostante, dovetti soffrire parecchi sportelli di immigrazione in diversi aeroporti del mondo per imparare a digerire il nervosismo del passaporto di un altro.
Il primo fu a Ginevra, e tutto andò in modo assolutamente normale, però so che non lo dimenticherò nel resto della mia vita, perché il funzionario dell’immigrazione controllò il passaporto con molta attenzione, quasi pagina per pagina, e alla fine mi guardò la faccia per confrontarla con la fotografia. Lo guardai negli occhi, senza respirare, nonostante la foto fosse l’...