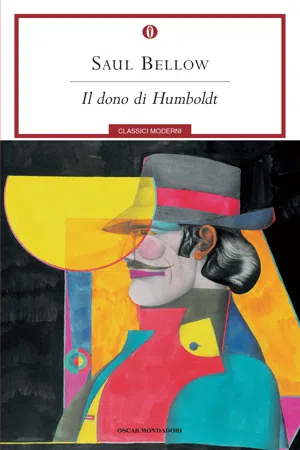![]()
Il libro di ballate pubblicato da Von Humboldt Fleisher negli anni Trenta riscosse un immediato successo. Humboldt era, appunto, colui che tutti quanti attendevano. Io per me l’aspettavo ardentemente, dal mio fondo di provincia nel Midwest, ve l’assicuro. Scrittore d’avanguardia, il primo della sua generazione, era bello, era biondo, grande e grosso, serio e insieme spiritoso, ed era colto. Insomma, aveva tutto. Nessun giornale mancò di recensire il suo libro. La sua foto comparve su «Time» senza ingiurie e su «Newsweek» con elogi. Io le lessi con trasporto, le Ballate di Arlecchino. Ero studente all’Università del Wisconsin e non pensavo ad altro, giorno e notte, che alla letteratura. Humboldt mi rivelò nuovi orizzonti, nuovi modi di fare. Andavo in estasi. Gli invidiavo il talento e la fortuna, invidiavo la sua fama. E a maggio me ne andai all’Est proprio per lui: contando di vederlo, magari di avvicinarlo. Il viaggio, in corriera, passando per Scranton, durò una cinquantina di ore. Che importava? Guardavo dal finestrino aperto: non avevo mai visto, prima, vere montagne. Gli alberi mettevano gemme e germogli. Pareva la Pastorale di Beethoven. Mi sentivo inondare di verde, dentro di me. Anche Manhattan mi andò subito a genio. Mi affittai una camera per tre dollari alla settimana, e trovai un lavoro: vendevo spazzole di porta in porta. Tutto quanto mi dava una selvaggia eccitazione. Siccome avevo scritto a Humboldt una lunga lettera, da ammiratore, venni presto invitato a casa sua, per conversare di letteratura, di altre cose elevate. Abitava in Bedford Street, nel Greenwich Village, poco lontano da Chumley’s. Mi offrì del caffè nero e, nella stessa tazza, versò pure del gin. «Mi hai l’aria di un bravo ragazzo, Charlie» mi disse. «Non sarai mica un furbacchione, alle volte? Mi sa tanto che diventerai presto calvo. E che occhi grandi che hai, belli, espressivi! Però senz’altro ami la letteratura, e questo è quel che più conta. Hai sensibilità» mi disse. Era un pioniere, nell’uso di quella parola. Di lì a poco “sensibilità” fece furore. Humboldt fu molto gentile con me. Mi fece conoscere gente del Village, mi procurò libri da recensire. Io gli ho sempre voluto molto bene.
Il successo di Humboldt durò circa dieci anni. Sullo scorcio degli anni Quaranta cominciò a declinare. All’inizio degli anni Cinquanta io divenni famoso a mia volta. Feci perfino un mucchio di quattrini. Ah, il denaro! i soldi! Humboldt me li rinfacciò sempre. Negli ultimi anni della sua vita, quando non era troppo depresso per parlare, e non era rinchiuso in manicomio, andava in giro per New York a dire male di me e del mio “milione di dollari”. «Prendiamo il caso di Charlie Citrine. È arrivato senza un soldo da Madison nel Wisconsin, è venuto a bussare alla mia porta. E adesso ha un milione di dollari. Come può uno scrittore, o un intellettuale, fare soldi a palate così? Un Keynes, d’accordo. Keynes... Un genio dell’economia, di statura mondiale, un principe di Bloomsbury» diceva Humboldt. «Sposato con una ballerina russa. Il denaro ne consegue. Ma chi diavolo è Citrine, per diventare ricco in questa maniera? Eravamo molto amici» soggiungeva, per l’esattezza. «Ma c’è qualcosa che non quadra, in quell’individuo. Dopo aver fatto la grana, perché è andato a seppellirsi in provincia? Che ci sta a fare, a Chicago? Ha paura che lo smascherino, ecco tutto.»
Quando aveva la mente abbastanza lucida, ce la metteva tutta a denigrarmi. E gli riusciva egregiamente.
Non è vero che io mirassi al denaro. Oh, Dio, no. Quel che volevo era riuscire a fare qualcosa di buono. Era questo che bramavo, da morire. Tale senso del bene risaliva ai miei verdi anni ed era tutt’uno col mio singolare concetto dell’esistenza stessa: come chi, immerso nelle cristalline profondità della vita, annaspando tentoni ricerchi, pieno di ebbrezza e disperazione, un significato, intensamente consapevole dei veli dipinti, di Maya, delle cupole di vetro istoriato tra noi e il radioso biancore dell’eternità, trepidante nell’intenso vuoto... e così via. Ero decisamente pazzo per queste cose. Humboldt lo capiva bene ma, verso la fine, non poteva più permettersi di offrirmi comprensione e simpatia. Malato e malevolo, non mi perdonava nulla. Seguitava a calcare sulla contraddizione fra i veli dipinti e il mucchio di quattrini. Ma il denaro che io facevo, in realtà si faceva da sé. Era il capitalismo stesso, a farlo, per oscure e comiche ragioni sue proprie. Era il mondo a fare quei soldi. L’altro ieri leggevo sul «Wall Street Journal», a proposito di benessere e malinconia: «Mai, nei cinque millenni della storia del mondo, tanti uomini furono tanto abbienti». Una mentalità formatasi in cinque millenni di penuria è per forza distorta. Il cuore mal sopporta codesti mutamenti. Certe volte li rifiuta, punto e basta.
Negli anni Venti, i monelli di Chicago cercavano tesori nel disgelo di marzo. Mucchi di neve sudicia bordavano le vie e, quando si scioglievano, un’acqua tersa e tortuosa correva nei rigagnoli, e lì potevi fare bottino di cose meravigliose: tappi di bottiglia, rotelline dentate, monete di rame. Ed ecco che la primavera scorsa, in là con gli anni ormai, mi sorpresi a camminare giù dal marciapiede cercando con gli occhi nel rigagnolo. Cosa? Che mi era preso? Ammettiamo che trovassi dieci centesimi. Che trovassi mezzo dollaro... E poi? Non lo so come fosse tornata, l’anima del fanciullo, fatto sta che era tornata. E tutto si scioglieva: ghiaccio, discrezione, maturità. Cosa ne avrebbe detto Humboldt?
Quando mi riferivano le sue maldicenze io, spesso, mi trovavo d’accordo con lui. «Hanno dato a Citrine il premio Pulitzer per il suo libro su Wilson e Tumulty. Il Pulitzer non conta, è roba buona solo per i polli. È un premio fasullo, pubblicità per i giornali, conferito da una giuria di analfabeti e farabutti. Tu diventi il loro cartello pubblicitario ambulante e, appena crepi, il necrologio comincia con: “È venuto a mancare un Premio Pulitzer”.» Non aveva torto, pensavo. «E Charlie ha vinto il premio Pulitzer due volte. La prima, per quella sua commedia allo sciroppo. Gli ha fruttato una fortuna, a Broadway. Più i diritti cinematografici. E una percentuale sugli incassi! Non dico che abbia commesso un vero e proprio plagio ma... ma qualcosa mi ha rubato, sissignori: la mia personalità. Si è servito di me per il suo personaggio.»
Anche qui, per madornale che sembrasse, l’accusa era forse fondata.
Era un conversatore meraviglioso, un improvvisatore frenetico, capace di monologhi fluviali, era un grande denigratore. Venire vilipesi da Humboldt era, in realtà, una sorta di privilegio. Come essere il soggetto di un ritratto con due nasi di Picasso, o una gallina sviscerata da Soutine. Il denaro lo ispirava, sempre. Gli piaceva un sacco parlare dei ricchi. Nutrito in gioventù di rotocalchi, gli capitava spesso di alludere agli scandali d’oro di ieri l’altro: Peaches e Daddy Browning, Harry Thaw ed Evelyn Nesbitt, e poi l’età del Jazz, Scott Fitzgerald e i super-ricchi. Le ereditiere di Henry James, lui le conosceva a fondo. C’erano stati momenti in cui anch’egli aveva brigato, comicamente, per fare fortuna. Ma la sua vera ricchezza era letteraria. Aveva letto migliaia di libri. La storia, diceva, è un incubo, durante il quale lui tentava di assicurarsi ogni notte qualche ora di sonno. L’insonnia lo rendeva più erudito. Durante le ore piccole, leggeva grossi tomi: Marx e Sombart, Toynbee, Rostovcev, Freud. Parlando di ricchezza, era in grado di fare raffronti fra il luxus dei romani e le dovizie dei protestanti d’America. In genere, andava a parare sugli ebrei: gli ebrei joyciani in cilindro davanti alla Borsa. E concludeva con il teschio ricoperto d’oro o la maschera mortuaria d’oro di Agamennone, riportata alla luce dallo Schliemann. Humboldt era proprio bravo a parlare.
Suo padre, ebreo immigrato dall’Ungheria, aveva partecipato alla spedizione del generale Pershing nel Chihuahua, per dare la caccia a Pancho Villa in un Messico di puttane e cavalli (quanto diverso da mio padre, piccolo e raffinato, alieno da cose simili). Il suo, ci si era tuffato a capofitto nell’America. Humboldt parlava di bivacchi, battaglie, bottini. In seguito vennero limousine, alberghi di lusso, ville in Florida. Suo padre aveva abitato a Chicago negli anni d’oro. Operava nel settore immobiliare e aveva un appartamento all’Edgewater Beach Hotel. D’estate, faceva venire il figlio presso di sé. Così Humboldt conobbe anche Chicago. Ai tempi di Hack Wilson e Woody English, i Fleisher avevano posti riservati in tribuna allo stadio Wrigley. Si recavano alla partita a bordo di una Pierce-Arrow o di una Hispano-Suiza (Humboldt andava pazzo per le automobili). E c’era allora il simpatico John Held junior, c’erano ragazze bellissime vestite alla maschietta. E whisky e gangster, e le banche di La Salle Street, adorne di colonne, scure come l’inferno, nei cui sotterranei blindati si conservava il denaro delle ferrovie, il denaro dei grandi agrari. Di questa Chicago io ero del tutto ignaro, quando ci arrivai da Appleton. Giocavo a softball con i ragazzini polacchi sotto i pilastri della Sopraelevata. Humboldt invece si pappava enormi torte a strati di cioccolato e cocco da Henrici. Io, da Henrici, non c’ero mai entrato nemmeno a dare un’occhiata.
Vidi invece, una volta, la madre di Humboldt nel suo buio appartamento di West End Avenue, a New York. Di viso, tal quale il figlio. Era muta, grassa, dalle labbra carnose, avvolta in una vestaglia. Aveva i capelli canuti, a cespuglio, da aborigena. Aveva il dorso delle mani maculato dalla melanina e, sulla faccia bruna, chiazze ancora più cupe, grandi quanto un occhio. Humboldt si chinò per parlarle all’orecchio, e lei non rispose nulla, ma il suo sguardo fisso nel vuoto esprimeva un imprecisato possente risentimento muliebre. Quando uscimmo, lui, tetro, mi disse: «Da ragazzo mi lasciava andare a Chicago, ma a patto che spiassi il vecchio. Voleva che copiassi per lei gli estratti conto della banca, che le passassi tutti i dati finanziari e anche i nomi delle sue donnine. Intendeva fargli causa. È matta, sai. Poi, invece, lui perdette ogni cosa nel tracollo. È morto di infarto, giù in Florida».
Questo, lo sfondo di quelle allegre, spiritose ballate. Era un maniaco-depressivo, lui (per sua stessa diagnosi). Possedeva l’opera omnia di Freud e leggeva riviste di psichiatria. Una volta che hai letto Psicopatologia della vita quotidiana sai che la vita quotidiana è psicopatologica. E Humboldt era pienamente d’accordo. Spesso mi citava, dal Re Lear: «Nelle città, sommosse; nelle nazioni, discordia; nei palazzi, il tradimento; e si è spezzato il vincolo fra padre e figlio...». Calcava su queste due parole. «Rovinosi disordini ci incalzano fin alla tomba, inquieti.»
Ebbene, era fin là che lo incalzarono rovinosi disordini, sette anni fa. E ora, quando uscivano nuove antologie, andavo alla Libreria Brentano a controllare. Le poesie di Humboldt non vi erano mai incluse. Questi bastardi, questi beccamorti e politicanti della letteratura, non sapevano che farsene del vecchio e “smesso” Humboldt. Quindi tutto il suo pensare, il suo scrivere e sentire non erano valsi a nulla; tutte quelle incursioni per catturare la bellezza non avevano sortito altro effetto che quello di logorarlo. Era morto d’un colpo in uno squallido alberguccio di Times Square. Io, scrittore d’altra sorta, ero sopravvissuto a piangerlo, nella prosperità, a Chicago.
La nobile idea di essere un poeta americano doveva certo far sentire Humboldt, a volte, come una specie di macchietta, di monello, di buffone, di matto. Vivevamo come bohémiens e goliardi, noialtri, in uno spirito di gioco e di allegria. Forse l’America non aveva bisogno di arte, di miracoli interiori. Ne aveva tanti, di quelli esteriori. Gli Stati Uniti erano una immensa impresa. Più contavano loro, meno contavamo noi. Quindi Humboldt viveva da eccentrico, da personaggio comico. Ma di tanto in tanto c’era una pausa, nella sua eccentricità, quando si fermava a riflettere. Cercava allora di districarsi mentalmente da quel mondo americano (e ci provavo anch’io). Humboldt si stillava il cervello per capire cosa bisognasse fare tra l’allora e l’adesso, tra la nascita e la morte, per risolvere certe grosse incognite. Tali rimuginii non giovavano alla sua salute mentale, tutt’altro. Tentò con la droga, col bere. Alla fine, dovette essere sottoposto a elettroshock. Era, ai suoi stessi occhi, la lotta di Humboldt contro la pazzia. La pazzia era un bel po’ più forte.
Nemmeno io me la cavavo tanto bene, ultimamente, allorché Humboldt si rifece vivo, per così dire, dall’oltretomba, foriero di grossi mutamenti nella mia vita. Nonostante i nostri dissapori e la ruggine di quindici anni, mi lasciava qualcosa nel suo testamento. Così, incappai in un’eredità.
Era uno di grande compagnia, ma stava uscendo di senno. Il lato patologico poteva sfuggire solo a chi, per il troppo ridere, non l’osservasse. Humboldt, questo grand’uomo bello e mutevole, dalla larga faccia bionda, quest’uomo affascinante e facondo e turbato nell’intimo, cui volevo tanto bene, viveva in maniera appassionata la commedia del Successo. Naturalmente, è morto in pieno Fallimento. Che altro risultato può ottenersi, a mettere in maiuscolo codesti nomi? Io, per me, ho sempre cercato di ridurre il numero delle parole sacre. Humboldt invece ne aveva una lista lunghissima: Poesia, Bellezza, Amore, Terra Desolata, Alienazione, Politica, Storia, Inconscio... E, s’intende, Mania Depressiva: sempre con la maiuscola. A sentir lui, il più grande Maniaco-Depressivo d’America fu Lincoln. E anche Churchill, con quei periodi che lui chiamava i suoi «Cani neri», era un classico caso di Mania Depressiva. «Come me, Charlie» mi diceva. «Ma pensaci su: se l’Energia è Gioia e se l’Esuberanza è Bellezza, il Maniaco-Depressivo la sa più lunga di chiunque altro, in fatto di Bellezza e di Gioia. Chi possiede più Energia, più Esuberanza di lui? Forse si tratta di uno stratagemma della Psiche per accrescere la Depressione. Freud non ha forse detto che la Felicità altro non è che una remissione del Dolore? Quindi, più Dolore si prova, più intensa sarà la Felicità. Ma l’origine è fors’anche più remota: la Psiche lo crea apposta, il Dolore. Sia come sia, l’Umanità rimane sbigottita di fronte all’Esuberanza e alla Bellezza di certi individui. Quando un Maniaco-Depressivo riesce a eludere le sue Erinni, diventa irresistibile. Diviene arbitro della Storia. Secondo me, il Dolore rappresenta una tecnica segreta dell’Inconscio. Quanto all’idea che i grandi e i re siano schiavi della Storia, qui, secondo me, Tolstoj si sbagliava. Non illuderti: i re sono i malati più sublimi. Gli eroi Maniaco-Depressivi trascinano l’Umanità dentro i loro cicli e ve la imprigionano.»
Il povero Humboldt non riuscì a imporre i suoi cicli per molto. Non divenne mai il centro radioso della propria epoca. La Depressione lo strinse nella sua morsa per sempre. I periodi di furori e poesia vennero a termine. Tre decenni dopo essere diventato famoso con le Ballate di Arlecchino un attacco cardiaco lo fulminò in un albergo pulcioso, una delle tanti succursali della Bowery nelle West Forties. A New York mi trovavo anch’io, per caso, quella sera. C’ero venuto per Affari: vale a dire, per loschi motivi. Nessuno dei miei Affari era meno che losco. Estraniatosi da tutti, abitava in un posto chiamato Ilscombe. In seguito ci andai a dare un’occhiata. Una specie di ospizio per vecchi. Era una notte di caldo atroce, quella in cui morì. Perfino al Plaza, dove alloggiavo io, si tribolava. L’aria in città era gravida di miasmi. I condizionatori alle finestre, pulsando, sgocciolavano sul capo dei passanti. Una nottataccia. L’indomani, sul 747 che mi riportava a Chicago, aprii il «Times» e vi trovai il necrologio di Humboldt.
Lo sapevo che Humboldt sarebbe morto presto perché, quando l’avevo visto l’ultima volta per strada, due mesi prima, gli avevo letto la morte sul viso. Lui non mi vide. Grigio, corpulento, malato, polveroso, aveva comprato una ciambella e la stava mangiando. Il suo pranzo. Nascosto dietro un’auto in sosta, lo spiai. Non gli andai incontro: sentivo che era impossibile. Una volta tanto, i miei Affari all’Est erano legittimi: non correvo dietro a qualche ragazza, ero là per un servizio giornalistico. Proprio quella mattina avevo sorvolato New York in un corteo di elicotteri della Guardia costiera, con i senatori Javits e Robert Kennedy. Poi avevo preso parte a un banchetto di politici, alla Tavern on the Green del Central Park, dove tutte le celebrità vanno in estasi l’una alla vista dell’altra. Ero anch’io, come suol dirsi, «in gran forma». Quando non ho una buona cera, ho l’aria disfatta, senza vie di mezzo. Ma quel giorno sapevo di avere un bell’aspetto. E avevo soldi in tasca. Avevo curiosato nelle vetrine di Madison Avenue: se una cravatta di Cardin o Hermès mi piaceva, potevo entrare e comprarla senza chiedere prima il prezzo. Non avevo un filo di pancetta, indossavo mutande di fil di Scozia da otto dollari il paio. Mi ero iscritto a un club atletico, a Chicago, e con sforzi attempati mi mantenevo in forma. Giocavo aspre e veloci partite di paddle ball, che è una specie di squash. E quindi, come potevo parlare con Humboldt? Era troppo, per me. Mentre io sorvolavo Manhattan, quel mattino, e contemplavo New York come si guarda una scogliera corallina da una barca con carena di vetro, forse lui rovistava fra barattoli e bottiglie, cercando qualche rimasuglio di succo di frutta da mischiare al suo gin, per colazione.
Dopo la morte di Humboldt, mi dedicai con impegno anche maggiore al culturismo. L’an...