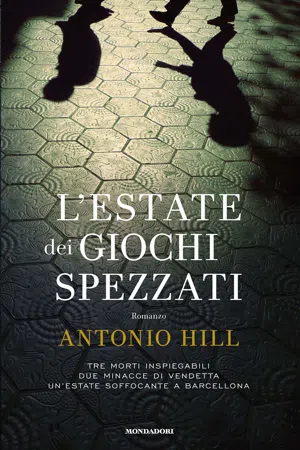![]()
Antonio Hill
L’ESTATE
DEI GIOCHI SPEZZATI
Traduzione di Elena Rolla
![]()
A mia madre, per tutto
![]()
![]()
È da molto tempo che non penso a Iris e all’estate in cui è morta. Credo di aver cercato di dimenticare tutto, proprio come ho superato gli incubi e le paure dell’infanzia. E adesso che voglio ricordare mi torna in mente soltanto l’ultimo giorno, come se quelle immagini avessero cancellato tutte le precedenti. Chiudo gli occhi e torno in quella vecchia e grande casa, nella camera con i letti vuoti che aspettano l’arrivo del prossimo gruppo di bambini. Ho sei anni, sono al campo estivo e non riesco a dormire perché ho paura. No, non è vero. Quella notte mi comportai da coraggioso: disobbedii alle regole e affrontai il buio soltanto per vedere Iris. Ma la trovai annegata. Galleggiava in piscina, circondata da una corte di bambole morte.
![]()
![]()
Spense la sveglia al primo squillo. Le otto del mattino. Benché avesse gli occhi aperti da ore, un’improvvisa fiacca si impossessò delle sue membra e dovette fare uno sforzo per alzarsi dal letto e infilarsi sotto la doccia. Il getto d’acqua fresca fece svanire l’intontimento, lavando via almeno in parte gli effetti del fuso orario. Era arrivato il pomeriggio precedente, dopo un interminabile volo Buenos Aires-Barcellona che si era ulteriormente prolungato all’ufficio bagagli smarriti dell’aeroporto. L’impiegata, che di certo in una vita precedente doveva essere stata una di quelle sadiche istitutrici britanniche, aveva esaurito le ultime scorte di pazienza guardandolo come se la valigia fosse un’entità dotata di volontà propria che aveva deciso di trovare un proprietario meno antipatico.
Si asciugò energicamente e notò con fastidio che il sudore cominciava di nuovo a imperlargli la fronte: l’estate a Barcellona era così, umida e appiccicosa come un gelato sciolto. Con l’asciugamano intorno ai fianchi, si guardò allo specchio. Avrebbe dovuto radersi. Vaffanculo. Tornò in camera e frugò nell’armadio mezzo vuoto alla ricerca di un paio di mutande. Per fortuna, la valigia che aveva perso conteneva vestiti invernali, perciò non ebbe problemi a trovare una camicia a maniche corte e un paio di pantaloni. Scalzo, si sedette sul letto. Fece un respiro profondo. Il peso del lungo viaggio si faceva sentire; fu tentato di tornarsene a dormire e dimenticare l’appuntamento delle dieci, ma in cuor suo sapeva di non esserne capace. Héctor Salgado non mancava mai un appuntamento. “Neanche fosse con il mio carnefice” si disse, accennando un sorriso ironico. Con la mano destra cercò il cellulare sul comodino. Era quasi scarico e gli venne in mente che il caricabatteria si trovava in quella maledetta valigia. Il giorno prima era troppo stanco per parlare con qualcuno, anche se in fondo aveva sperato che fossero gli altri a ricordarsi di lui. Cercò nella rubrica il numero di Ruth e rimase per qualche secondo a fissare il display prima di premere il tasto verde. La chiamava sempre al cellulare, sforzandosi di ignorare che lei aveva un altro numero fisso. Un’altra casa. Un’altra relazione. La sua voce, un po’ roca, gli sussurrò all’orecchio: «Héctor...».
«Ti ho svegliata?»
«No. Be’, in effetti...» Lui sentì sullo sfondo una risatina smorzata. «Ma dovevo comunque alzarmi. Quando sei arrivato?»
«Scusa. Sono arrivato ieri pomeriggio, ma quegli stronzi mi hanno perso la valigia e tenuto per mezza giornata all’aeroporto. Il cellulare sta per scaricarsi. Volevo solo farti sapere che sono arrivato bene.»
D’improvviso si sentì assurdo. Come un bambino che parla troppo.
«Com’è andato il viaggio?»
«Tranquillo» mentì. «Guillermo dorme ancora?»
Ruth scoppiò a ridere.
«Ogni volta che torni da Buenos Aires ti cambia l’accento. Guillermo non c’è, non te l’avevo detto? È andato qualche giorno al mare, a casa di un amico» rispose lei. «Ma probabilmente a quest’ora dorme» aggiunse subito dopo.
«Già.» Una pausa: negli ultimi tempi le loro conversazioni si inceppavano continuamente. «E come sta?»
«Lui bene, ma io ti giuro che se la preadolescenza dura ancora molto te lo rispedisco con corriere espresso.» Ruth sorrideva. Lui ricordava il suo sorriso e il fugace luccichio dei suoi occhi. Lei cambiò tono. «Héctor, senti, sai qualcosa di quella tua faccenda?»
«Devo incontrare Savall alle dieci.»
«Va bene, fammi sapere.»
Un’altra pausa.
«Pranziamo insieme?» Héctor aveva abbassato la voce. Ruth esitò un po’ più del necessario.
«Ho già un impegno, mi dispiace.» Per un attimo lui pensò che la batteria si fosse scaricata del tutto, ma poi la voce proseguì: «Però sentiamoci più tardi. Potremmo vederci per un caffè...».
Prima che riuscisse a rispondere il telefono si trasformò in un pezzo di metallo inerte. Lo guardò con odio. Poi gli occhi si posarono sui suoi piedi nudi. E con un balzo, come se la breve chiacchierata gli avesse dato l’impulso necessario, si alzò e andò di nuovo verso quell’armadio accusatore pieno di grucce vuote.
Héctor abitava al terzo e ultimo piano di un edificio del quartiere di Poblenou. Niente di speciale, uno dei tanti palazzi tipici della zona, vicino alla stazione della metropolitana e a un paio di isolati da quell’altra rambla che non compariva nelle guide turistiche. Gli unici pregi del suo appartamento riguardavano l’affitto, che non era aumentato quando la zona aveva raggiunto un certo prestigio grazie alla posizione privilegiata in riva al mare, e la terrazza sul tetto, che in pratica aveva tutta per sé perché il secondo piano era vuoto e al primo ci abitava la padrona di casa, una donna di quasi settant’anni che non aveva alcun interesse a salire tre rampe di scale. Lui e Ruth avevano risistemato la terrazza, coprendola in parte e mettendoci qualche pianta, adesso agonizzante, e un tavolo con delle sedie per cenare fuori nelle serate d’estate. Non c’era quasi più salito da quando Ruth se n’era andata.
La porta del primo piano si aprì proprio mentre ci passava davanti e Carmen, la proprietaria dell’edificio, uscì ad accoglierlo.
«Héctor.» Sorrideva. Come sempre, lui si disse che se fosse arrivato alla vecchiaia avrebbe voluto essere come quella brava donna. Anzi, meglio ancora, avrebbe voluto avere una come lei al suo fianco. Si fermò e le diede un bacio sulla guancia, un po’ goffamente. I gesti affettuosi non erano mai stati il suo forte. «Ieri ho sentito dei rumori di sopra, ma ho pensato che fossi stanco. Vuoi un caffè? L’ho appena fatto.»
«Lei mi vizia...»
«Sciocchezze» rispose lei decisa. «Gli uomini devono uscire di casa ben nutriti. Vieni in cucina.»
Héctor la seguì, obbediente. La casa profumava di caffè appena fatto.
«Mi mancava il suo caffè, Carmen.»
Lei lo guardò con le sopracciglia aggrottate mentre gli riempiva una tazza, aggiungendoci poi un goccio di latte e un cucchiaino di zucchero.
«Ben nutriti... e ben sbarbati» aggiunse la donna con intenzione.
«Non sia troppo dura con me, Carmen, sono appena arrivato» supplicò lui.
«E tu non fare la vittima. Come stai?» Lo guardò con affetto. «Com’è andata al tuo paese? Ah, fumati pure una sigaretta, so che ne hai voglia.»
«Lei è un tesoro, Carmen.» Tirò fuori il pacchetto di sigarette e se ne accese una. «Non capisco come mai nessun nonnetto danaroso abbia mai cercato di conquistarla.»
«Sarà perché i nonnetti non mi piacciono! Quando ho compiuto sessantacinque anni, mi sono guardata intorno e mi sono detta: Carmen, ja n’hi ha prou, chiudi bottega. Dedicati a guardare film a casa... A proposito, lì ci sono quelli che mi hai prestato. Li ho visti tutti» disse con orgoglio.
La collezione di film di Héctor avrebbe fatto impallidire d’invidia più di un appassionato cinefilo: dai classici di Hollywood, i prediletti di Carmen, alle ultime novità. Tutti sistemati su uno scaffale che andava da una parete all’altra, senza ordine apparente; uno dei suoi passatempi preferiti, nelle notti insonni, era tirarne fuori un paio a caso e sdraiarsi sul divano a guardarli.
«Meravigliosi» proseguì Carmen. Era una fan sfegatata di Grace Kelly, le avevano anche detto che da giovane le somigliava. «Ma non cercare di distrarmi. Come stai?»
Lui soffiò fuori lentamente il fumo e finì di bere il caffè. Lo sguardo della donna non concedeva tregua: quegli occhi azzurri dovevano aver fatto strage di uomini. Carmen non era di quelle vecchiette che adorano rievocare il passato, ma, grazie a Ruth, Héctor sapeva che c’erano stati almeno due mariti, “dimenticabili, poverini”, a detta della stessa Carmen, e un amante, “un mascalzone di quelli che non si dimenticano”. Ma alla fine era stato proprio quest’ultimo a garantirle una vecchiaia serena lasciandole in eredità quel palazzo di tre piani, in cui lei avrebbe potuto vivere ancora meglio se non avesse riservato un appartamento per un figlio che se n’era andato anni prima e non era più tornato.
Héctor si versò dell’altro caffè prima di rispondere.
«Non le sfugge niente, Carmen.» Cercò di sorridere, ma l’aria stanca e gli occhi tristi vanificarono i suoi sforzi. «Va tutto di merda, scusi l’espressione. Ormai è da parecchio che va tutto di merda.»
CASO 1231-R.
H. SALGADO.
INDAGINE IN CORSO.
Tre brevi righe scritte a pennarello nero su un post-it giallo appiccicato a una cartellina dello stesso colore. Per non vederle, il commissario capo Savall aprì la cartellina e ne sfogliò il contenuto. Come se non lo conoscesse a memoria. Dichiarazioni. Testimonianze. Certificati medici. Violenze da parte di un rappresentante delle forze dell’ordine. Fotografie delle ferite di quello stronzo. Fotografie della povera ragazzina nigeriana. Fotografie dell’appartamento al quartiere del Raval in cui tenevano stipate le ragazze. Perfino vari ritagli di giornale, alcuni – pochi, grazie a Dio – particolarmente accaniti, che raccontavano la loro versione dei fatti mettendo l’accento su concetti come ingiustizia, razzismo e abuso di potere. Savall chiuse la cartellina con una manata e guardò l’orologio sulla scrivania dell’ufficio. Le nove e dieci. Cinquanta minuti. Mentre spostava indietro la sedia per allungare le gambe qualcuno bussò alla porta e l’aprì senza attendere risposta.
«È arrivato?» si informò.
La donna che entrò nell’ufficio fece cenno di no con il capo senza chiedergli a chi si riferisse e, con estrema lentezza, posò entrambe le mani sullo schienale della sedia davanti alla scrivania. Guardandolo negli occhi, gli chiese a bruciapelo: «Cosa intendi dirgli?».
La domanda suonò come un’accusa, una raffica di colpi in tre parole.
Savall fece spallucce, quasi impercettibilmente.
«Come stanno le cose. Cosa vuoi che gli dica?»
«Ah. Geniale.»
«Martina...» Cercò di essere brusco, ma la stimava troppo per prendersela davvero con lei. Abbassò la voce. «Ho le mani legate, cazzo.»
Lei non si arrese. Scostò un po’ la sedia, si sedette e la riavvicinò alla scrivania.
«Non aspettano altro. Quel tizio è già uscito dall’ospedale. E adesso è a casa, come se niente fosse, a riorganizzare l’attività...»
«Non mi rompere, Martina!» Il sudore gli imperlò la fronte e per una volta perse le staffe. Quella mattina, alzandosi, si era imposto di non farlo. Ma era un essere umano. Aprì la cartellina, prese le foto e le dispose sulla scrivania come un poker d’assi. «Mandibola rotta. Due costole fratturate. Contusioni al cranio e all’addome. La faccia come un pallone. Tutto perché Héctor ha perso la testa e si è presentato a casa di quello stronzo. E gli è andata ancora bene, perché non ha riportato lesioni interne. Ma ci è andato davvero pesante.»
Lei lo sapeva. Sapeva anche che se fosse stata al suo posto avrebbe detto esattamente lo stesso. Ma se c’era un particolare che caratterizzava la viceispettrice Martina Andreu era la lealtà incrollabile verso i suoi: la famiglia, i colleghi, gli amici. Per lei il mondo si divideva in due fazioni ben distinte, i suoi e gli altri, ed Héctor Salgado faceva senz’altro parte del primo gruppo. Perciò, a voce alta e in tono deliberatamente sprezzante, un tono che irritava il suo capo ancora più della vista di quelle fotografie, replicò: «Perché non tiri fuori anche le altre? Quelle della ragazza. Perché non guardiamo cos’ha fatto quel maledetto stregone negro a quella povera ragazzina?».
Savall sospirò.
«Vacci piano con la parola “negro”.» Martina gli lanciò uno sguardo spazientito. «Ci manca solo questo. E le condizioni della ragazza non giustificano l’aggressione. Lo sai tu, lo so io e lo sa Héctor. Ma il guaio è che lo sa anche l’avvocato di quello stronzo.» Abbassò la voce, lavorava da anni con Andreu e si fidava di lei più di qualunque suo subordinato. «L’altro ieri è stato qui.»
Martina inarcò un sopracciglio.
«Sì, l’avvocato di... come diavolo si chiama. Gliele ho cantate chiare: o ritira la denuncia contro Salgado, o il suo assistito si ritroverà alle costole un agente che lo seguirà perfino quando va al cesso.»
«Quindi?» chiese lei, guardando il suo capo con rinnovato rispetto.
«Ha detto che ne avrebbe parlato con il suo cliente. Ho fatto di tutto per mettergli pressione. In via ufficiosa. Mi chiamerà stamattina, prima delle dieci.»
«E se accetta, cosa gli hai promesso in cambio?»
Savall non fece in tempo a rispondere. Il telefono sulla scrivania squillò come un allarme. Lui fece cenno alla viceispettrice di stare in silenzio e alzò il ricevitore.
«Pronto?» Per un attimo il suo volto rimase impassibile, ma subito dopo assunse un’aria infastidita. «No. No! Adesso sono impegnato. La richiamo più tardi.» Più che riattaccare, lasciò cadere la cornetta del telefono e aggiunse, rivolto alla viceispettrice: «Joana Vidal».
Lei sbuffò.
«Ancora?»
Il commissario alzò le spalle.
«Non ci sono novità sul suo caso, no?»
«Niente. Hai visto il rapporto? È chiaro come l’acqua. Il ragazzo si è distratto ed è caduto dalla finestra. Pura sfortuna.»
Savall annuì.
«Buon rapporto, fra l’altro. Molto completo. È di quella nuova, vero?»
«Sì. Gliel’ho fatto riscrivere, ma alla fine è venuto bene.» Martina sorrise. «Sembra una ragazza sveglia.»
Se ve...