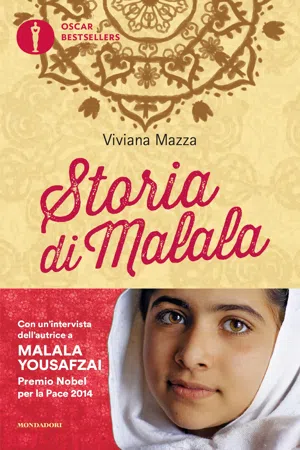“Dove sono?”
Malala ha appena aperto gli occhi.
Si guarda intorno.
È in un letto d’ospedale, su questo non c’è dubbio. La stanza ha le pareti celesti, e la finestra è coperta da una tenda a fiori dalle tinte tenui: azzurro, beige, marrone chiaro.
Muove lievemente le braccia e le gambe. Non prova più il dolore straziante di prima. C’è un’infermiera con la divisa azzurra, gli occhiali, i capelli biondi e ricci raccolti all’indietro. Sorride.
Malala vorrebbe chiederle dove si trova, ma non riesce a parlare, sente qualcosa in gola. Perde conoscenza.
Le sembra di assopirsi e risvegliarsi, non saprebbe dire se per pochi minuti oppure per ore.
In gola ha un tubo che l’aiuta a respirare, però le impedisce di parlare. È un medico a spiegarglielo, parlandole in urdu. È un tipo gentile. Le dà un foglio e una penna.
IN QUALE PAESE MI TROVO? scrive Malala.
— Sei in Inghilterra. A Birmingham. Al Queen Elizabeth Hospital.
DOVE SONO PAPÀ, LA MAMMA, I MIEI FRATELLI?
— In Pakistan, ma arriveranno presto.
CHE GIORNO È?
— Il 19 ottobre 2012.
Dieci giorni dopo l’attentato.
Malala se lo ricorda. Le immagini le scorrono davanti agli occhi: il compito in classe, lo scuolabus, gli orecchini di Laila, la strada polverosa, l’uomo con la pistola.
Le ha sparato. Ma lei è viva.
Quella mattina l’infermiera la aiuta ad alzarsi in piedi per la prima volta.
Malala riesce a reggersi sulle sue gambe, ma dopo pochi minuti è già spossata. La testa è pesante, la gola gonfia. Dall’orecchio sinistro non sente quasi niente. Si rimette a letto e l’infermiera le porge un orsacchiotto bianco con un fiocco rosa al collo. Malala lo stringe forte.
Conta almeno otto medici che passano a controllarla giorno dopo giorno. Chi le esamina il lato sinistro della testa: è lì che il proiettile deve averla colpita. Chi le guarda la gola: parlano di un’infezione.
Sul tavolino di legno rotondo, davanti alla tenda a fiori, c’è una montagna di lettere e di disegni che raffigurano il sole, gli alberi, palloncini e mongolfiere. Centinaia di messaggi. L’infermiera ne legge alcuni per lei.
“Cara Malala, spero che tu ti rimetta presto.”
“Malala, pensiamo tutti che sei una persona straordinaria.”
“Cara Malala, sei così coraggiosa, sei un esempio per tutti noi.”
“Malala, hai pagato un prezzo terribile. Ma hai svegliato il mondo.”
Le sembra incredibile che tanti uomini, donne e bambini di tutto il pianeta siano interessati alla sua salute. Dio deve aver ascoltato le loro preghiere: per questo l’ha salvata.
PER FAVORE, scrive su un foglietto che porge all’infermiera, RINGRAZIATE TUTTE QUESTE PERSONE A MIO NOME.
Anche se c’è sempre qualcuno con lei e non è mai sola, la sua famiglia le manca moltissimo. Ma come può parlare con loro, se non ha più la voce? Un giorno le portano il telefono.
— Malala? — È papà. E anche se lei non può rispondere, sentirlo di nuovo la riempie di emozioni.
Sulla parete accanto alla spalliera del letto c’è un foglio rosa con la scritta TODAY IS… Ogni lettera è di un colore diverso. Mattina dopo mattina, Malala osserva l’infermiera che scrive che giorno è. E dopo alcuni giorni, i medici rimuovono il tubo dalla sua gola: l’infezione è passata, e Malala può parlare di nuovo, può mangiare. Appoggiandosi al braccio dell’infermiera, riesce anche a camminare con una certa sicurezza.
— Papà — gli dice al telefono con un filo di voce. — Portami i libri quando vieni. Voglio prepararmi per gli esami. — E lo sente commuoversi dall’altro capo del filo.
Un giorno, i medici le hanno appena fatto tutti i controlli a vista e udito, è stesa sul letto a riposare, e finalmente li vede.
Il papà, la mamma, Atal e Khushal entrano nella stanza. E lei, nonostante la stanchezza, tenta di regalare loro un grande sorriso, ma sente che il lato sinistro della bocca non ha la forza di inarcarsi come il destro. I genitori e i fratelli scoppiano in lacrime. Lacrime di gioia. E per quasi un’ora papà non la smette di parlare, di gesticolare, di sorridere.
Atal, seduto al suo fianco, stringe l’orsacchiotto bianco. Dall’altra parte del letto, Khushal, che sembra un po’ nervoso, sta in silenzio accanto alla mamma, avvolta in un ampio velo beige. Malala fa fatica a girarsi. Guardando dritto davanti a sé, chiede alla mamma: — Come stanno Laila e Zakia?
— Sono rimaste ferite, ma si sentono molto meglio. Ho parlato con loro per telefono, e mi hanno chiesto di te. Non vedono l’ora di rivederti.
— Non sono le sole — aggiunge papà. — La scuola ha riaperto: il giorno dopo l’attacco metà delle ragazze erano assenti, ma il lunedì successivo, nella tua classe ne mancavano solo sei su trentuno.
Papà fa il conto delle presenze, proprio come ai vecchi tempi.
Passano le settimane e, ogni tanto, seduta al tavolino, con l’orsetto bianco sulle gambe, Malala si ritrova a fissare il vuoto.
Certe volte i bambini non riescono ad addormentarsi per paura dei mostri. Ma Malala i suoi mostri li conosce bene.
Nessuno è stato arrestato per avere tentato di ucciderla.
Un portavoce dei talebani ha rivendicato l’attentato e ha promesso che ci riproveranno: si mormora addirittura che Maulana Fazlullah in persona lo abbia ordinato. Anche se tutti i pashtun sanno che uccidere i bambini è un enorme disonore, la giustificazione dei talebani è che Malala diffonde idee occidentali contro l’Islam, è apparsa in TV truccata e ammira Obama.
Il governo ha identificato un sospetto di ventitré anni, ma il ragazzo si è volatilizzato.
— Ora devi pensare a diventare più forte — le dice papà quando la vede così pensierosa — in modo che i medici possano fare le ultime operazioni. Ripareranno anche il tuo orecchio sinistro — le promette. — Tornerai a sentire perfettamente, proprio come una volta.
Mentre il papà le legge i messaggi di solidarietà che continuano ad arrivare, Malala pensa alla prima foto che le hanno scattato in ospedale e che è stata pubblicata sui giornali.
In quell’immagine, lei giace sul letto con il volto gonfio, gli occhi cerchiati di ombre scure, un sondino nel naso, una sciarpa bianca appoggiata intorno alla testa: sembra proprio che stia per morire.
“Non accadrà più.” D’ora in poi, decide, si farà fotografare con un libro in mano e con un bel foulard a incorniciarle il viso e a nascondere le ferite.
Una sera papà le dice che uno dei giornalisti che l’aveva intervistata in TV è scampato per un pelo a una bomba piazzata sotto la sua auto. Malala gli telefona, si fa passare la figlia del giornalista, che ha diciassette anni.
— Hana, sono Malala. Ascoltami — le dice con voce ancora debole, ma sicura. — Capisco che quello che è successo è tragico, ma devi continuare a essere forte. Non puoi smettere di lottare.
Qualche giorno dopo, scopre che il governo ha dato il suo nome a una scuola di Mingora, ma gli studenti si sono ribellati perché non vogliono essere il prossimo bersaglio.
Ancora una volta prende il telefono, per dire la sua:
— Non voglio che gli studenti siano in pericolo per colpa mia. Per favore, restituite alla scuola il nome di prima, oppure sceglietene un altro che non sia il mio.
È ora di lasciare questa stanza d’ospedale. L’infermiera è venuta a prenderla. Tre mesi dopo l’attentato, Malala se ne va, non su una sedia a rotelle, ma sulle sue gambe.
Percorre il corridoio a piccoli passi, con la mano sinistra in quella dell’infermiera che l’accompagna, e salutando con la destra tutte quelle persone in camice che le sono state accanto, che l’hanno curata e guarita.
Arrivata davanti alla porta di legno, si ferma per un attimo, e si gira indietro a salutare anche la telecamera. Tutte le persone del mondo la vedranno, e capiranno. I talebani hanno cercato di toglierle la vita, invece l’hanno resa più forte.